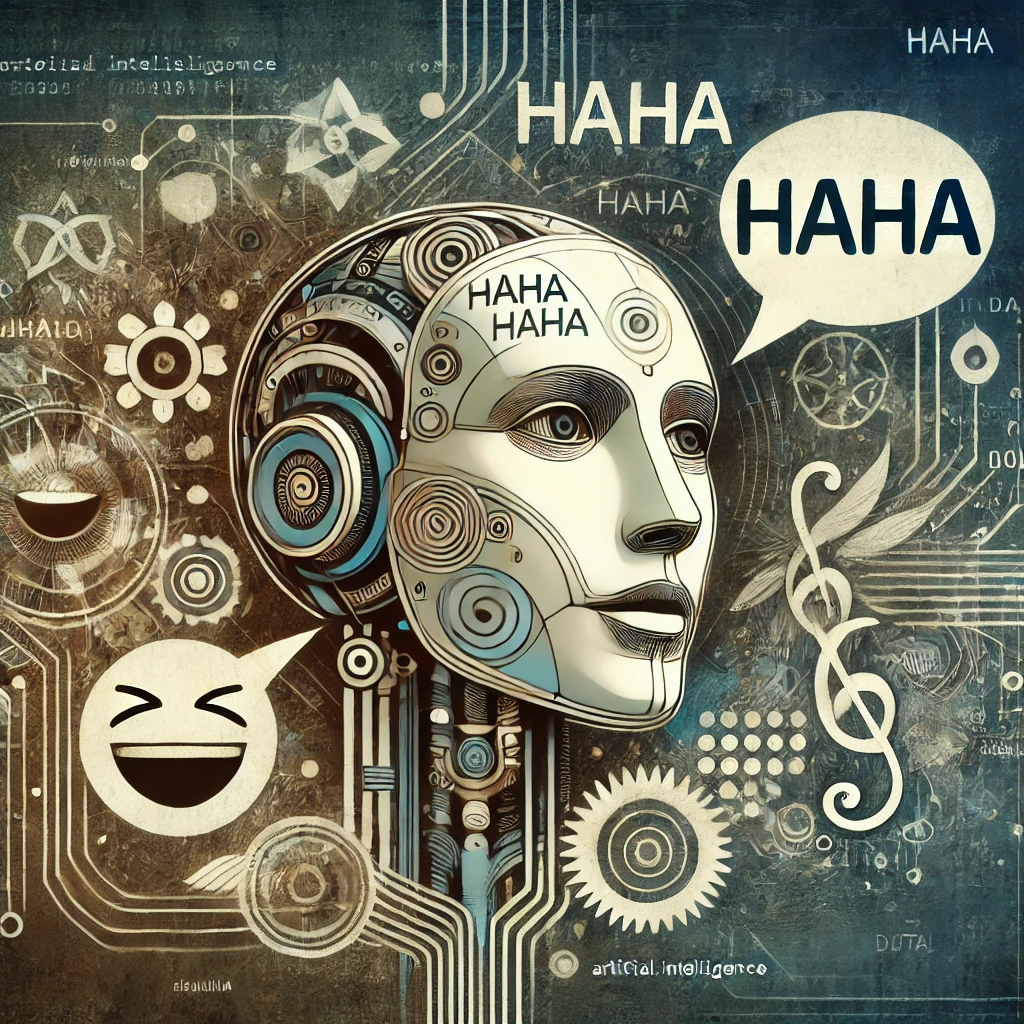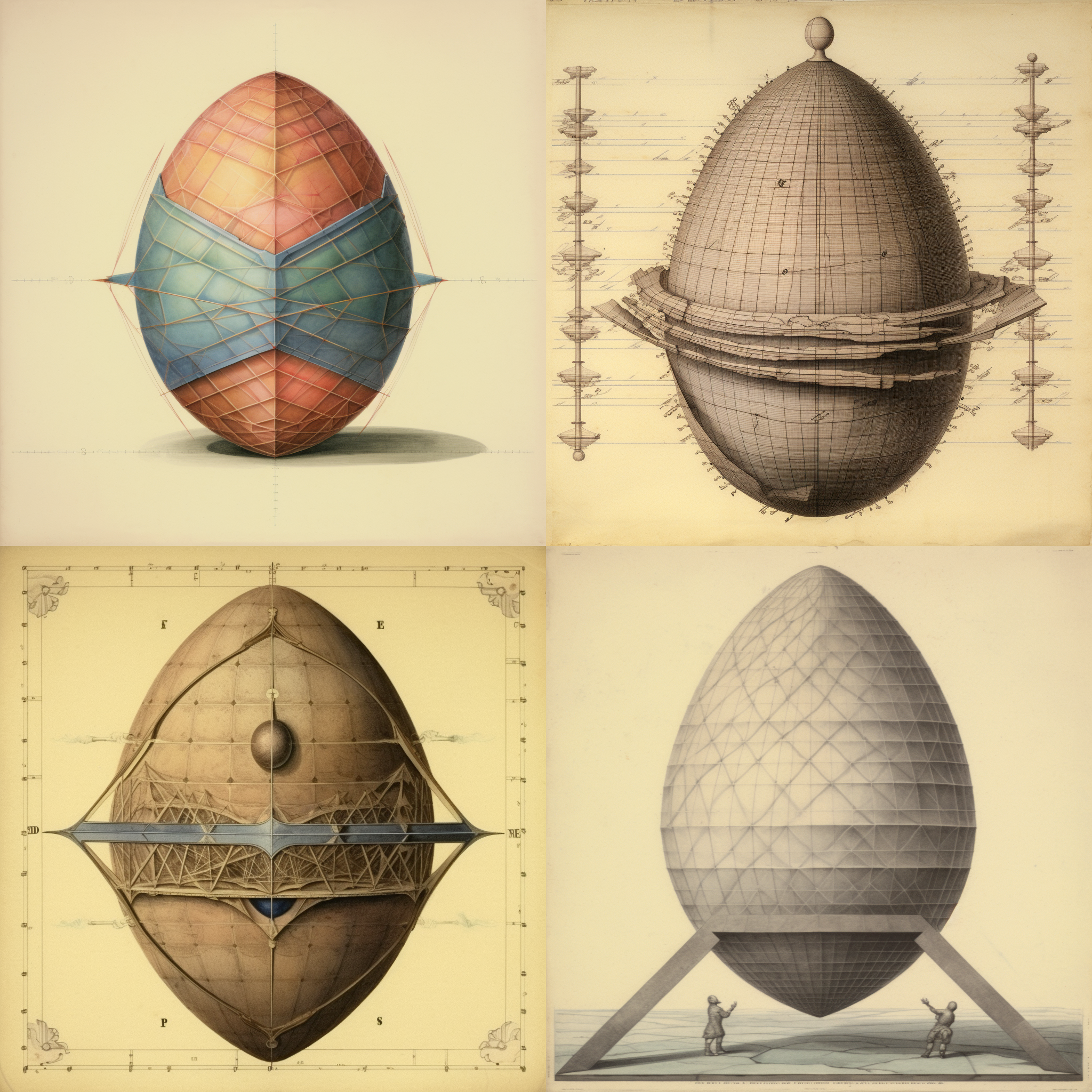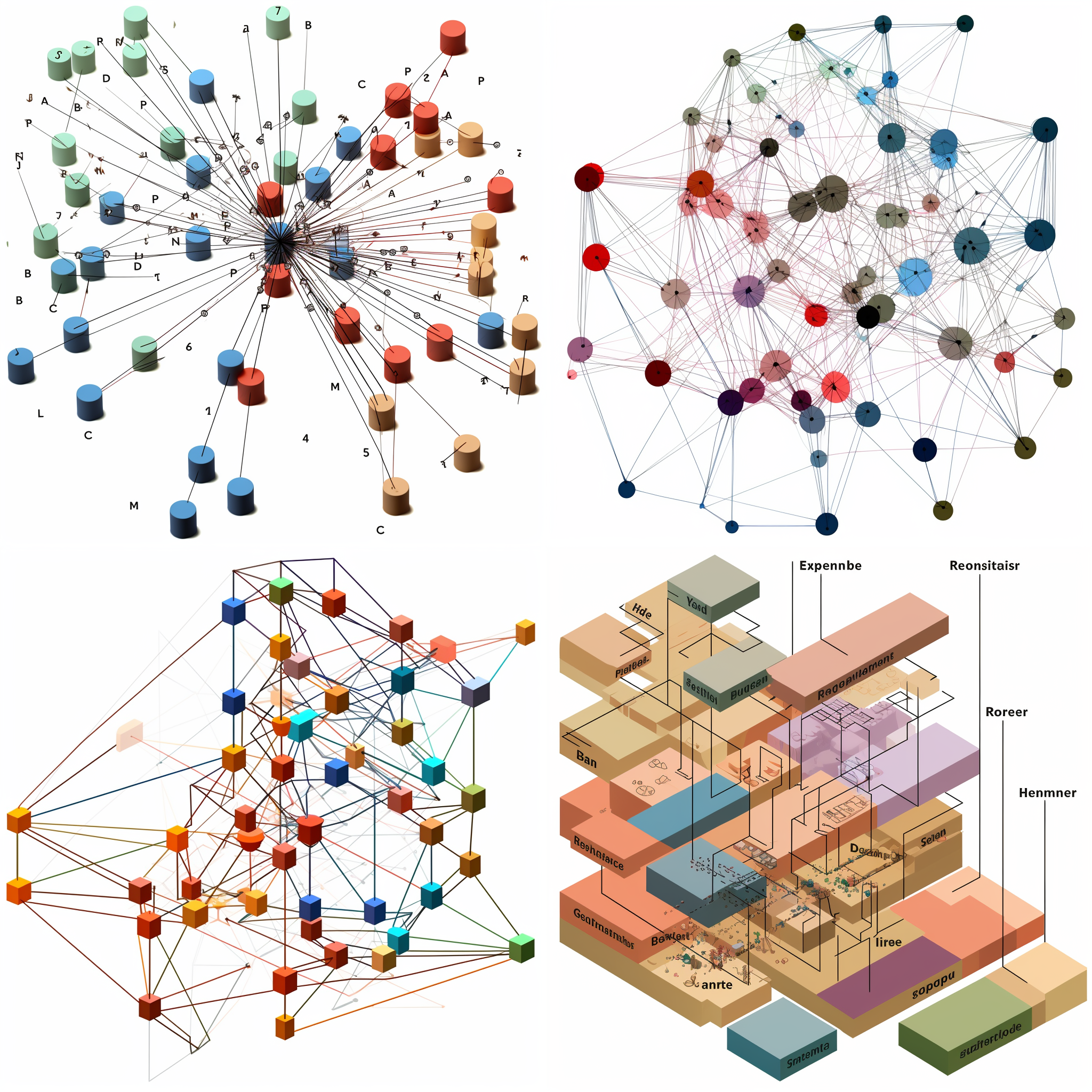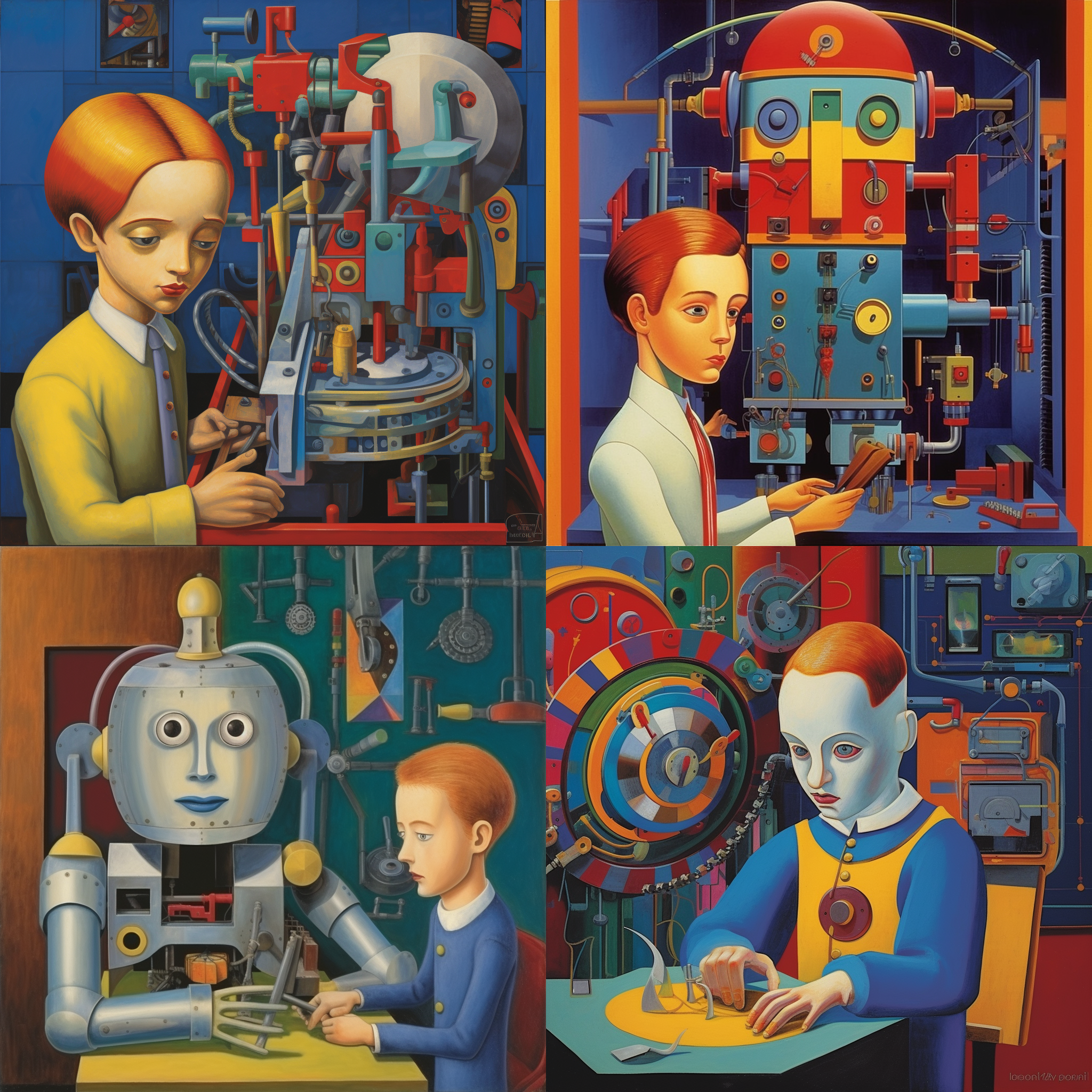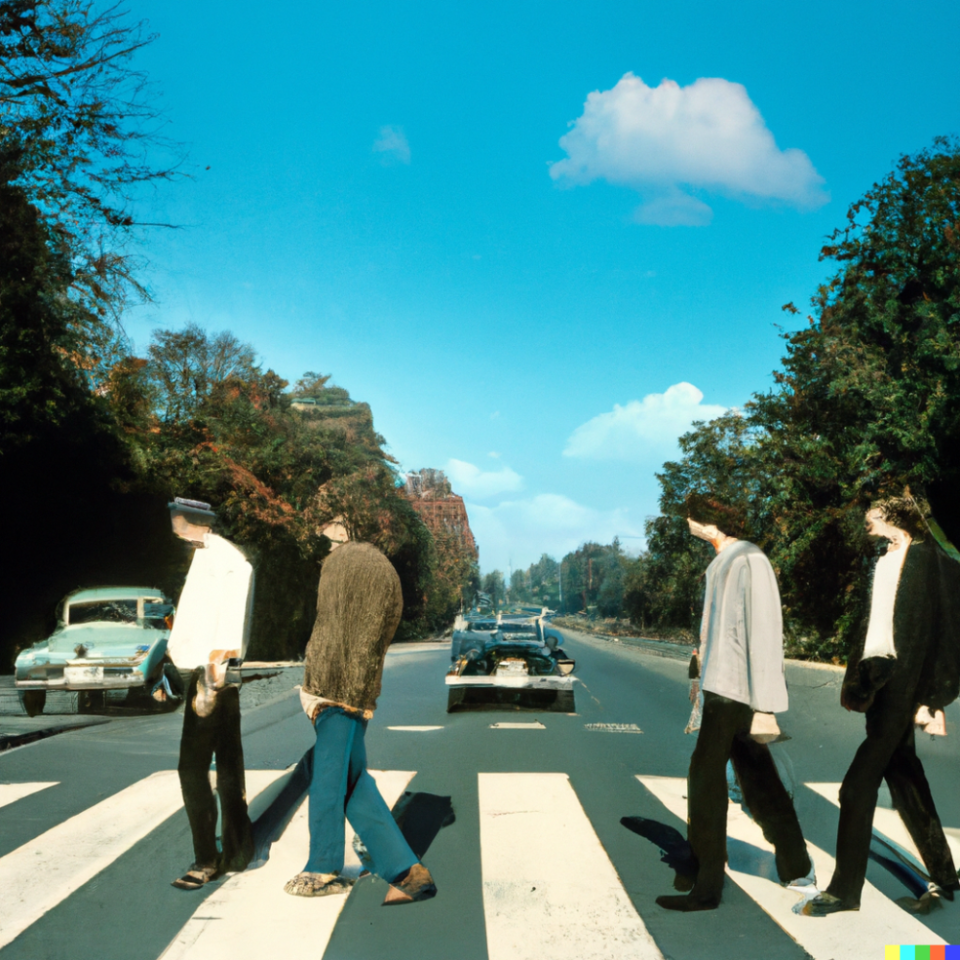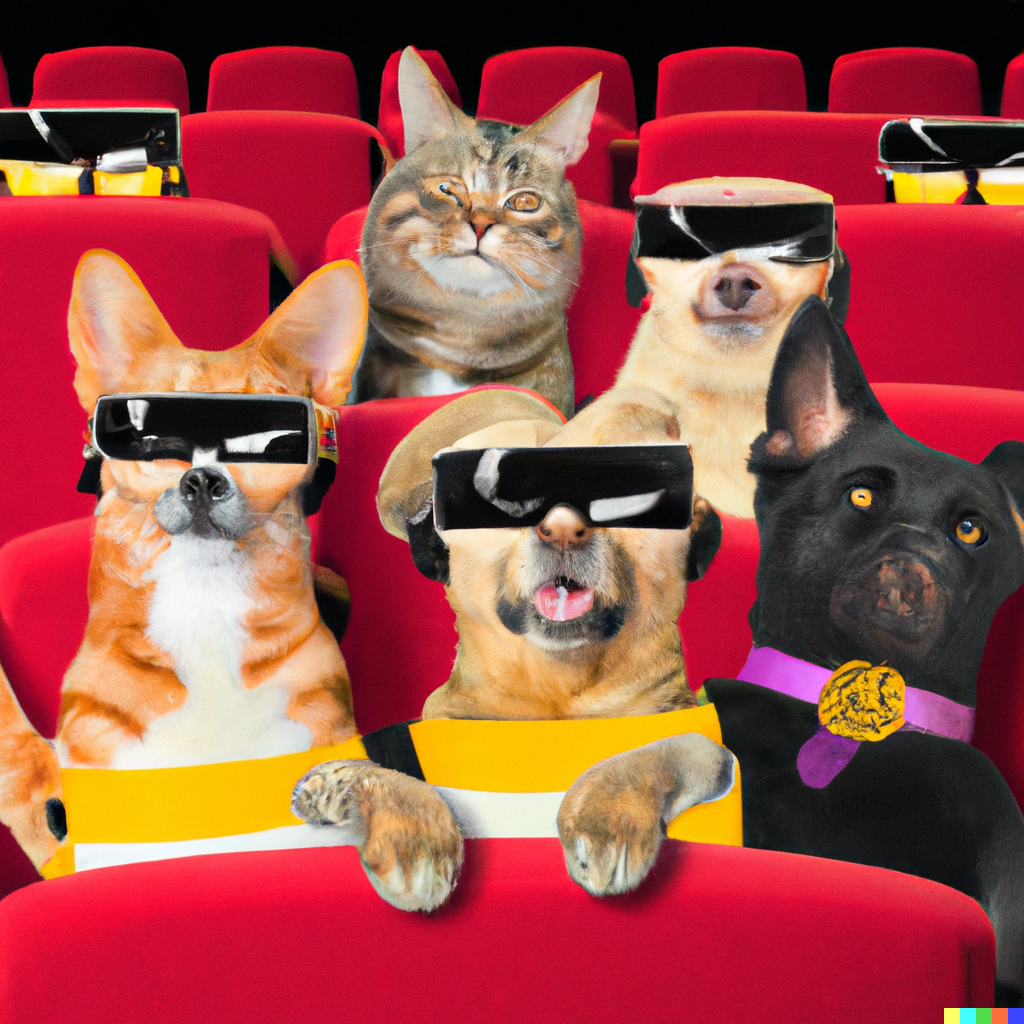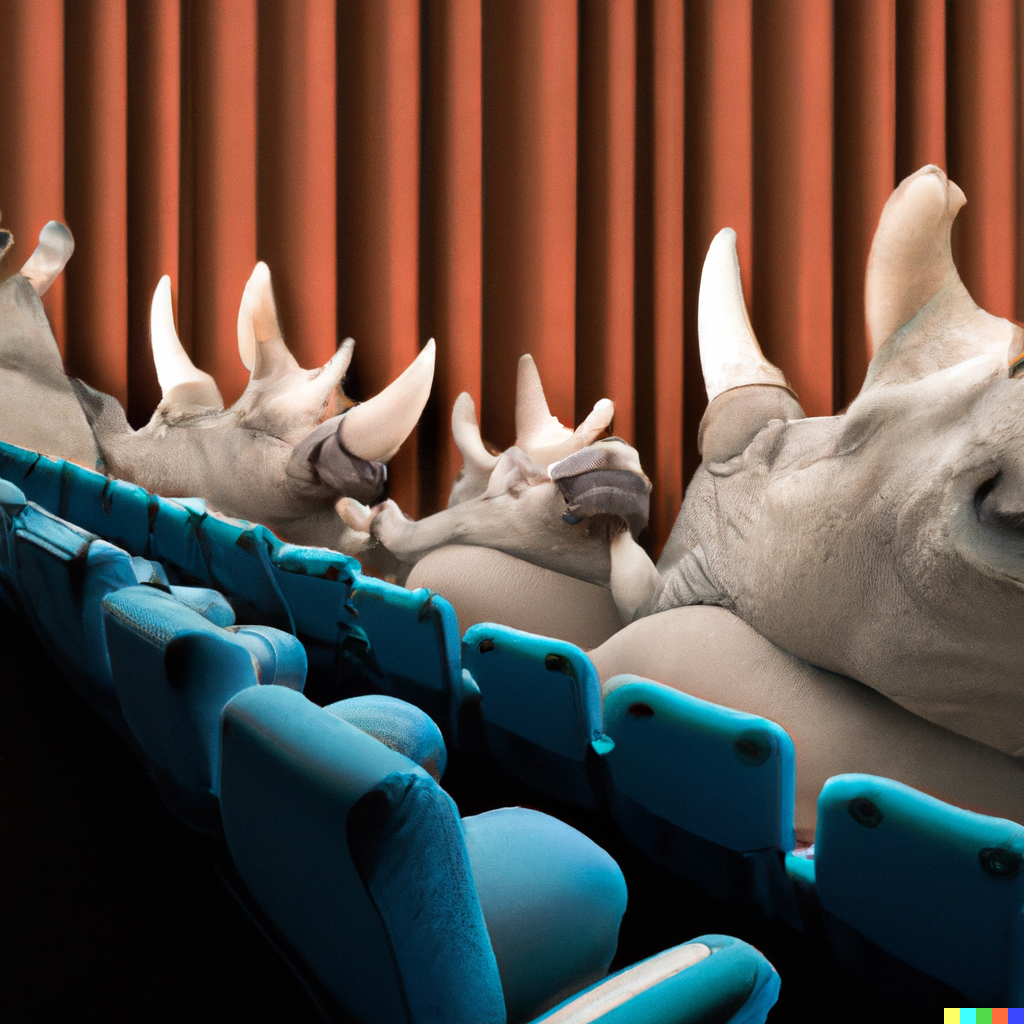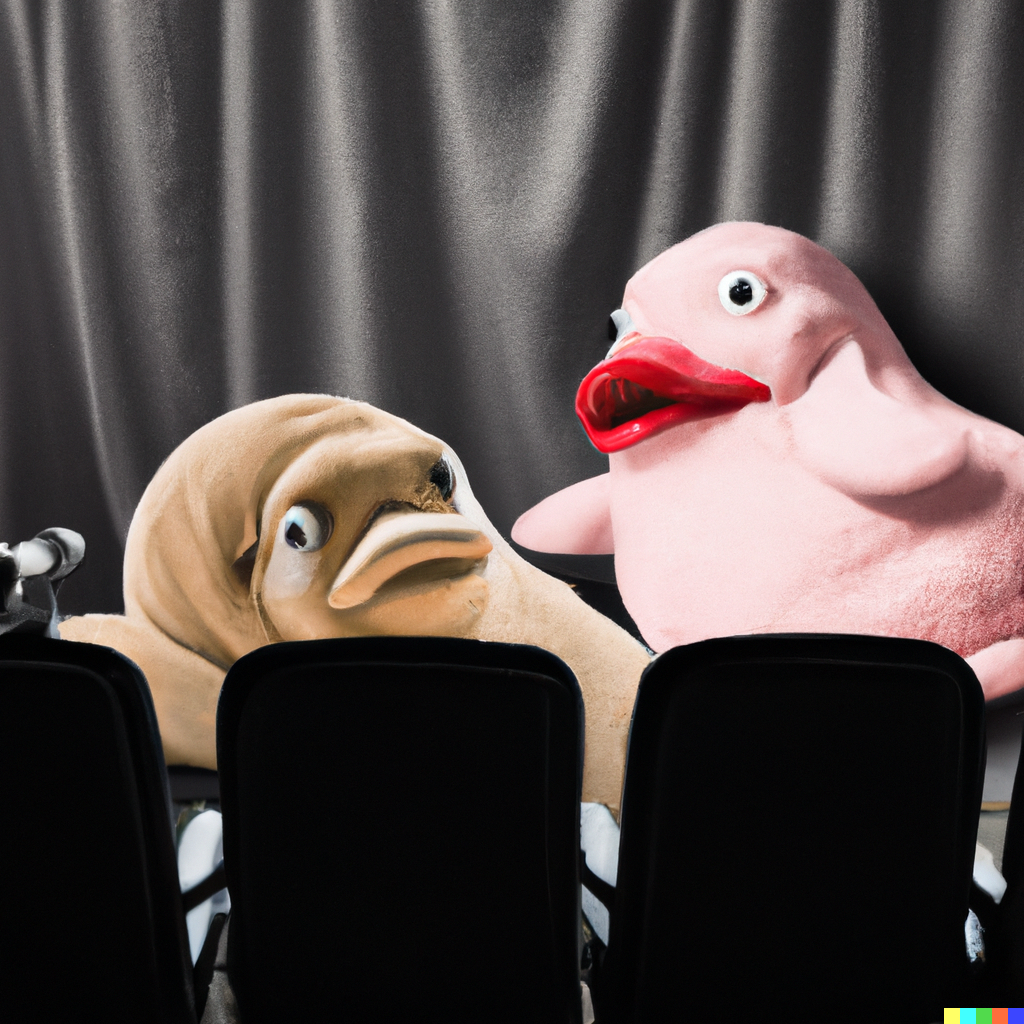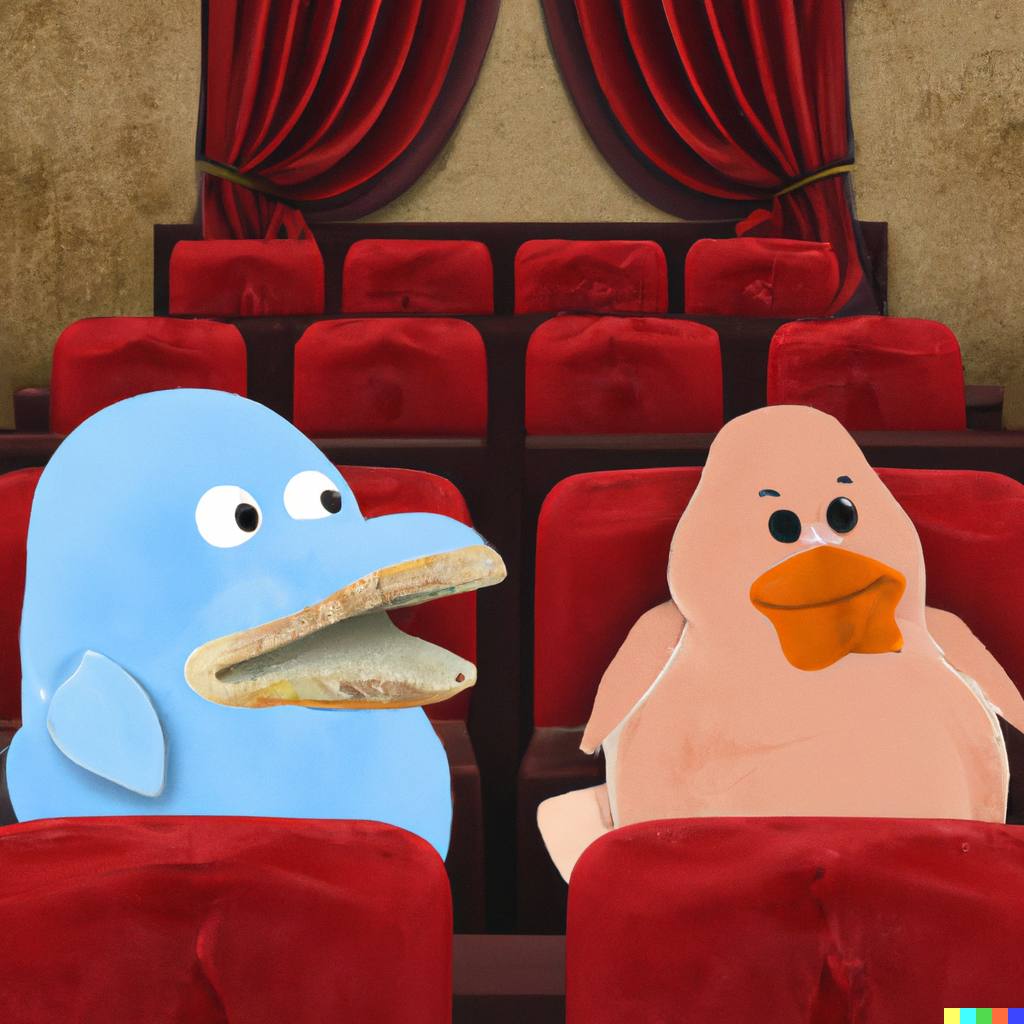Fare ridere con un’intelligenza artificiale generativa è difficile per vari motivi, molti dei quali sono legati alla teoria del riso di Henri Bergson, filosofo francese che, nel suo celebre saggio Il riso (1900), analizza le dinamiche che scatenano la risata. Secondo Bergson, il riso nasce dalla percezione di un comportamento umano che diventa meccanico o rigido in un contesto sociale, creando un contrasto tra l’automatismo e la naturale fluidità delle interazioni umane.
Bergson suggerisce che il riso scaturisce quando una persona si comporta in modo che sembri un “automatismo”, come se il suo corpo o le sue azioni fossero pilotate da una macchina, senza il giusto adattamento alla situazione. Questo genere di umorismo dipende dalla capacità di cogliere l’imprevisto, il fuori luogo, il contrasto tra ciò che ci si aspetta e ciò che accade realmente. Questo deporrebbe in teoria a vantaggio dell’uso delle IA per creare battute comiche, ma alla prova dei fatti è facile rendersi conto – banalmente, usando ChatGPT – che le cose non stanno proprio così.
Quando si cerca di fare ridere con un’intelligenza artificiale esistono infatti numerose difficoltà legate proprio ai meccanismi tipicamente umani di cui parlava l’autore:
- Mancanza di esperienza e contesto umano: Il riso spesso dipende dalle esperienze personali, dai riferimenti culturali e sociali condivisi, che un’IA non possiede. Un comico umano può attingere a una varietà di esperienze vissute, comprendendo appieno le dinamiche sociali e culturali che possono far scaturire una risata. Un’IA, invece, non vive esperienze e non ha un’intuizione diretta della realtà, ma solo dati e schemi linguistici da analizzare. La battuta comica di Bergson, che si basa sul “fuori luogo” o sull’errore in un comportamento, diventa difficile per un’IA, che non sa cogliere il contesto e le sfumature che rendono qualcosa inappropriato o sorprendente.
- Automatismo vs. creatività: l’umorismo implica spesso una rottura dell’automatismo, una sorta di imprevedibilità che scuote la nostra percezione. Le IA, però, lavorano proprio sulla base di schemi ripetitivi e calcoli algoritmici. Sebbene possano generare battute, queste risultano spesso “meccaniche” o prive di quella freschezza e improvvisazione che rendono il comico umano così efficace.
- Mancanza di comunicazione non verbale: Bergson mette in evidenza che una discreta parte del riso è alimentata da aspetti non verbali della comunicazione: i gesti, le espressioni facciali e il linguaggio del corpo. Questi elementi sono impossibili da riprodurre per un’intelligenza artificiale che funziona esclusivamente con il testo.
- Difficoltà nell’ironia e nelle contraddizioni: l’ironia nasce dalla capacità di cogliere la distanza tra ciò che una persona dice e ciò che realmente intende. Le IA, non essendo dotate di una comprensione emotiva o culturale profonda, non sono in grado di afferrare l’arguzia o l’ambiguità con la stessa sottigliezza di un comico umano.
Sebbene le intelligenze artificiali siano in grado di generare battute e risposte comiche, è difficile che riescano a suscitare una risata autentica come farebbe un comico. Questo perché il riso, secondo Bergson, dipende da un’interazione complessa tra la realtà e il suo contrasto, un contrasto che emerge dalla nostra capacità di percepire la vita come un flusso imprevedibile e sorprendente. L’intelligenza artificiale, pur eccellendo nell’analisi dei dati e nella produzione di contenuti, manca dell’esperienza umana, della capacità di improvvisare e del senso del contesto che sono alla base della comicità più profonda e spontanea.
Ci abbiamo provato qui, e queste sono le prime battute che sono “venute in mente” a ChatGPT il 24 dicembre 2024.
“Perché il computer non va mai in vacanza? Perché ha paura dei virus!”
“Perché gli astronauti portano sempre una matita nello spazio? Per scrivere nelle stelle!”
“Perché il pomodoro non riesce mai a prendere un treno? Perché perde sempre il sugo!”
Invitando ChatGPT a fare qualcosa di più mirato esce fuori qualcosa di migliore, anche se si evidenzia fin da subito come sia meglio farne uso come strumento assistivo e non automatico al 100%:
“Ho chiesto a ChatGPT di scrivere una barzelletta… mi ha risposto: ‘Errore 404, senso dell’umorismo non trovato!’”
e funziona discretamente anche se modelliamo sullo stesso esempio altre battute (o presunte tali):
“Ci ho provato con una, mi ha detto di no. Risultato: errore 403, accesso al cuore negato!”
“Ci ho provato con una, mi ha detto di no. Errore 503: servizio amore non disponibile!”
Ho invitato a questo punto il chatbot a ispirarsi a Billy Hicks, e a cambiare argomento: ha tirato fuori
“Cercavo la felicità su Google… ma mi ha reindirizzato su Amazon con uno sconto del 10%!”
A questo punto ho fatto generare un po’ di battute a raffica, ed ho selezionato quelle che reputavo migliori. Quelle vagamente divertenti potrebbero essere:
“Ho cercato la pace interiore… ma l’unica cosa che ho trovato è stato un Wi-Fi gratuito.”
“La gente parla sempre di ‘essere te stesso’, ma se fossi davvero me stesso, starei sul divano a mangiare patatine e insultare il mondo intero.”
“La gente mi dice di ‘guardare il lato positivo’. Io guardo il lato positivo e vedo solo una fila di cose che non voglio fare.”
“Mi hanno detto che la verità ti rende libero, ma poi ho scoperto che la verità è solo un’altra scusa per non dire quello che davvero pensi.”
“L’unico posto dove mi sento in pace è quando chiudo gli occhi e immagino che il mondo sia stato cancellato da un bug di sistema.”
“C’è sempre qualcuno che ti dice che ‘la felicità è una scelta’. A me sembra più una di quelle cose che ti vendono nei negozi di alimentari quando non hai più voglia di cucinare.”
Quelle con meno senso o più fiacche, comunque, rimangono la maggioranza:
“Voglio credere nel karma, ma sinceramente, se mi devo fare un’idea del karma, sembra più un disastro organizzato.”
“Sono andato in palestra per un mese… e l’unica cosa che ho sollevato è stato il morale dei miei amici.”
“Mi hanno detto che l’amore è cieco, ma forse è solo mio il problema, perché non vedo un futuro con quella persona!”
“Mi hanno detto che l’intelligenza artificiale sta cambiando il mondo… Ma io ancora non so come far partire la stampante.”
“La mia dieta è come una relazione: comincia bene, poi finisce sempre con il dolce.”
“Ho deciso di essere positivo… e ho iniziato a ignorare le bollette.”
“Mi hanno detto che l’importante è non arrendersi, ma non mi hanno spiegato che fine fanno i sogni quando finisce la batteria del telefono.”
“I social sono come le feste: all’inizio sembra divertente, poi ti rendi conto che nessuno ha voglia di parlare davvero.”
“Cercavo una soluzione ai miei problemi… ma poi ho trovato un’app che mi dice quando devo bere acqua. Problema risolto!”
“Sono andato in un ristorante vegano… Ho scoperto che la vera ‘carne’ era il conto.”
“Non capisco perché si parlino di diritti umani, quando nessuno ti dà nemmeno il diritto di non rispondere a una chiamata con l’ID sconosciuto.”
“La religione è come un abito elegante: lo metti per impressionare, ma alla fine ti fa sentire scomodo e fuori posto.”
“Tutti vogliono essere felici, ma nessuno ha mai chiesto a me se sono pronto per farlo. Ho un sacco di cose da fare, tipo non capire cosa sta succedendo nel mondo.”
“Mi hanno detto di ‘vivere nel presente’, ma sono ancora bloccato a guardare il passato mentre il futuro mi sta urlando dalla finestra.”
“La politica? È come un gioco di società: tutti si stanno mettendo in fila per vincere, ma nessuno sa davvero le regole e, alla fine, chi vince perde comunque.”
“Ho chiesto al mio terapeuta come affrontare le mie paure. Mi ha risposto: ‘Non preoccuparti, è il tuo lavoro farle entrare nella stanza.’”
“Il problema della vita? Stai cercando sempre di sistemare le cose, ma le cose, mio caro amico, non sono fatte per essere sistemate.”
“Ci sono quelli che dicono ‘tutto succede per una ragione’, ma io non credo che la mia faccia sia stata progettata per essere vista da qualcuno.”
“La gente è ossessionata dal ‘cercare il senso della vita’. Io sono più preoccupato di non trovare il mio portafoglio quando ne ho davvero bisogno.”
Le difficoltà nell’ottenere risate genuine da un’intelligenza artificiale generativa si radicano nelle teorie psicologiche e filosofiche sul riso, a partire da Henri Bergson. La sua riflessione sul riso come reazione all’automatismo e alla rigidità dei comportamenti umani ci offre un quadro utile per comprendere perché l’IA fatica a emulare la comicità autentica. Bergson suggerisce che la risata nasce da una sorta di meccanismo che interrompe la fluidità naturale del comportamento, creando una dissonanza che il pubblico riconosce come comica. Tuttavia, l’IA, pur basandosi su algoritmi avanzati, non ha accesso a quella “fluidità” esperienziale che è essenziale per cogliere e generare quella rottura del naturale che provoca il riso. La sua risata è infatti più sterile, derivante dall’elaborazione logica e schematica dei dati piuttosto che da un’autentica comprensione del contesto sociale, emotivo e culturale.
Le IA possono riconoscere e replicare schemi linguistici comici, ma non sembrano riuscire a “sentire” e a interpretare le sottili sfumature del linguaggio che vanno oltre le parole, come il sarcasmo o l’ironia. Studi più recenti, come quelli di Robin Dunbar sulla connessione sociale attraverso l’umorismo, suggeriscono che la risata ha anche una funzione sociale fondamentale, promuovendo il legame tra gli individui. Dunbar sottolinea che il riso è un’azione umana profonda, legata alla condivisione e alla comunicazione non verbale, e che una “battuta” diventa veramente comica quando è situata in un contesto condiviso. Le risate collettive, osservate in contesti di gruppo, creano connessioni tra le persone, un aspetto che l’IA non è in grado di replicare (e che probabilmente mai riuscirà ad emulare). Studi più specifici sul machine learning e sull’IA emotiva, come quelli condotti da Rosalind Picard del MIT, evidenziano che – sebbene le AI possano riconoscere alcune emozioni nei testi o nelle espressioni facciali – la loro capacità di generare umorismo autentico rimane limitata proprio perché non hanno una comprensione profonda di ciò che rende divertente un comportamento, un atteggiamento o una situazione.