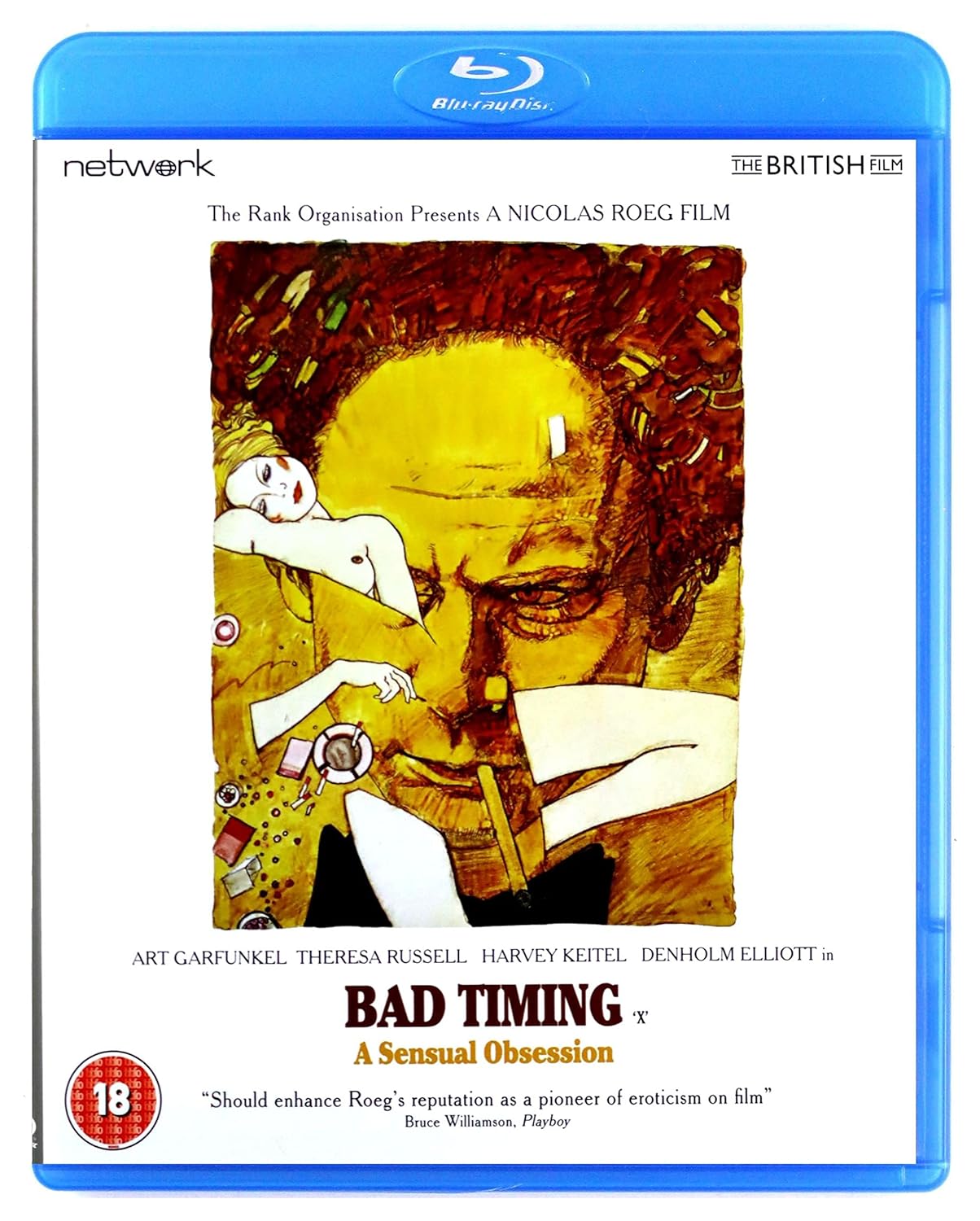Nel panorama del cinema psicologico europeo tra gli anni Settanta e Ottanta, Il lenzuolo viola di Nicolas Roeg occupa una posizione singolare e ancora oggi perturbante. Opera rifiutata, fraintesa e perfino osteggiata in fase produttiva, si rivela tuttavia uno dei lavori più coerenti e spietati del regista britannico: un’indagine sull’ossessione amorosa che rifiuta qualsiasi forma di sentimentalismo e si addentra senza filtri nelle zone oscure del desiderio.
Ambientato in una Vienna crepuscolare, sospesa tra decadenza mitteleuropea e tensione da Guerra Fredda, il film si apre con un evento traumatico: il ricovero in ospedale di Milena Flaherty per overdose. Da questo punto apparentemente conclusivo, Roeg costruisce un racconto frantumato, fatto di salti temporali, ellissi e ripetizioni, che ricostruisce a ritroso la relazione tra Milena e Alex Linden, psichiatra americano incapace di applicare a se stesso gli strumenti con cui interpreta gli altri. La struttura narrativa non mira mai a condurre lo spettatore verso una verità univoca: lo obbliga invece a navigare tra percezioni soggettive, ricordi deformati e zone d’ombra morali.
Il rapporto tra Alex e Milena è il vero fulcro del film, ma Roeg lo priva deliberatamente di qualsiasi idealizzazione. Non si tratta di una storia d’amore, bensì di un terreno di confronto emotivo in cui si intrecciano bisogno, dipendenza, manipolazione e timore dell’abbandono. Milena, incarnazione di una libertà inquieta e autodistruttiva, sfugge costantemente alle definizioni e alle categorie in cui Alex tenta di rinchiuderla. Egli, razionale solo in apparenza, trasforma progressivamente il desiderio in controllo, l’intimità in possesso. La loro relazione non evolve: implode, trascinando con sé ogni possibilità di equilibrio.
La figura dell’ispettore Netusil introduce una dimensione quasi investigativa, ma anche qui Roeg evita le convenzioni del genere. L’indagine non serve a chiarire i fatti, bensì a mettere in crisi le versioni dei personaggi, insinuando il dubbio che la verità non sia un dato oggettivo, ma una costruzione emotiva. In questo senso, il film oscilla costantemente tra colpa e responsabilità, consenso e violenza, amore e sopraffazione, senza mai offrire al pubblico un punto di riferimento rassicurante.
Dal punto di vista formale, Il lenzuolo viola è uno degli esempi più radicali del cinema di Roeg. Il montaggio spezzato, quasi musicale, rispecchia il funzionamento della memoria e dell’inconscio: immagini che ritornano, si sovrappongono, cambiano significato a seconda del contesto. La fotografia e l’uso cromatico contribuiscono a creare un’atmosfera sensoriale e inquietante, in cui il corpo diventa luogo di desiderio ma anche di vulnerabilità. L’erotismo non è mai decorativo: è esposto, scomodo, spesso doloroso, perché legato a dinamiche di potere più che a un’autentica reciprocità.
Sotto la superficie di un dramma sentimentale, il film si configura come una riflessione impietosa sull’illusione di conoscere l’altro. Alex, psichiatra, è paradossalmente il personaggio più cieco: analizza, etichetta, interpreta, ma non ascolta davvero. Milena, al contrario, sfugge a ogni tentativo di definizione definitiva, divenendo il simbolo di ciò che non può essere posseduto né spiegato. In questo conflitto risiede la tragedia del film: l’impossibilità di conciliare desiderio e libertà senza trasformare l’amore in una forma di violenza.
Rifiutato al momento dell’uscita e accusato di cinismo e misoginia, Il lenzuolo viola è stato progressivamente rivalutato come una delle opere più oneste e disturbanti del cinema d’autore europeo. Non offre consolazione, non redime i personaggi e non cerca l’empatia facile. È un film che osserva l’ossessione senza giudicarla apertamente, ma nemmeno senza denunciarne la natura distruttiva. Proprio per questa sua crudezza, resta un’opera scomoda, ancora capace di mettere a disagio e di interrogare lo spettatore sul sottile confine tra amore e annientamento.