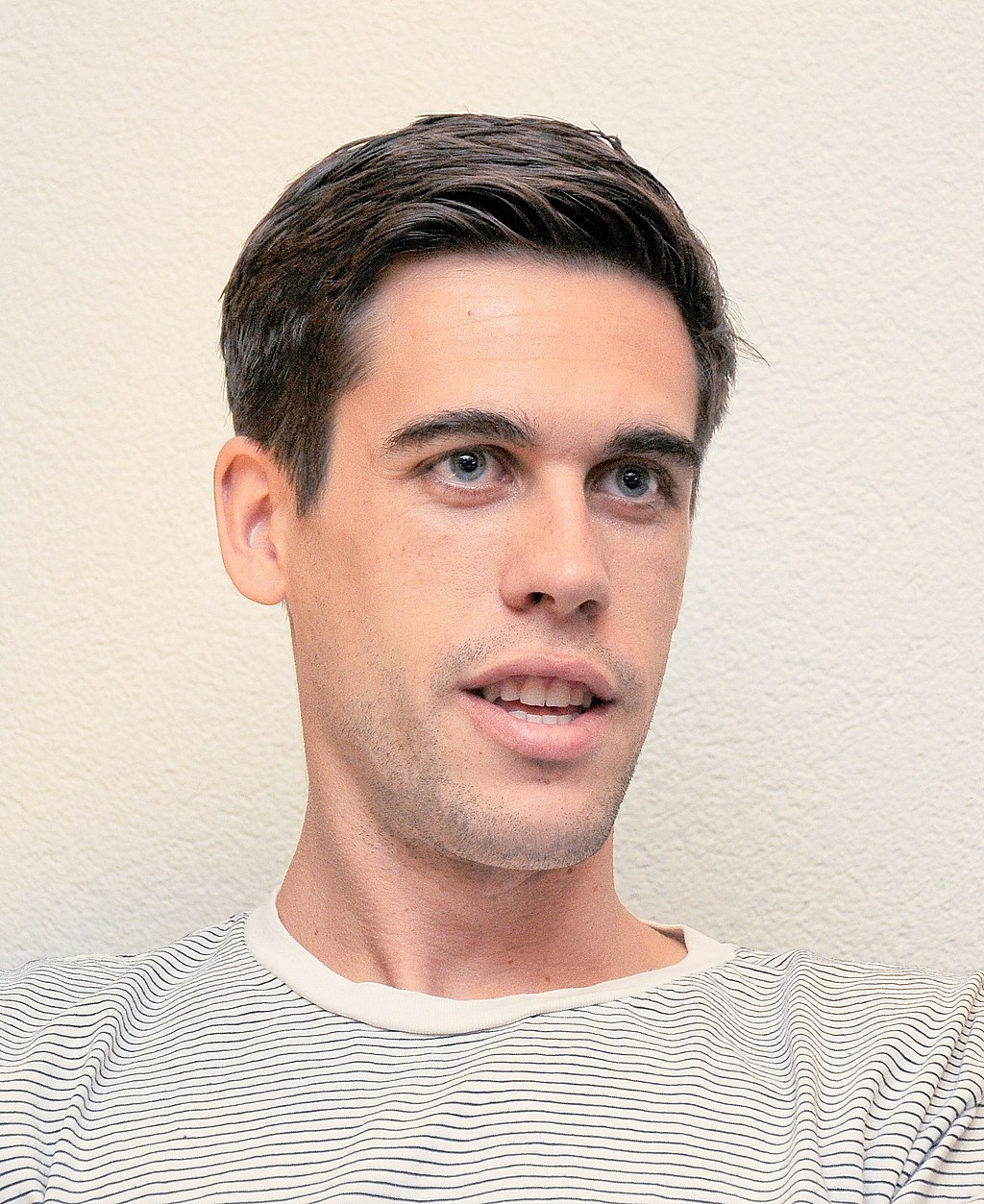Credimi, sono un bugiardo (“Trust Me, I’m Lying: Confessions of a Media Manipulator” in lingua originale) è un libretto misconosciuto in Italia, uscito nel lontano 2014 e (come va di moda scrivere in questi casi, pur non trattandosi di un episodio dei Simpson) sostanzialmente profetico.
Profetico non a caso, direi, perchè questo diario di Holiday – prima che entrasse in una fase di redenzione che abbraccia addirittura lo stoicismo – è una esplorazione accurata e approfondita delle tattiche o strategie utilizzate dai media e dai pubblicitari per manipolare e influenzare le notizie e l’opinione pubblica.
Sulle prime si tratta di un’incomprensibile ode irrazionale e tutt’altro che stoica, in effetti: Holiday lavora nel cinema, deve promuovere un film commedia (si tratta del misconosciuto in Italia I Hope They Serve Beer in Hell), e di punto in bianco racconta di aver deciso di auto-imbrattare il manifesto del film, accusandolo di misoginia e maschilismo.

Holiday sta facendo qualcosa di poco ovvio, vagamente autoreferenziale e sostanzialmente da troll: scrive delle frasi di accusa contro l’uscita del film per cui sta lavorando, con l’idea che questo possa garantire in prospettiva una visibilità al film stesso. Il punto non è nemmeno capire se le accuse fossero fondate, perchè all’epoca della campagna il film non era nemmeno uscito nelle sale.
Ovviamente non si aspetta che qualcuno si accorga per caso della cosa. Holiday auto-imbratta quei manifesti e poi scatta delle foto col proprio smartphone. Arrivato a casa, scrive a due blog molto in vista all’epoca, usando un account fake (usa il falso nome di Evan Meyer) e segnala loro di aver visto per caso quelle locandine, senza indicare la strada precisa in modo da risultare più credibile. È la miccia definitiva che finalmente si innesca. I blog, da sempre a caccia di notizie (più volte l’autore ribadisce come certe testate online siano letteralmente disposte a pubblicare qualsiasi cosa, pur di ricevere visite), non vanno tanto per il sottile, non possono immaginare che la notizia sia auto-generata (per non dire farlocca), e pubblicano un articolo sull’argomento.
Dopo qualche ora, la (falsa) notizia è rimbalzata su tutti i siti, viene ripresa dai giornali nazionali. Il piano virtuale si innesta nel reale: viene fatta rimuovere la pubblicità del film dagli autobus di linea della città. Alcune femministe scendono in strada per manifestare contro il regista, accusato di aver girato un film misogino che, da quello che traspare nella ricostruzioni, ben pochi avevano visto. L’idea ovviamente è che tanta gente si butti al cinema a vederlo per verificare se le accuse siano vere, cosa che a quanto pare (purtroppo per Holiday) non avverrà
Ma per il momento, come dire, missione compiuta.

L’eco della notizia non pervenì in Italia (dove non è difficile immaginare che una cosa del genere sarebbe potuta succedere con facilità anche oggi), perchè mai questo film vi è arrivato, ma fu una case history da manuale. Questa storia racconta tutto o quasi su come sia facile, usando internet da vero troll, creare notizie sensazionalista indistinguibili dalle notizie reali.
Per quello che vale saperlo: il film di Tucker ebbe recensioni quasi tutte negative, con una media di 3,19/10 sull’affidabile Rotten Tomatoes, che lo stroncò ferocemente: “I Hope They Serve Beer in Hell fallisce nei suoi tentativi di umorismo volgare, e Tucker Max si presenta così antipatico e oltraggioso che l’inevitabile arco narrativo del film sembra forzato“, fino a renderlo addirittura uno dei peggiori dell’anno.
Non solo: il film fallì al botteghino guadagnando poco più di 1 milione di dollari, e la colpa secondo Tucker fu proprio quella di essersi fatti prendere la mano con le fake news sul film. Durante il periodo promozionale pre-uscita del film, come se non bastasse, i media furono unanimi nell’accusare il film ed il regista di un approccio superficiale e violento al sesso, con la pesante accusa di rendere affascinante la pratica di fare sesso con donne ubriache e/o non consenzienti. Naturalmente il tema è molto serio, e proprio per questo non avrebbe mai dovuto essere vittima di un’attività di marketing senza scrupoli del genere. Il dubbio sostanziale dopo aver letto questo libro è quello di quantificare quanti pubblicitari, ancora oggi, ragionino come Holiday, ponendo pubblicità costruite in modo sensazionalistico, assoldando troll al fine di insultare e fomentare le fazioni, fino ad arrivare al caso recente di EsseLunga o delle pubblicità che raccontano storie fascinose (bias della narrazione) premettendole al prodotto, dove il prodotto o servizio nemmeno viene esplicitato.
Nel libro Trust Me, I’m Lying, il marketer Ryan Holiday ha sostenuto che quella controversia fosse una trovata pubblicitaria fabbricata e falsamente diffusa da Holiday per creare interesse sul film, che ebbe come unico risultato quello di svilire una tematica sociale seria e instillare nella gente l’idea che non ci si possa fidare di nessuno. Sono i miracoli (si fa per dire) dell’auto-imbrattamento, dell’auto-insulto, dell’idea che per far parlare di sè uno possa arrivare all’autolesionismo, a volte ammantandolo di un’aura subliminale, della serie “lo faccio perchè così parleranno di noi“. Non è diverso, estremizzando, dagli influencer che rischiano di farsi male seriamente per creare un video che faccia visualizzazioni.
Detta banalmente, l’idea di fare qualcosa di triviale e spacciarla per “cult” è consolidata nei social (viene prevista da certi horror pseudo snuff di qualche anno fa, che ne prefigurano e simboleggiano gli orrori di fondo: visto oggi, August Underground potrebbe quasi sembrare un reality come tanti altri), per cui Holiday (nel bene o nel male) potrebbe essere uno dei più grandi precursori nella storia. Anche perchè, a rifletterci ancora, auto-imbrattarsi non è semplicemente dare benzina a quell’abusato bene o male, purchè se ne parli: significa, per lo più. declinare quel detto stereotipato nel lato osceno, raddoppiandolo, triplicandone l’entità, rincarando la dose: male o malissimo, purchè se ne parli.
Si potrebbe anche discutere della natura politica di questo trollaggio, che ha scatenato le ire di varie attiviste sulla base di un fatto fabbricato ad arte, spiattellato da un marketer in cerca di visibilità senza che nessuno, di fatto, si sia preso la briga di verificare. Perchè il punto è questo, e prefigura l’era della post verità, in cui la realtà delle cose è un’opzione come qualsiasi altra, reale o immaginaria che sia. All’epoca si poteva anche capire che un’operazione di auto-imbrattamento fosse inconcepibile da essere intuita dall’esterno, ma oggi, mi chiedo: quanti auto-imbrattatori potrebbero ancora esistere, solo in Italia?
Poco importa che il risultato sia stato conseguito e la campagna non abbia probabilmente funzionato a dovere (come anche ammise il regista del film), perchè tanto nel mondo del marketing digitale non sembrano esistere sensi di colpa. Con una mossa di un cinismo sublime, e con la lucidità di raccontare la storia senza filtro, Holiday racconta il mondo delle pubblicità online in nuce, riferendo più volte come i blog più in vista siano strumenti molto potenti nelle mani dei pubblicitari, per quanto ad esempio in Italia il più delle volte, alla meglio, ai blog si chiedano (perlopiù) banali guest post.
Nel libro Holiday condivide le sue esperienze lavorando nel settore delle pubbliche relazioni e del marketing online, rivelando come notizie false o sensazionalistiche possano essere diffuse e amplificate attraverso il ciclo delle notizie digitali, in modo da fornire visibilità a chi di dovere, nel bene o nel male. Viene esposta soprattutto, a mio avviso, la sostanziale fragilità del giornalismo online e la tendenza dei media a dare priorità al clickbait e al sensazionalismo rispetto all’accuratezza e alla verità, proprio perchè i giornali online lavorano sulle visualizzazioni e senza quelle, di fatto, muoiono rapidamente..
Foto di Holiday: Luiz Berengue, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons