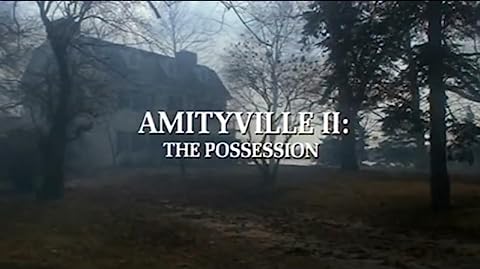Informazioni sul film
Ecco alcune curiosità sul film “Amityville Possession” del 1982, diretto da Damiano Damiani:
- “Amityville Possession” è il terzo capitolo della serie di film basati sui tragici eventi che si sono verificati nella casa di Amityville, in Long Island, New York. È un sequel diretto del film del 1979 intitolato “Amityville Horror”.
- Il film è stato diretto da Damiano Damiani, un regista italiano noto per il suo lavoro nel genere thriller e horror. Damiani ha contribuito a creare un’atmosfera inquietante e angosciante nel film.
- “Amityville Possession” è stato prodotto dalla Dino De Laurentiis Cinematografica, una rinomata casa di produzione italiana che ha realizzato numerosi film di successo nel corso degli anni.
- Il cast del film includeva attori come James Olson, Burt Young, Rutanya Alda e Jack Magner, che hanno offerto interpretazioni convincenti dei personaggi coinvolti negli eventi soprannaturali della storia.
- Una delle curiosità più interessanti riguarda la casa di Amityville utilizzata nel film. Per rispettare la privacy dei proprietari della vera casa di Amityville, la produzione ha costruito una replica identica della casa per le riprese.
- “Amityville Possession” ha continuato ad alimentare l’interesse per la storia di Amityville, offrendo una visione unica degli eventi e dei fenomeni paranormali che si dice siano accaduti nella casa infestata.
Amityville Possession (Amityville II: The Possession) è un film horror del 1982 diretto da Damiano Damiani, che funge da prequel al primo film, Amityville Horror, uscito nel 1979. La regia di Damiani ricevette particolari apprezzamenti soprattutto per la sequenza particolare in soggettiva del demonio stesso, durante il momento in cui si impossessa di Sonny. Per il ruolo di Anthony, il padre di Sonny, fu scelto l’attore italo-americano Burt Young, all’apice della sua carriera grazie al ruolo del cognato del pugile Rocky.
Trama Amityville II: the possession
La trama di “Amityville Possession” (Amityville II: The Possession), diretto da Damiano Damiani, ruota attorno alla storia della famiglia Montelli, una famiglia italo-americana che si trasferisce nella casa di 112 Ocean Avenue ad Amityville, Long Island. Dopo aver acquistato la casa, i Montelli iniziano a vivere una serie di eventi inquietanti e inspiegabili. La madre, Dolores, si rende conto per prima che qualcosa di sinistro si annida nella casa e cerca l’aiuto del sacerdote padre Adamsky. Tuttavia, prima che possa intervenire, il figlio maggiore, Sonny, viene posseduto da una presenza demoniaca. Il demone che ha preso possesso di Sonny inizia a influenzare il suo comportamento, portandolo ad avere un rapporto incestuoso con la sua stessa sorella. La situazione si intensifica ulteriormente quando Sonny impugna un fucile e massacra brutalmente il resto della sua famiglia.
Sonny viene arrestato, ma a causa delle circostanze paranormali che circondano l’accaduto, il prete padre Adamsky decide di liberarlo dalla prigione con l’intento di esorcizzarlo. Tuttavia, durante il tentativo di portarlo in chiesa per l’esorcismo, Sonny scappa e torna nella casa infestata. Padre Adamsky lo segue e, in un disperato sforzo finale, riesce a liberare Sonny dal controllo del demone. Sonny viene portato via dalla polizia, mentre padre Adamsky, esausto e provato, si ritrova posseduto dal demone che prima lo aveva dominato.
Di cosa parla il film
Il film “Amityville Possession” esplora l’oscura presenza demoniaca che ha afflitto la famiglia Montelli e mette in luce gli sforzi di un prete per affrontare il male sovrannaturale. La trama si basa su eventi ispirati al vero caso di cronaca della famiglia DeFeo del 1974, che ha sconvolto la comunità di Amityville.
Quali sono i tragici fatti di cronaca su cui si basa il film?
La storia di Amityville è una vicenda controversa che ha inizio il 13 novembre 1974, quando a Long Island, New York, sei membri della famiglia DeFeo vengono trovati brutalmente assassinati nella loro casa di Amityville. Ronald “Butch” DeFeo Jr., il figlio maggiore, viene successivamente arrestato e condannato per i delitti. Sostiene di aver commesso gli omicidi sotto l’influenza di voci demoniache che lo avrebbero spinto a compiere l’atroce gesto.
Un anno dopo, nel dicembre 1975, George e Kathy Lutz acquistano la casa di Amityville, nonostante la sua oscura reputazione legata agli omicidi precedenti. La coppia, insieme ai loro tre figli, si trasferisce nella casa sperando di iniziare una nuova vita. Tuttavia, affermano di essere stati testimoni di fenomeni paranormali disturbanti e inquietanti sin dal loro arrivo. I Lutz raccontano di strani rumori, presenze sinistre, malfunzionamenti elettrici, porte che si aprono e si chiudono da sole, e persino di aver visto figure spettrali. Affermano anche di essere stati soggetti a un aumento di tensione e conflitti familiari, presumibilmente causati dall’influenza maligna che sarebbe presente nella casa. Dopo soli 28 giorni, la famiglia Lutz decide di abbandonare la casa, affermando di non poter più sopportare l’oppressione e la paura costante. Questo evento segna l’inizio di un’ampia copertura mediatica e di un’attenzione internazionale verso la storia di Amityville.
La vicenda diventa un fenomeno culturale e suscita un ampio dibattito sulla veridicità degli eventi riportati dalla famiglia Lutz. Ci sono coloro che credono fermamente alla presenza di forze paranormali nella casa di Amityville, mentre altri ritengono che sia stata una semplice invenzione o esagerazione dei Lutz per guadagnare notorietà e sfruttare il successo dei libri e dei film basati sulla loro storia. Dal 1977, la storia di Amityville è stata oggetto di numerosi libri, documentari e adattamenti cinematografici. Le opere hanno spesso narrato la vicenda in modo romanzato, aggiungendo elementi di horror e suspense per amplificare l’atmosfera spaventosa. Nonostante le controversie e il dibattito in corso sulla veridicità dei fatti, la storia di Amityville continua a essere un’icona del genere horror e un argomento affascinante per coloro che sono interessati all’occulto e al paranormale. Resta un mistero irrisolto, lasciando spazio a diverse interpretazioni e opinioni.