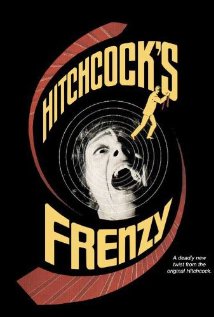La doppia storia di un jazzista e di un giovane meccanico, esplicata in dinamiche da incubo e collegamenti anomali tra i due personaggi. Il tutto ruota attorna ad una storia di gelosia ed ambigui personaggi…
In breve: uno dei capolavori di David Lynch, l’essenza della sua poetica più oscura. Lugubre, enigmatico e ricco di spunti psicologici di spessore.
“Ti voglio… ti voglio, Alice…” – “Tu non mi avrai … MAI!”
Piccola premessa: un luogo comune abusatissimo in parecchie recensioni dei film di Lynch è legato allo stereotipo secondo cui bisognerebbe lasciarsi trasportare puramente dalle emozioni, seguire le immagini e non preoccuparsi troppo della trama. Fermo restando che Lynch non usa dare “spiegazioni” per i suoi film, secondo me questo luogo comune è una semplificazione un po’ eccessiva, che serve molto spesso ad assolvere il recensore da qualsiasi responsabilità per averla, eventualmente, “sparata grossa”. Data l’evidente enormità di cui Lynch riesce ad avvolgere anche i suoi film più piatti, infatti, sarebbe anche lecito farlo: figuriamoci quelli inequivocabilmente validi ed intriganti come questo. Dunque mi pare opportuno cercare di seguire più del solito quanto concretamente rappresentato sulla pellicola (l’ho finito di fare qualche minuto fa), senza sconfinare nelle solite improbabili metafore da acido lisergico.
“Dick Laurent è morto” è la misteriosa frase con cui si apre e si chiude uno dei migliori film diretti da David Lynch, sceneggiato da lui stesso e da Barry Gifford; si tratta di una storia dalle forti tinte noir con un enorme “buco” narrativo all’interno, ovvero l’inspiegabile mutazione fisica del musicista Fred nel meccanico Pete. Dal punto di vista interpretativo sono state scomodate complesse strutture matematiche (il nastro di Moebius, da parte di Enrico Ghezzi), idea forse efficace ma che possiede il difetto di spiegare una cosa già intricata con una altrettanto difficile.
I DOPPI RUOLI DEL FILM. In primis bisogna inquadrare ovviamente Renee Madison / Alice Wakefield, sempre interpretati dalla Arquette: la prima è la conturbante consorte del musicista, la seconda è l’ambigua compagna del gangster Mr. Eddy, che possiede a sua volta un doppio di nome Dick Laurent. Il film è incentrato su un rapporto di coppia, peraltro, che sembra non trovare equilibrio in nessun caso, come a dire due estremità attratte l’una dell’altra che non combaciano.
DOPPIA NARRAZIONE. A quanto si vede è possibile individuare due livelli di narrazione, che riguardano essenzialmente lo stesso protagonista che – come vuole il surrealismo, cioè in modo libero dalla coerenza prettamente logica e basandosi esclusivamente su un flusso onirico – è come se cambiasse internamente in modo così pesante da risentirne nell’aspetto fisico.Vi sono due narrazioni innestate, il cui inizio e fine non coincidono (da qui il paragone con il nastro di Mobius proposto da Ghezzi), anche se molto probabilmente riguardano la stessa persona dal punto di vista della storia reale (uxoricidio) e di quella che il protagonista sogna (e vorrebbe) fosse accaduto (la moglie che lo cerca nuovamente): il contatto con la realtà ritorna solo quando sta per morire sul serio.
DOPPIA PERSONALITA’. Qualcuno ha parlato di un assassino dalla doppia personalità: puo’ anche darsi, tuttavia a mio avviso si tratta di suddividere il realismo della prima metà con una storia che il protagonista immagina di aver vissuto, fino alla conclusione che è comunque per lui fatale. La distinzione, ovviamente, è tutt’altro che netta, anzi possiede margini molto sfocati. In altri termini il cambiamento dall’insicuro jazzista Fred nel meccanico Pete (Balthazar Getty) prefigura una mutazione del protagonista, che pero’ è impossibile che sia avvenuta sul serio (e siccome si tratta di surrealismo, la cosa passa addirittura in secondo piano). Fred dichiara apertamente, all’inizio del film, di non amare le videocamere perchè “preferisco ricordare le cose a modo mio“, e questo è un po’ il manifesto delle successive sue intenzioni.
PARALLELISMO TRA FRED E PETE. Si tratta della stessa persona? Sia Fred che Pete soffrono di un’amnesia, nessuno dei due ricorda dove abbiano conosciuto l’Uomo Misterioso (che pero’ sembra conoscerli entrambi, addirittura recandosi a casa di ognuno). Fred appare invecchiato e depresso per il tradimento da parte della moglie, Pete invece è giovane e molto sicuro di sè; la strana allucinazione che segna lo “stacco” tra i due personaggi, ovvero i genitori e la ragazza di Pete che urlano qualcosa al ragazzo sulla porta è come come una “porta” tra realtà e sogno. Pete afferma di odiare il jazz, mentre Fred è un musicista proprio di quel genere, il quale pero’ tende a ricollegare le proprie esibizioni al fatto che la moglie se ne disinteressasse completamente. I due soffrono di forti mal di testa, e sembrano destinati ad incontrare rispettivamente l’ambigua Renee/Alice (Patricia Arquette), con la quale instaurano un rapporto passionale, ma piuttosto “soffocato” per via di una terza persona (il viscido Andy per una, ed il cinico e potente Eddy per l’altra). In aggiunta a questo, sia Renee che Alice parlano con il rispettivo compagno di un “lavoro” non specificato, ma l’allusione alla natura sessuale della cosa sembra, in entrambi i casi, piuttosto evidente. Neanche a dirlo, infine, i due personaggi, pur partendo da presupposti abbastanza diversi, subiscono una sorte avversa che li spinge progressivamente verso il baratro (poco importa se per mano di un gangster o per mezzo di una sedia elettrica: il movente è per entrambi di natura passionale). Come notato giustamente dal blog “Il proiezionista”, inoltre, le convulsioni che ha Pete mentre fugge dalla polizia dopo essere “mutato” per la seconda volta sono quasi certamente quelle dovute alla sua esecuzione, che nel frattempo sta avvenendo.
L’ UBIQUITA’ DELL’ UOMO MISTERIOSO. Scena cult (ne scelgo una, ce ne sarebbero davvero parecchie): l’Uomo Misterioso parla con Fred alla festa, ed afferma di trovarsi davanti a lui e a casa sua contemporaneamente. Come prova di quanto dice, lo invita a fare il proprio numero e risponde effettivamente la stessa voce per telefono. Senza dare altre spiegazioni, l’uomo sorride e se ne va. Questo essere in due posti contemporaneamente, a mio parere, rinsalda il tema del doppio che ossessiona Lynch in questa pellicola, ed alimenta il senso di paranoia che l’Uomo Misterioso – il ricettatore e killer assoldato da Fred stesso, in sostanza – evidentemente gli infonde.
LA COPPIA CHE NON REGGE. Altra scena molto significativa: per sottolineare la freddezza di Renee e la passione che, nonostante tutto, ancora avvolge Fred, viene mostrato un amplesso con i primi piani dei protagonisti, al termine del quale la donna sorride con indifferenza e da’ una pacca sulla spalla del compagno dicendo, in modo quasi beffardo: “Non ti preoccupare, non è nulla“. Questo è in aperta contrapposizione con quello che invece è Pete: sicuro di sè e del suo lavoro, e con una vita sessuale molto attiva (con la fidanzata Sheila, intepretata da Natasha Gregson Wagner, che con la donna di Eddy).
Tra le note finali, una splendida colonna sonora di Rammstein, David Bowie, Trent Reznor, Marylin Manson, Angelo Badalamenti, Lou Reed ed altri ancora), e la partecipazione in un piccolo cameo sia di Manson che di Henry Rollins.