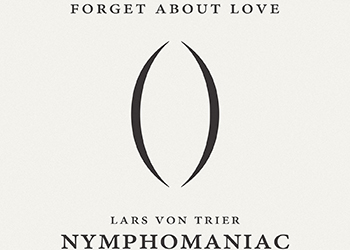Il pensionato Seligman trova Joe, sanguinante e semisvenuta, in un vicolo vicino casa propria: la donna accetta di andare a casa dell’uomo per raccontargli come sia finita lì.
In breve. Interminabile excursus sull’erotismo e le sue ossessioni, raccontato dal punto di vista di una ninfomane: c’è spazio per considerazioni varie sul genere umano, sui suoi rapporti e sui rispettivi (e spesso discutibili) comportamenti. Per un pubblico adulto, e soprattutto non superficiale.
Lanciato con un chiarissimo (per chi conosce il regista, quantomeno) “Forget about love“, Nymphomaniac è un trattato nichilista e spassionato sull’erotismo, forse tra i film più controversi del regista danese (e che, per questo, probabilmente sarà davvero capito e rivalutato solo tra qualche secolo anno). Del resto, già conosciamo le sue folli – nel senso migliore del termine – incursioni di genere, oltre alla sua innata capacità – o forse esigenza – di trovare un aspetto “scandalizzante” (ovviamente dal punto di vista dei soliti tromboni) in quasi ogni sua opera.
Anche in quelle apparentemente più innocenti, come Dogville, figurarsi ora: il dualismo morte ed erotismo è il vero protagonista. Corpi che inizialmente scoprono la sessualità, prima con entusiasmo, poi con massimo ardore e in seguito, inevitabilmente, arrivando a consumare un’agonia straziante, mentre il corpo si logora, si contorce e si ferisce. L’amore ha poco a che fare con questo processo che evoca la dipendenza da una droga, e questo è chiaro soprattutto se conosciamo la tendenza cinica e beffarda del regista nei confronti dei facili sentimentalismi.
In Nymph()maniac Von Trier racconta la storia di Joe, un’anti-eroina archetipica per un film del regista danese poichè, per sua stessa ammissione, non ha alcuna intenzione di salvarsi (rinuncia all’ambulanza fin dalle prime scene, ed evoca alcuni tratti della Justine di Melancholia). Il film racconta, con un montaggio anti-causale o seguendo lo stream of consciousness della protagonista, la storia della sua vita: la scoperta di essere ninfomane, le prime esperienza con il sesso, l’apice dell’erotismo, la sperimentazione di varie perversioni, l’inizio del degrado (e qui termina la prima parte del film), la crisi dei sentimenti, il declino, l’attrazione morbosa verso il sadismo (le sequenze più crude sono probabilmente qui), la successiva rinascita, il trauma inaspettato poco dopo.
Un viaggio interminabile, quindi, per un film di quasi 5 ore di durata, che sembrano addiritture poche, tutto sommato, rispetto a quanto e come viene raccontato. Nymphomaniac si troverà, come molti altri film di Von Trier, nelle condizioni ideali di visione avendo l’accortezza (se si può) di non leggere nulla a riguardo, prima di guardarlo.
L’incontro di Joe incontro con Seligman – archetipo maschile di colto, pacato ed un po’ tontolone “maschio medio” – diventa da un lato seduta psicoanalitica vera e propria (per la gioia degli esperti in materia, of course: a più riprese Von Trier sembrerebbe evocare il primo Cronenberg, quantomeno dal punto di vista dell’approfondimento dei personaggi e delle rispettive perversioni), dall’altro è un modo originale per raccontare una storia che, di per sè, non è altro che un incredibile concentrato di esperienza sessuali della protagonista.
La stessa Joe che, fin da piccolissima, racconta di aver sempre avuto un’insana attrazione per queste tematiche, tanto da sfregarsi con qualsiasi cosa fosse utile a stimolarla sessualmente (fin da ragazzina), e da chiedere esplicitamente il primo rapporto al suo vicino di casa – di punto in bianco. Nymphomaniac – opera omnia dell’ossessione dell’erotismo dai tratti patologici, e anche qui il parallelismo col canadese Cronenberg non sfigura, sebbene solo dal punto di vista “mentale” – nelle mani di qualsiasi altro regista sarebbe diventato un’opera insulsa; con Von Trier di mezzo non può essere così. L’impresa prefissata è quella di rendere significativo un film dai fortissimi tratti erotici, spesso esplicitamente pornografici ma mai, in effetti, gratuiti o non funzionali alla storia. Von Trier delizia il proprio pubblico con montaggi frenetici, narrazione anti-causali, scritte sullo schermo che esaltano determinate scene ed un repertorio di personaggi immenso e davvero complesso da catalogare.
A contribuire al fascino della storia deve certamente aver contribuito il cast (Udo Kier, Uma Thurman, Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård e Willem Dafoe, solo per citarne alcuni), ma ovviamente è il tipo di storia raccontata ad essere un terreno molto fertile per le provocazioni di Trier. La ninfomania, argomento su cui molti propendono a fare facili (e poco divertenti) battute, viene qui trattata con lucidità e freddezza, per meglio contestualizzare il catalogo di “tipi” umani che probabilmente avremo incontrato anche noi nella nostra vita, e capirne meglio motivazioni e disagio. Un film forse – unica vera pecca – troppo lungo per le intenzioni medie che manifesta ma, a ben vedere, girato magistralmente e, per questo, non certo da biasimare. Le considerazioni da fare saranno tante e, tra un atto di sesso ed un’ennesima perversione mostrata – sono poche quelle che Von Trier non ha preso in considerazione – c’è spazio per la riflessione serie e, naturalmente, per l’inatteso ed imprevedibile finale della vicenda.
Un twist che è tutto un programma, per quanto è pervaso di pessimismo antropologico, oserei scrivere, da manuale.