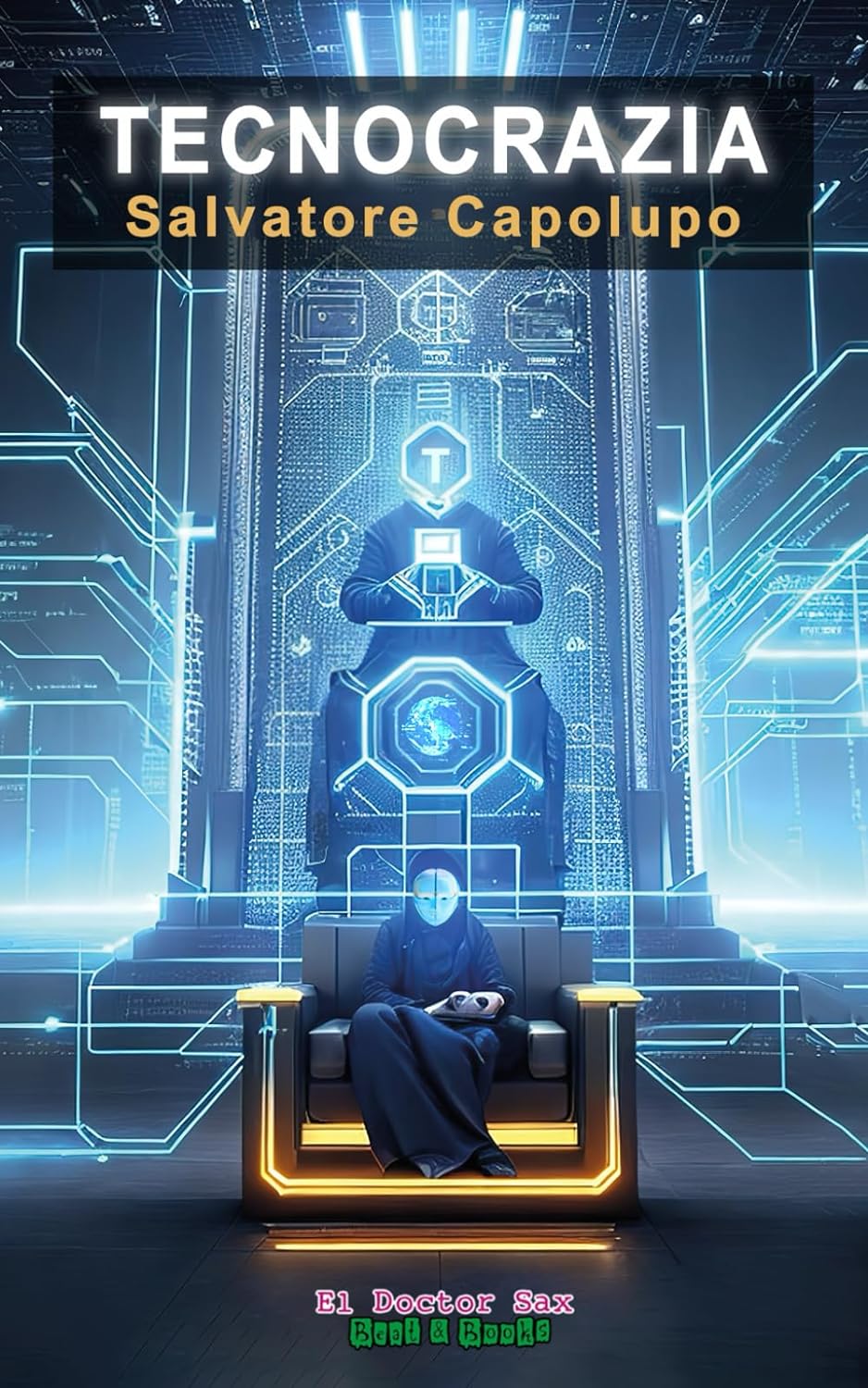“Una tecnologia dilagante ci aiuta davvero a vivere meglio, o finisce solo per condizionarci e dominare, alla lunga, le nostre esistenze?”
Viviamo una quotidianità dove il “cellulare è diventato un prolungamento della nostra organicità”, scrive Capolupo nel suo ultimo lavoro, Tecnocrazia. Un saggio in cui affronta come i rapidi cambiamenti del mondo tecnologico stanno definendo nuovamente le nostre abitudini. Secondo l’autore, infatti, la tecnologia potrebbe imporsi definitivamente sulla nostra passività e arrivare a imporre un dominio tecnocratico.
Oggi la presenza pervasiva della tecnologia ha raggiunto un punto in cui non possiamo più immaginare un mondo senza di essa. La tecnologia, infatti, è diventata così centrale nelle nostre vite che non può più essere considerata solo un aspetto accessorio, ma assumere un ruolo più attivo, portando a un possibile dominio tecnocratico: “Una tecnologia che si impone con decisione in virtù di una curiosa e autoreferenziale necessità d’esserci.”
La tecnologia, dunque, diventa un attore influente che modella le dinamiche sociali, economiche e politiche. In questo senso, l’autore parla di “tecnocrazia”, suggerendo come la governance basata sulla competenza tecnologica, potrebbe emergere come forma predominante di organizzazione sociale.
“Internet ci accoglie, ci coccola, ci fa trovare quello che vogliamo, su misura per ognuno, e ci fa diventare permalosi se qualcuno ci fa notare che quella conoscenza è farlocca. Una forma di sapienza che potremmo definire totalitaria.”
I cambiamenti avvengono troppo rapidamente per essere osservati o analizzati con la dovuta attenzione, per questo è fondamentale riflettere sulle implicazioni della crescente influenza tecnologica che sta cambiando byte dopo byte, nostra percezione del mondo.
“Complessità + velocità è diventato un binomio stordente, colossale, ingestibile, impossibile da dibattere senza degenerare in analisi semplicistiche, parziali o ingenue.”
Riflessioni supportate anche dal lavoro dello scienziato Turing, uno dei più significativi studiosi di informatica, che l’autore cita a proposito della genialità delle sue intuizioni.
La tecnocrazia, con le sue mille sfaccettature e modalità sempre più difficili da decifrare, sta andando ben oltre la soglia che si era prefissata alle origini. Oggi è già uno strumento invasivo: “può scrivere al tuo posto, cambiare le tue abitudini, produrre risultati umanizzati, ingannarti.”
“Tecnocrazia nasce da un personale flusso di coscienza che deve qualcosa al cyberpunk, la corrente letteraria che analizza il rapporto uomo-macchina da più di quarant’anni. È frutto di analisi puntuali frammiste a personaggi che conosco da sempre, alle prese con le proprie psicosi tecnologiche: app che non si aprono, email da perfetti sconosciuti, messaggi smarriti, GPS fuori controllo e intelligenze artificiali che sembrano darci del tu.”
Capolupo mette in evidenza come, grazie all’intelligenza artificiale, la tecnocrazia abbia saputo trovare nuove soluzioni e livelli di realtà in maniera tanto credibile da confondersi con la realtà stessa.
“C’è moltissimo altro in gioco, nelle tecnologie di oggi: non soltanto numeri, sesso, politica e finanza, ma anche sentimenti, stati d’animo dei singoli individui che si rapportano con le stesse.”
Come possiamo combattere la tecnocrazia? “Con il silenzio, a volte, o con un impopolare quanto sempre lecito: «non lo so».”, oppure possiamo fare qualcosa di più?
Sull’autore
Salvatore Capolupo (1979, Vibo Valentia) è un ingegnere informatico, consulente, blogger e formatore, oltre che appassionato attore e factotum teatrale. Immerso nel contesto di internet fin dai suoi albori, collabora con varie realtà digitali e startup, da molto prima che “lavorare da casa” diventasse pop. Esperto di tecnologie open source, è da sempre incuriosito dai risvolti pratici delle applicazioni e da come la tecnologia si innesti nella società in cui viviamo. Gestisce vari blog su argomento tecnologico, finanziario e cinematografico, tra cui lipercubo.it. Ha pubblicato Tecnofobia per El Doctor Sax, Tecnocrazia è il suo secondo libro.
TECNOCRAZIA di Salvatore Capolupo (190 pagine, 13.00€) è impreziosito dalla splendida copertina dell’illustratore digitale Javier Escribano (instagram: odottan_cosmic_alchemist). Il volume verrà presentato in anteprima a Roma, alla Fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi, dal 6 al 10 dicembre 2023 e sarà disponibile nelle librerie fisiche e online dal 30 novembre.
Recapiti
È possibile concordare con la casa editrice l’invio gratuito di copie dell’opera per recensioni, interviste all’autore, eventi promozionali. Per ordini, distribuzione, informazioni contattare attraverso i seguenti canali:
- E-mail: eldoctorsax@gmail.com
- Cell: +34 663 628 186