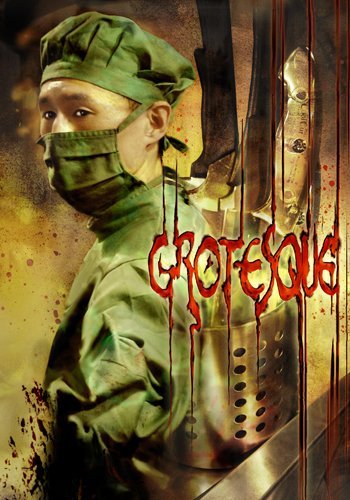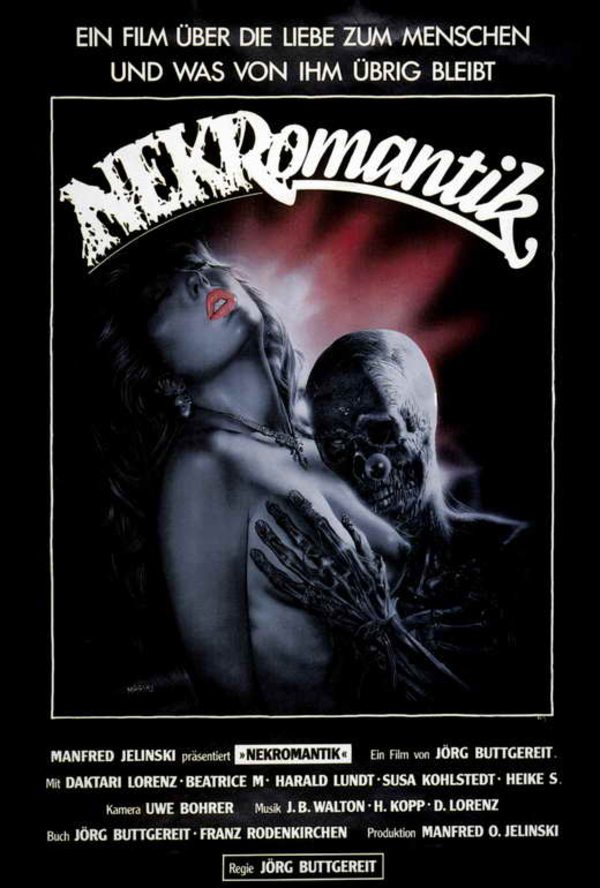Uno scrittore sta lavorando a un’opera teatrale di ispirazione biblica su Ponzio Pilato; nel frattempo Woland (alter ego di Satana in persona) e due oscuri figuri sembrano interessarsi all’opera.
In breve. La trasposizione è semplificata rispetto al romanzo, ma nel complesso regge e dovrebbe (al netto delle consuete – quanto irrealistiche – manìe traspositive) onorare la memoria dell’opera da cui è tratto. Memorabile anche per l’atipica e fondante interpretazione drammatica di Ugo Tognazzi.
“Bisogna guardare un film direttamente. il cinema non è l’arte degli accademici, ma degli illetterati“: a formulare il pensiero appena riportato è stato Werner Herzog in persona – la citazione è tratta dal libro-intervista Incontri alla fine del mondo, Edizioni Minimum Fax – considerato uno dei principali portavoce del cinema colto e impegnato, esponente della corrente del nuovo cinema tedesco e (potremmo aggiungere, a corredo) intellettuale controcorrente.
Ho visto questo film mentre finivo di leggere il mattoncino appena citato, e non ho potuto fare a meno di collegare le due linee narrative. La visione de Il maestro e margherita andrebbe effettuata, infatti, dopo aver ribadito quella frase un paio di volte, imparandola a memoria e rifiutando per questo motivo qualunque parallelismo letterario-filmico che rischierebbe, di fatto, di essere fuorviante. Se è vero quello che ha affermato Herzog, infatti, possiamo concederci questa edizione de Il maestro e margherita addirittura (!) senza aver mai letto il romanzo. Senza pensare nulla altro di atipico, lo faremmo giusto per attribuirci un grado di libertà che non è così scontato concederci.
Lo faremmo, in effetti, anche solo al fine di evitare di farci travolgere dalla barbosa questione della “propedeuticità” del romanzo – vedi il putiferio scatenato dalla versione filmica de Il signore degli anelli, ad esempio – e la consumata dicerìa secondo cui “il film è sempre inferiore al libro da cui è tratto“. Se istintivamente tendo a dare ragione a questa affermazione, infatti, ho comunque ritenuto che le due forme espressive cinema/letteratura siano, in fondo, del tutto scorrelate, sostanzialmente imparagonabili tra loro, e basterebbe citare anche solo Arancia meccanica per convincersene: entrambi pregevoli, sia nella forma di Burgess che in quella di Kubrick. E che a nessuno venga in mente di citare Shining, a questo punto, perchè questo discorso di indipendenza vale addirittura in quel caso (sono due opere diverse, tanto che le schermaglie tra scrittore e regista in merito, viste oggi, sono superate e forse più egotiste che altro).
Tutto questo spiegone senza aver ancora citato nulla del film? (Purtroppo) sì, è necessario perchè l’opera è complessa, non quanto il romanzo ma quasi, e merita un approccio da parte dello spettatore che non sia nè saccente nè tantomenoe superficiale: la teatralità marcata dell’opera potrebbe, ad oggi, essere meno compresa di quanto non fosse per il 1972, periodo in cui lo sperimentalismo era quasi la norma o la necessità. La regia di Petrović è di natura sperimentale ma non tanto da disorientare lo spettatore, e riesce ad essere avulsa dallo stile lisergico di (forse) troppe opere del periodo. Quando ho scritto che questo film onora il romanzo, in effetti, ritengo che lo faccia non perchè ricostruisca i passi della storia originale in modo fedele (cosa che sarebbe stata alquanto improbabile in ogni caso), quanto perchè evidenzia in pochi tratti il mood letterario che ha reso famoso Il maestro e margherita.
Poche, scaltre pennellate bastano al regista per delineare il tutto: la raffigurazione dell’artista appassionato e destinato alla miseria, l’atteggiamento ottuso dei burocrati censori, la figura satanica che si pone come autentico sovversore dell’ordine costituito, che Petrovic sembra esprimere contrapponendo il satanismo e la sua anarcoide libertà ad un mondo piatto, ateo quanto conformistico, feroce contro i dissidenti e burocratizzato in modo grottesco. E lo vediamo chiaramente nella scena raffigurata anche nella locandina, quella del pubblico a cui Woland fa scomparire i vestiti, sequenza che si presta peraltro a più di una interpretazione simbolica (se il pubblico siamo noi, per intenderci, siamo “nudi” di fronte al fascino della trasgressione, per quanto l’ateismo potesse sembrare almeno inizialmente la “vera” libertà).
Il sovvertimento culturale di Petrović è sostanziale, in parte forse sottovalutato da parte della critica e merita un elogio anche solo per questo, sulla falsariga della sua appartenenza alla celebre Onda Nera – nome inquietante dietro il quale si firmavano vari cineasti “semplicemente” critici verso il regime sovietico. La sua riduzione è del 1972, ed è opportuno chiamarla “riduzione” perchè assume un approccio inesorabilmente riduzionista (quanto efficace, a mio avviso) rispetto alla pluri-citata complessità del romanzo originale, in grado di far comunque evolvere due trame in parallelo senza perdersi in virtuosismi letterari che, se da una parte lo hanno reso una delle opere più celebri della letteratura russa, sarebbe state improbabili sullo schermo. Parte dell’impianto scenico di base viene comunque mantenuto, e si vede che lo script è molto lavorato quanto, in alcuni casi, forse troppo da b-movie (le sequenze delle decapitazioni, ad esempio, danno l’idea di una lavorazione sbrigativa, per così dire). Stando a IMDB, per la cronaca, si sono occupati di soggetto e sceneggiatura il regista in persona, Barbara Alberti, Amedeo Pagani e Romain Weingarten.
Del resto questo approccio critico non dovrebbe scandalizzare gli appassionati o “puristi” dell’opera letteraria, perchè non è questo il punto; come abbiamo ribadito, dovremmo accettare che Bisogna guardare un film direttamente. il cinema non è l’arte degli accademici, ma degli illetterati. In fondo siamo quasi tutti tentati, credo, a credere a quelle parole, e proprio perchè a dirlo è Werner Herzog, un cineasta impegnato e impegnativo par excellence che in quel passaggio è quasi toccante per la sua semplicità e umiltà. E proprio perchè non è Peter Jackson o Nando Cicero (tanto per citare due estremi opposti) a pensarla così, ci sentiamo un po’ più legittimati a recensire l’opera rigettando a priori di proporre inquietanti paragoni col romanzo, anche in nome della scarsa filmabilità di default che si attribuisce spesso, ad esempio, ad H. P. Lovecraft. Se infatti lo scrittore di Providence è considerato da decenni molto difficile da rappresentare sullo schermo, Bulgakov probabilmente rasenta l’impossibilità e, di fatto, costringe a spostare il focus sulla regia e (non troppo) sullo script.
Ci sono due elementi fondanti questa riduzione filmica del romanzo di Bulgakov, che chiameremo “riduzione” in senso sia letterale che figurato, proprio perchè sarebbe stato insano proporre una versione uncut dell’opera, cosa che – a quanto pare – è avvenuto in una sola circostanza ed ha richiesto una lettura radiofonica di circa 20 ore. Le accuse di banalizzazione e riduzionismo a Petrović sono quindi, in partenza, frutto di un bias cognitivo molto radicato anche nell’animo di tanti cinefili che sanno il fatto loro, e che sarebbe il caso di mettere da parte.
Il maestro e margherita rimane ovviamente un film complesso e ricco di sottotesti, allusioni, allegorie e simbologie complesse da decifrare: al tempo stesso è chiaro come voglia essere una critica feroce al regime sovietico ed al suo materialismo dialettico, considerato dalla sceneggiatura un elemento esecrabile quanto in grado di appassire o degradare la realtà. I due elementi che caratterizzano l’opera di Petrović sono, a questo punto, il grottesco (che pervade l’intera opera con momenti davvero sublimi ed altri forse un po’ meno efficaci) e la drammatizzazione spinta nella recitazione degli interpreti. Di fatto la prima componente si declina con effetti speciali artigianali quanto coraggiosi nel loro impianto, con alcune sequenze che sconfinano quasi nell’horror oltre che nel fantastico.
Il feeling drammatico è di derivazione evidentemente teatrale, ed è anche chiaro che il parallelismo tra la storia di Pilato rispetto a quella del Maestro Nikolaj Afanasijevic Maksudov è giustamente rievocata durante lo svolgimento della trama. Proprio quest’ultimo personaggio è mirabilmente interpretato da Ugo Tognazzi, in una delle sue tante interpretazioni drammatiche, oltre che probabilmente uno dei motivi per cui il film ebbe una discreta popolarità anche in Italia. Maksudov si strugge perchè la sua arte non viene compresa, anzi viene boicottata dai burocrati sovietici, che dall’altro della loro arroganza e impunità non accettano la sua visionarietà, il suo andare oltre il “sacro” materialismo, meno che mai i riferimenti filo-anarchici di critica al potere come violenza.
Se volessimo individuare un difetto filmico, a questo punto, non possiamo fare a meno di citare alcuni apparenti vuoti narrativi che poi, di fatto, sono semplici pause prolungate: lo spettatore ci mette probabilmente un po’ a sintonizzarsi con questo aspetto, allo stesso modo in cui non faticherà a farsi affascinare dalla figura di Woland (un diavolo allusivo e potentissimo che, probabilmente, è un po’ il padre putativo di tanti altri demoni di forma umana visti sullo schermo di seguito).
Il film procede più speditamente di quanto quelle pause possano suggerire, e permette quasi di azzardare che la riduzione sia stata sintetica al punto giusto, nonostante qualche inevitabile fusione narrativa che i fan di Bulgakov quasi certamente criticheranno. Nonostante questo, il mio parere positivo non cambia, e vale la pena dare (o ridare) ancora oggi una possibilità a questo lavoro, a dispetto della sua età e del fatto che riesce a farsi amare, come pellicola, anche senza conoscere l’opera originale. E questo, anche se sembra incidentale o di poco conto, non andrebbe sottovalutato.