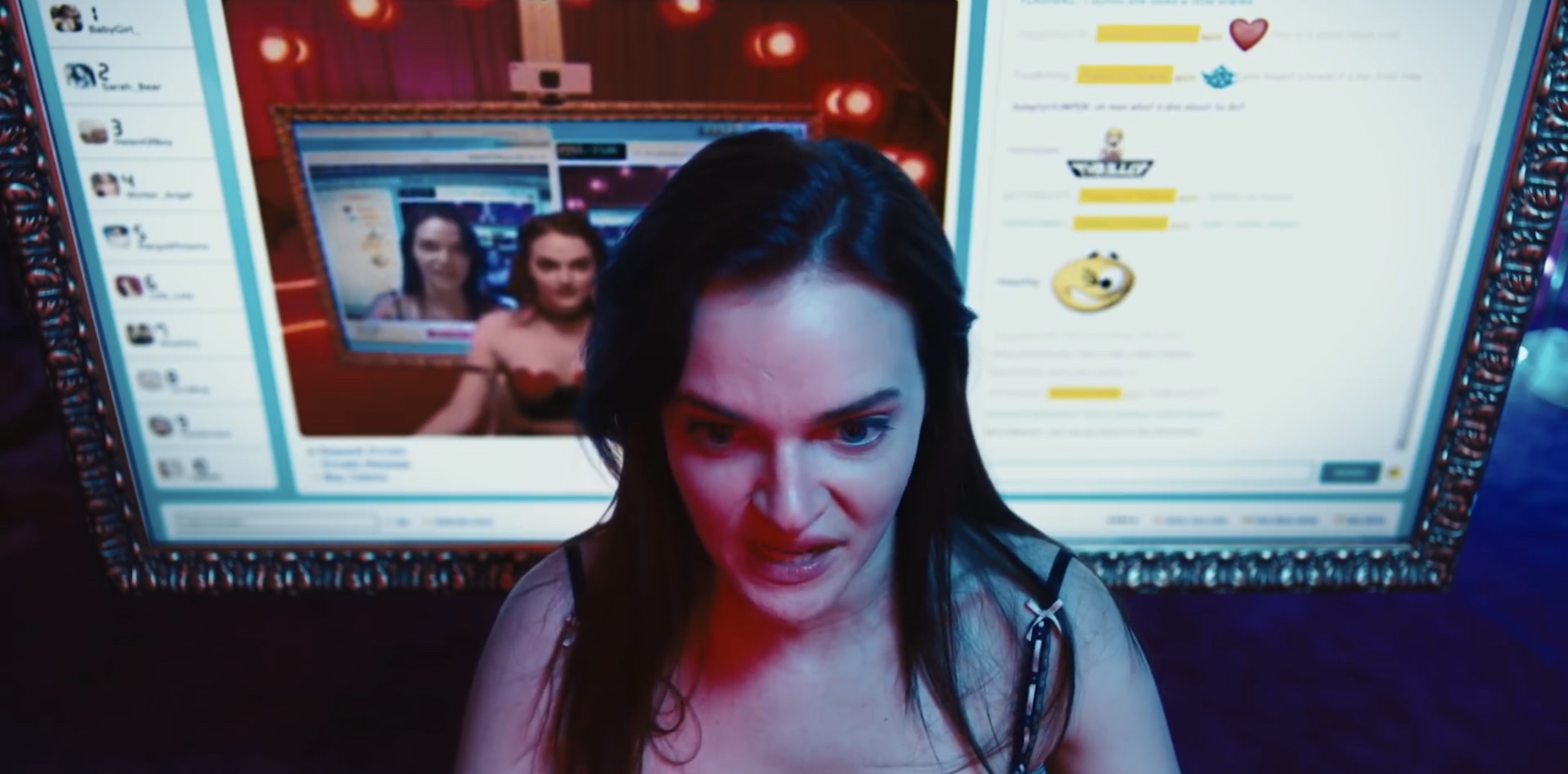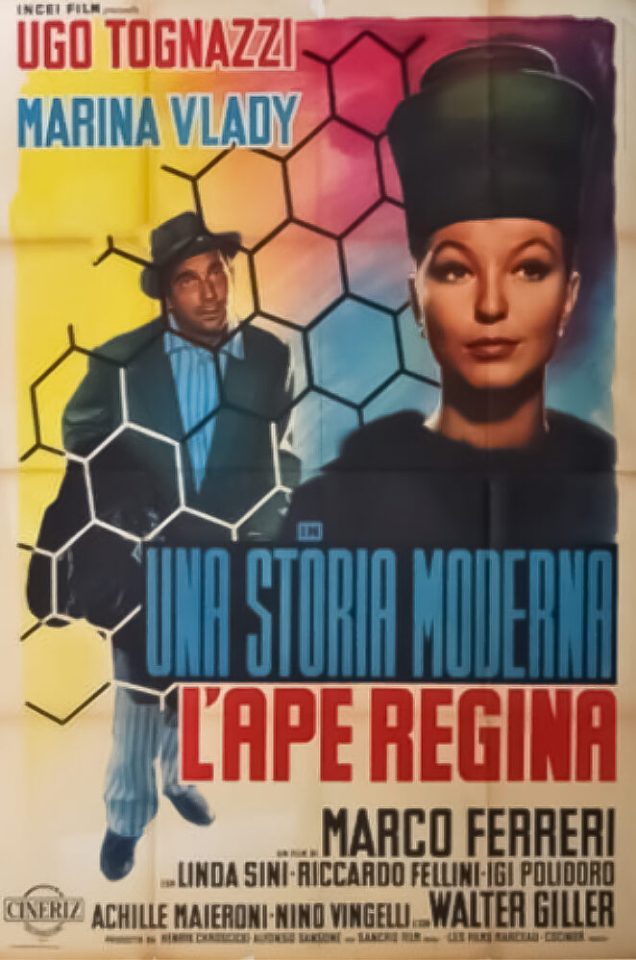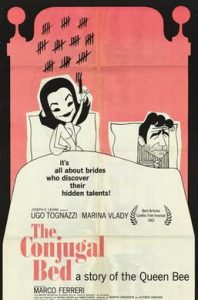Nel buio rosso e polveroso delle retrovie del cinema, Cigarette Burns (2005) di John Carpenter sembra raccontare un semplice collezionista di film rari. Ma come spesso accade in Carpenter, la superficie è solo una soglia. Kirby Sweetman, ex proprietario di cinema e ora cacciatore di pellicole perdute, riceve l’incarico di ritrovare un film maledetto, La Fin Absolue du Monde, proiettato una sola volta — e mai più. Chi l’ha visto non è tornato intero.
La storia scorre come una bobina che si srotola troppo in fretta: il desiderio di trovare il film coincide con la distruzione del soggetto. Kirby, segnato dal suicidio della compagna, si muove tra collezionisti ossessionati, mutilati dal bisogno di possedere l’immagine pura, quella che nessun supporto dovrebbe contenere. È la logica perfetta del capitalismo estetico: il feticcio dell’esperienza autentica, la promessa che dietro l’immagine ci sia ancora “qualcosa di vero”.
Ma il film che tutti cercano non mostra, lacera. Chi lo guarda smette di distinguere la visione dal vissuto. Le “cigarette burns”, i segni di bruciatura che indicano il cambio di rullo, diventano marchi dell’allucinazione: lembi di realtà che si strappano, ferite nel tessuto del visibile. Carpenter li trasforma in stigma, in punti dove la rappresentazione implode e rivela il suo fondo materiale — il sangue, la celluloide, la perdita.
Il corpo dell’angelo incatenato, che Kirby scopre prigioniero nel covo del collezionista, è la figura più radicale del film: la verità catturata, torturata, ridotta a spettacolo. È ciò che ogni immagine contiene ma rimuove: la sofferenza necessaria alla sua esistenza. E quando Kirby infine trova la pellicola e la proietta, non cerca più la conoscenza, ma l’assorbimento — la fusione totale tra spettatore e immagine, fino al punto in cui non si distingue più chi guarda da chi è guardato.
Trivia IMDb: Norman Reedus raccontò che Carpenter, durante le riprese, gli disse di “non recitare”, ma di “lasciare che il film lo consumasse”. Il sangue usato nella scena finale era vero sangue animale, per rendere la consistenza più “organica”. Udo Kier, che interpreta il collezionista, dichiarò che il suo personaggio “non ama il cinema, lo divora”. (imdb.com/title/tt0425055/trivia)
Carpenter costruisce così una parabola sulla visione come peccato originale: la sete d’immagine è la condanna, e l’unico modo per purificarsi è bruciare la pellicola — e con essa, la propria identità. Nessuna redenzione, solo la consapevolezza che ciò che chiamiamo arte, quando viene spinta oltre la soglia, non illumina: carbonizza.