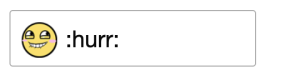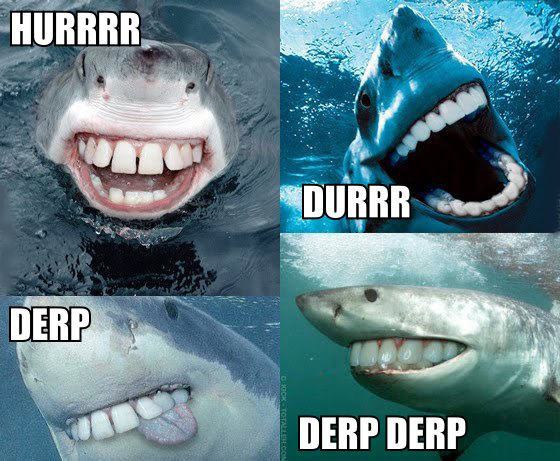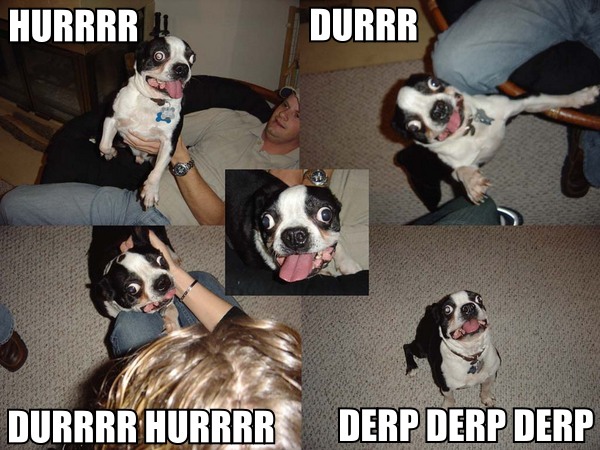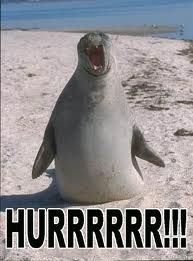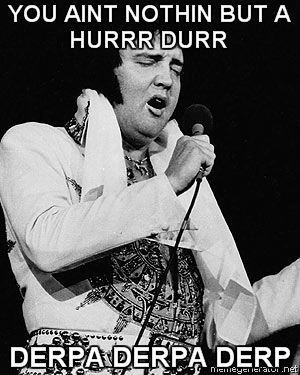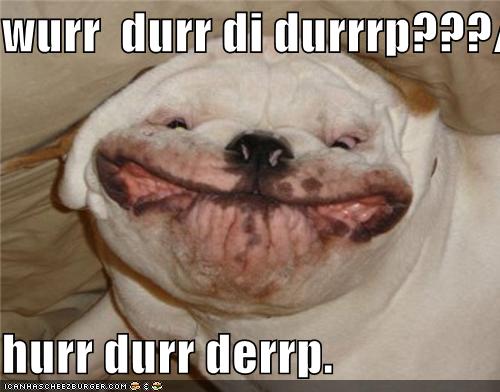La parola coerenza deriva dal latino cohaerentia (l’essere unito) e tende generalmente ad assumere una valenza mentale, oltre che di presunta “solidità” psicologica. Se sei coerente voilà, sei a posto (in apparenza): è come essere credente in chiesa, metallaro a un concerto, con mille pagine già battute di fronte al tuo editore. È nell’ordine delle cose, essere coerenti, e soprattutto ordina le tue cose: sei coerente, per cui agisci secondo i tuoi principi e tanto basta. Del resto coerenza è il contrario di disomogeneità, disorganicità, frammentarietà, rappresenta lo stare uniti, stare assieme, usando un termine desueto potremmo anche dire sentirsi agglutinato, che fa presa con gli altri e dentro di te. Agglutination era (è stato) un celebre festival metal nonchè una delle rare occasioni di aggregazione metallara nel sud Italia. Nulla di male nella coerenza, insomma, e non sarà certo un articolo a far cambiare le cose. Coerenza intesa come generica costanza logica o affettiva nel pensiero e nelle azioni, come da manuale, non farebbe mai di per sè urlare allo scandalo in alcun modo, anzi. Il problema sta altrove (come sempre, direbbero i benaltristi).
Esiste una forma di coerenza che non ci piace, e non riusciamo ad ammetterlo. Non la troviamo un valore desiderabile o, quantomeno, offre meno vantaggi e cose di cui andare orgogliosi di quanto potrebbe sembrare. La coerenza va sempre contestualizzata e compresa a fondo, prima di considerarla un valore positivo. Del resto già Sigmund Freud aveva notato, nella sua Psicologia delle masse, che un manipolatore che volesse condizionare un gruppo di persone
non ha bisogno di coerenza logica fra i propri argomenti; deve dipingere nei colori più violenti, esagerare e ripetere sempre la stessa cosa.
Gli strumenti di comunicazione ambigui, pericolosi e potenzialmente minacciosa della democrazia – intesa nel senso più ampio del termine, non solo politico ma anche sociale, emotivo ed economico – sono quelli della manipolazione, dello sfruttamento di bias cognitivi radicati nell’uomo fin dalle sue origini. Non fanno leva, questi strumenti, sul semplice fatto di sentirsi tranquilli perchè (mantra rassicurante) “ci siamo comportati come sempre abbiamo fatto“, “siamo stati coerenti e va bene così“. La coerenza di base permette di costruire senso e personalità alla vita, ovviamente, ma può diventare un’arma infida che potrebbe rivoltarsi contro. La coerenza ostentata aiuta a renderci unici o inimitabili (e neanche sempre) ma può portare, in altri termini, a ripetere sempre gli stessi errori e/o pattern, cosa che molte band metal dopo aver prodotto capolavori negli anni 80 e 90 hanno finito per fare, diventando una parodia del genere.
La coerenza è anche un modo per arroccarsi nelle proprie posizioni senza dare spazio all’altro, anzi investendolo di insulti e umiliazioni (peggio che peggio sui social, sfruttando l’illusione dell’anonimato digitale). Diventiamo parodie di noi stessi con il paravento della coerenza.
Lo scrittore Ralph Waldo Emerson parlava, a riguardo, di uomini perennemente con la testa dietro le spalle, timorosi di essere ciò che vorrebbero essere, spaventati dall’idea di fare alcune cose o di pensarle (tra cui il diritto di cambiare idea, uno dei tabù del mondo moderno), alla ricerca di una fantomatica coerenza con il passato o, per dirla con le sue parole:
Perché trascinarti dietro il cadavere della memoria, per paura di contraddire quel che hai detto e fatto in questo o quel luogo pubblico?
Perchè, in altri termini, usare la coerenza come paravento per negare, negandosi a se stessi e agli altri, impedendosi di migliorare le cose per una malintesa forma di “coerenza” col proprio passato? Il punto dovrebbe essere esattamente questo, ed è proprio questa frase ad aver ispirato questo insolito rant contro il mito della coerenza ad ogni costo e in ogni dove.
Perchè in fondo la coerenza può cedere il passo all’intelligenza, e qualora diventasse cristallizzata, morbosa o spigolosa può diventare qualcosa di cui preoccuparsi, da correggere, limare e lavorarci su. Fermo restando che la sua variante sana ha pieno diritto di esistere, e che potrebbe essere almeno un faro in grado di guidare le nostre vite e la sanità delle nostre azioni, con l’elasticità di liberarcene quando non ci serve e riprendercela se ne abbiamo davvero bisogno. La coerenza come scusante per non essere … no, non dovrebbe albergare in nessuno di noi.
L’incoerenza può essere una linea di fuga da logiche troppo stringenti in cui non ci riconosciamo più.
Photo by Raamin ka on Unsplash