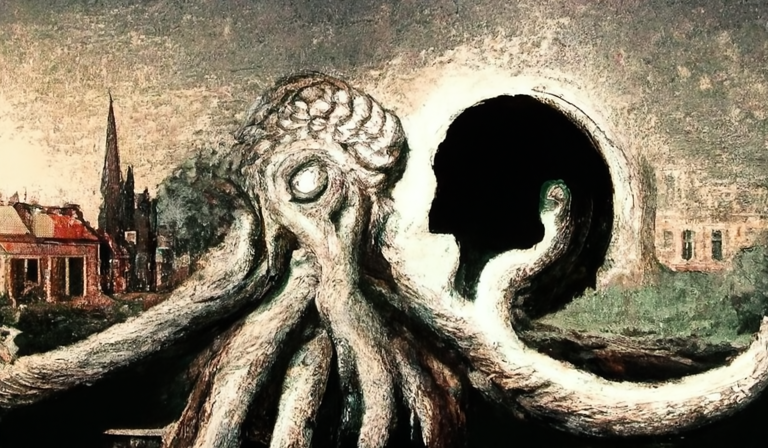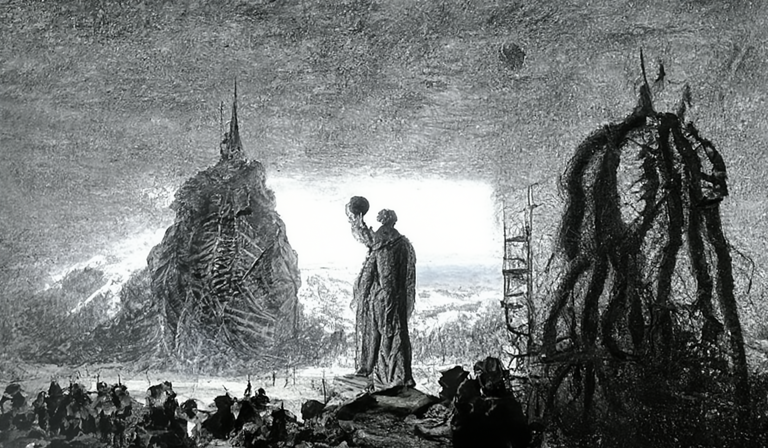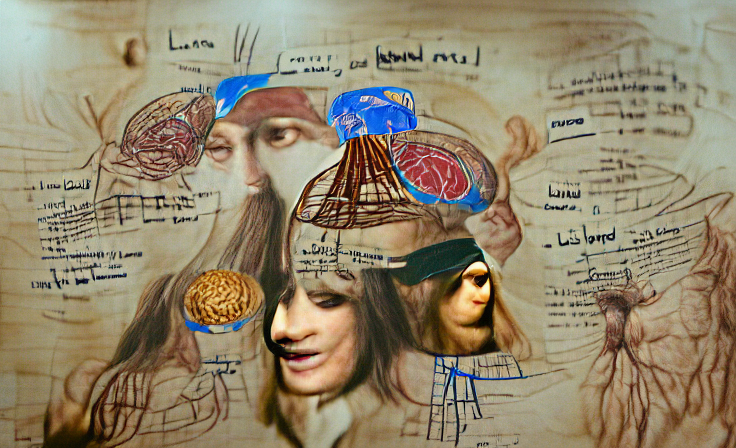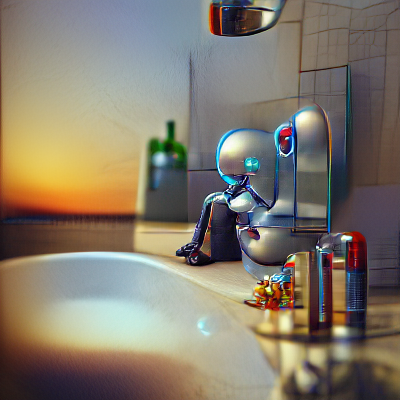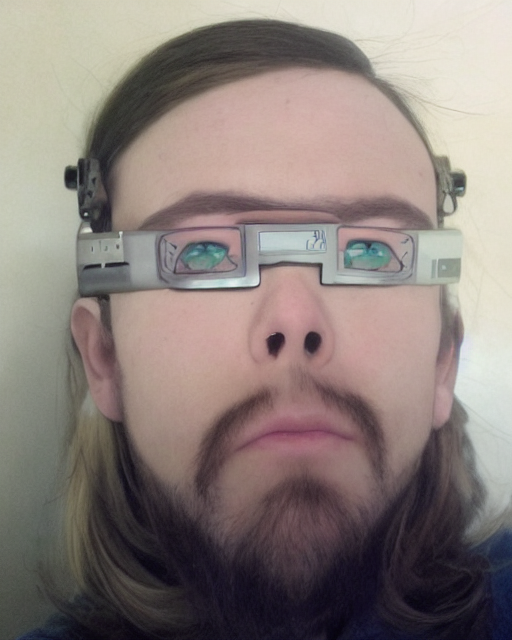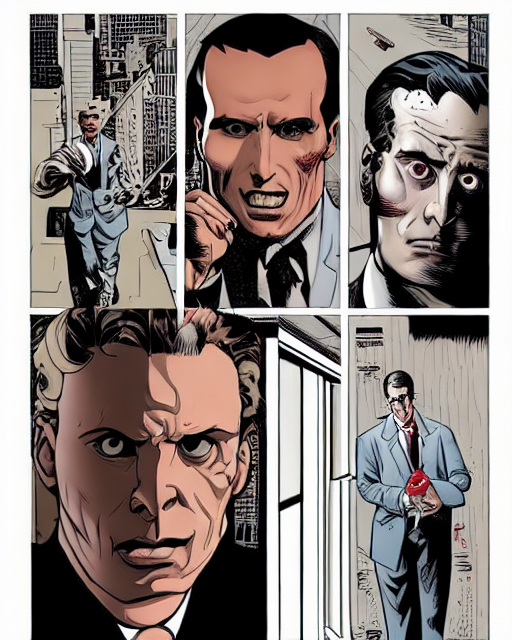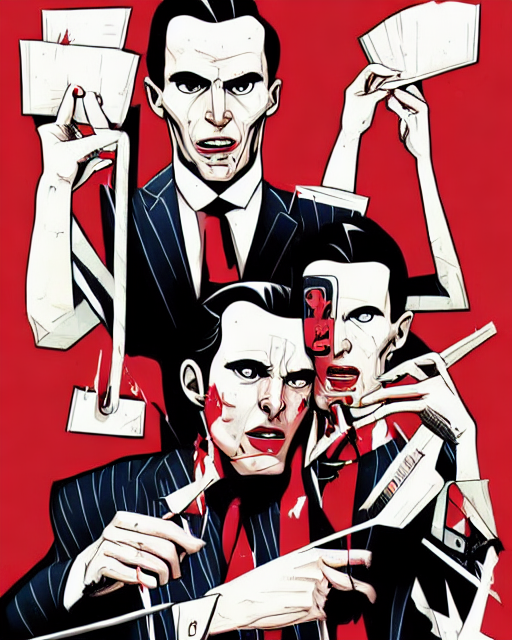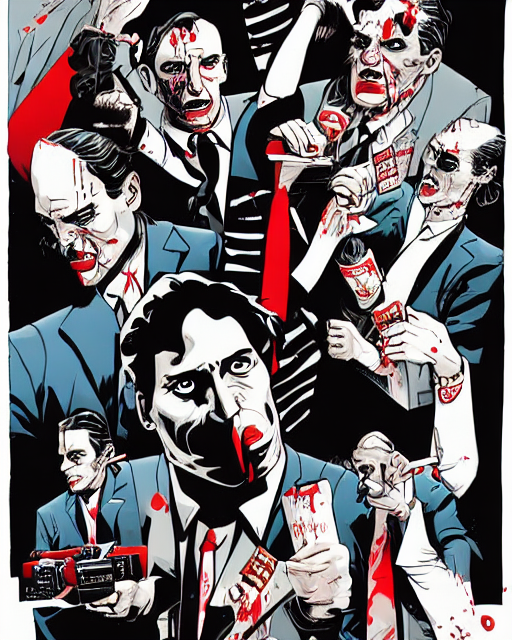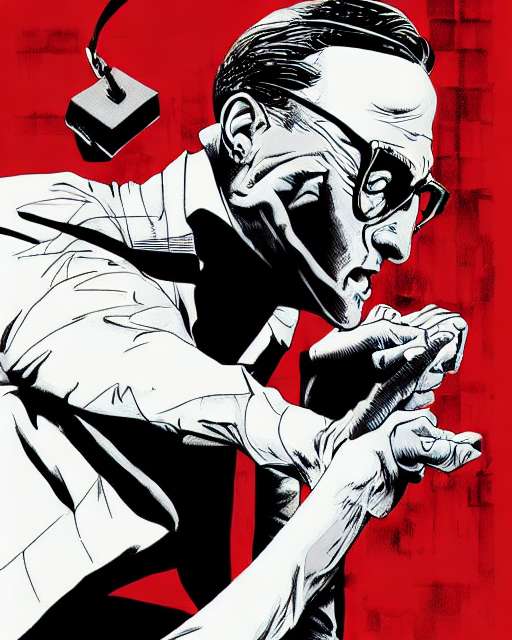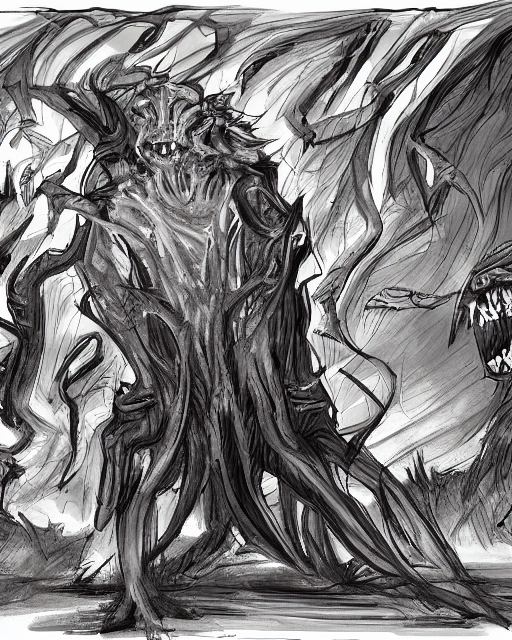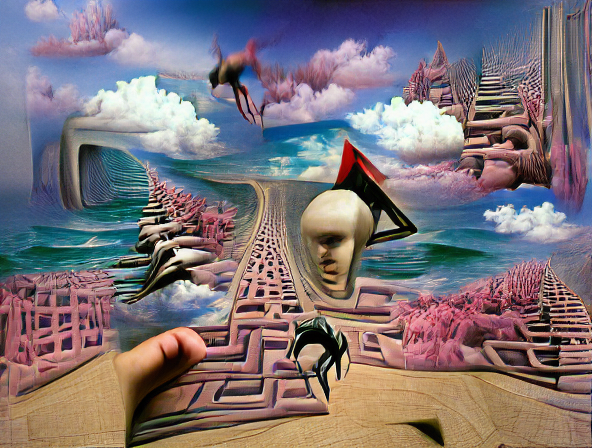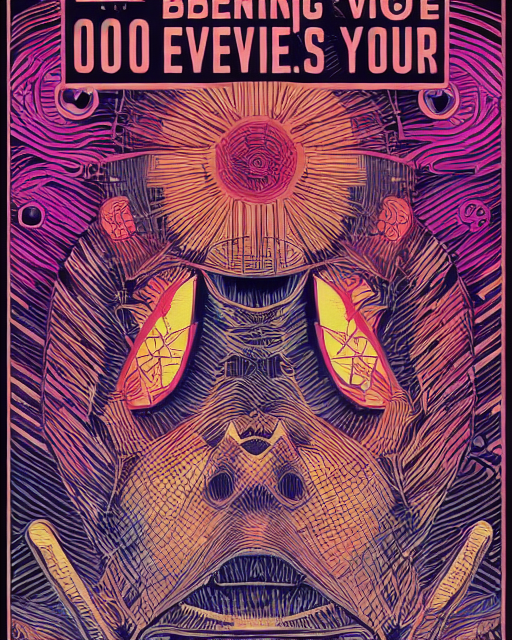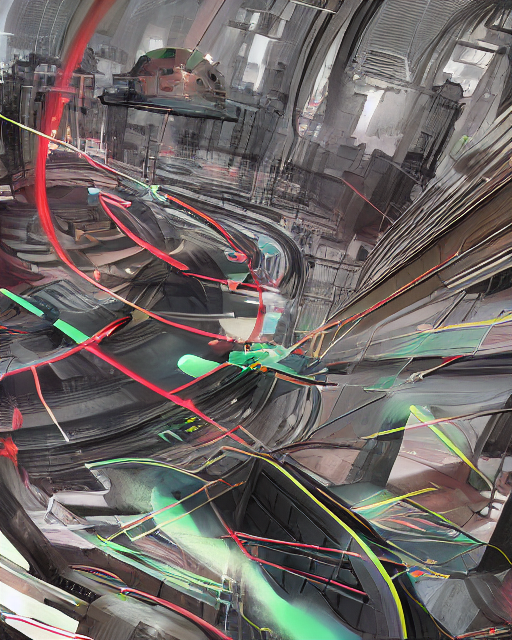In alcuni casi, i creepypasta video presenti su Youtube sembrano più che altro sensazionalismo o informazione di bassa qualità, cosa che sorbiamo periodicamente anche dalle nostre parti, del resto, e che non è il caso di approfondire (alcuni esempio possono essere quelli del bambino ventriloquo, del fantasma in pieno giorno o di certi video di avvistamenti fantasmi o UFO). In altri casi, la creepypasta – una storia horror breve ma intensa, per definizione – è perfettamente attinente, e siti come Reddit sono letteralmente zeppi di contenuti di questo tipo. Molti creepypasta celebri in passato, del resto, sono stati cancellati per sempre, e a meno di recuperarli per vie traverse o se qualcuno ne avesse una copia nei propri dischi sconnessi dalla rete, difficilmente potremo mai rivederli.
Quasi tutte le creepypasta citate, per inciso, sembrano semplicemente video horror ultra-amatoriali realizzati più o meno bene, i migliori dei quali hanno ottenuto effetto virale.
La posizione antibufala in merito, del resto, è quasi sempre assodata (quindi tutti i video non sono reali, senza eccezioni) per quanto possa sembrare a volte contraddittoria insoddisfacente: si assume che quasi tutte le creepypasta non siano reali, e si ispirino più che altro a leggende urbane raccontate in forma di video, un po’ come avvenuto per il revival degli horror POV e realistici modello [REC] diffusi nei cinema fino a qualche anno fa. C’è ad esempio, su questa falsariga, il cortometraggio Still Life, che rientra nel novero del genere per quanto non sia esattamente una creepypasta vera e propria (che in genere sono al più film amatoriali).
Nulla rende meglio l’idea della diffusione ed il successo di queste video-storie se non il fatto che, per convenzione perturbante, vengono credute reali anche se sappiamo bene non esserlo.
Avvistamento di un magnapinna
Le profondità dei mari sono ancora poco studiate e il magnapinna rientra tra gli animali più misteriosi che vivono tra quelle oscurità.
Bigfin Squid

Video del Tuyul
Sul modello di [REC] esiste un video che si chiama semplicemente Ghost, e che vanta molte visite e sul quale non sembrano disponibili molte informazioni in merito. La qualità è bassa, la questione è un po’ confusa e certi aspetti del video non sembrano troppo credibili, ma le visualizzazioni sono state più di 500.000 ad oggi. Se facciamo una lista di creepypasta video è impossibile non citare il Video di un tuyul, un demone della tradizione indonesiana, che nel video appare sul divano con effetto scary jump assicurato.

Meow meow I am a cat
Meow meow I am a cat
Rientra a pieno titolo nel bizzarro sul web, se non proprio nelle creepypasta. Quasi due milioni di visualizzazioni ad oggi per il creatore di questa animazione.
No Through Road di Steven Chamberlain rientra in una delle migliori produzioni del genere, afferente al POV horror realistico e spacciato come storia vera: questo fin dalla sua iniziale distribuzione nel lontano 2009. Si tratta del nastro ritrovato da parte delle famiglie di alcuni ragazzi scomparsi, che testimoniano le loro ultime ore di vita. Il filmato possiede elementi parecchio interessanti al proprio interno, e valorizza l’aspetto orrorifico di qualsiasi creepypasta: le apparizioni improvvise di figure oscure che si stagliano in lontananza, poi si avvicinano. Come la minaccia di You’re next, in questo No Through Road i villain sono uomini mascherati e minacciosi e dalla forza sovrumana, mentre l’orrore esce fuori soprattutto dalla geometria dei luoghi: una volta varcato il confine con il cartello che da’ il nome alla saga, non c’è modo di uscirne, e qualsiasi tentativo di andare via riporta i ragazzi nello stesso punto di prima, come in una spirale lovecraftiana (essere puniti o sentirsi in colpa per aver varcato un limite del Grande Altro). Un horror circolare, semplice e terrificante nel suo insieme, girato con buona qualità e ben lontano, per inciso, da certe altre produzioni troppo ostentatamente amatoriali.
Il film è suddiviso in quattro parti, reperibili ad oggi su Youtube (anche solo la prima rende perfettamente l’idea).
Max Headroom Pirating Incident
Max Headroom Pirating Incident non è una creepypasta vera e propria, ma poco ci manca: la storia vera di una delle prime incursioni hacker nella storia della televisione americana, con quest’uomo mascherato che si intromette nel canale di comunicazione dell’emittente TV e si diverte a trasmettere se stesso per diversi secondi mentre balla e delira in diretta nazionale. Alla base dei fatti una banale disattenzione del tecnico incaricato della trasmissione, a quanto sembra. L’identità di Max Headroom è rimasta ignota fino ad oggi.
The Wyoming Incident
Versione “alternativa”, molto simile e meno nota del caso di Max Headroom, per quanto abbia una parvenza più costruita a tavolino si tratta di un altro caso di incursione TV non prevista. Secondo questo sito si tratterebbe dell’opera di un hacker riuscito a interrompere le trasmissioni da un canale di programmazione locale (che si ritiene servisse diverse comunità più piccole nella contea di Niobrara, negli USA) e ha mandato in onda il proprio video. Il video conteneva numerose clip con visi umani in varie pose. Nella narrazione da urban legend della storia, la visione del video provocherebbe vomito, mal di testa e addirittura allucinazioni, per via delle particolari tonalità di colore e frequenza di riproduzione utilizzata.
The Wyoming Incident
There Are Monsters
Questo cortometraggio, fondato essenzialmente su un mood misterioso e sui primi piani ai suoi grotteschi personaggi, esprime forse al meglio lo spirito dei creepypasta, e li rende un film patinato e ben realizzato, tanto da finire nella selezione del London Film Festival nel 2008.
There Are Monsters
Maskie
Si tratta di una storia postata il 4 luglio 2012 sulla versione di 4chan dell’epoca, e che mostra il video di una figura accovacciata e non visibie che sembra pregare. Sembrerebbe essere il video degli omicidi di un killer girati in prima persona, se si vuole credere alla sospensione di incredulità, e sul quale non sembrano disponibili molte altre informazioni ad oggi. Sicuramente tra le creepypasta più suggestive di sempre.
You Will Never Find Me
The Gable Film
In questo caso si tratta di un cortometraggio, girato da Mike Agrusa, diventato virale sul web nell’anno 2007. Presenta l’apparizione di una strana ed ignota creatura, il Michigan Dogman, una sorta di quadrupede di colore bianco e dalla parvenza quasi umanoide. Figura appartenente al folklore americano, in The Gable Film si tratterebbe dell’unico video che ne mostra uno autentico.
Il figlio di Aaron Gable sale in sella alla propria motoslitta per compiere le proprie consuete attività: bere birra, spaccare la legna, andare in motoslitta. All’improvviso un cane non si accorge di qualcosa che non va, finchè non viene avvistata una creatura che cammina a quattro zampe nella foresta. Gable ferma il camion per cercare di riprenderlo, ma non è una buona idea: l’animale resta fermo da lontano, poi sembra attaccare il cameraman. La creatura si vede da vicino solo per un attimo, prima che l’operatore cada evidentemente a terra.
The Gable Film
Altro caso di creepypasta virale sul quale non si sa molto: un video dai tratti psichedelici che mostra varie immagini grottesche in alternanza, e che produce quella che potrebbe essere definita la pertubanza, ovvero quel mix di familiarità delle immagini e paura indotta dalle stesse tipica di qualsiasi horror ben realizzato.
FACE
Body of a pig
Altro creepypasta molto suggestivo e spaventoso, con colpo di scena finale (in inglese con sottotitoli).
Body of a Pig EVP
(Foto di copertina generata via Starryai)