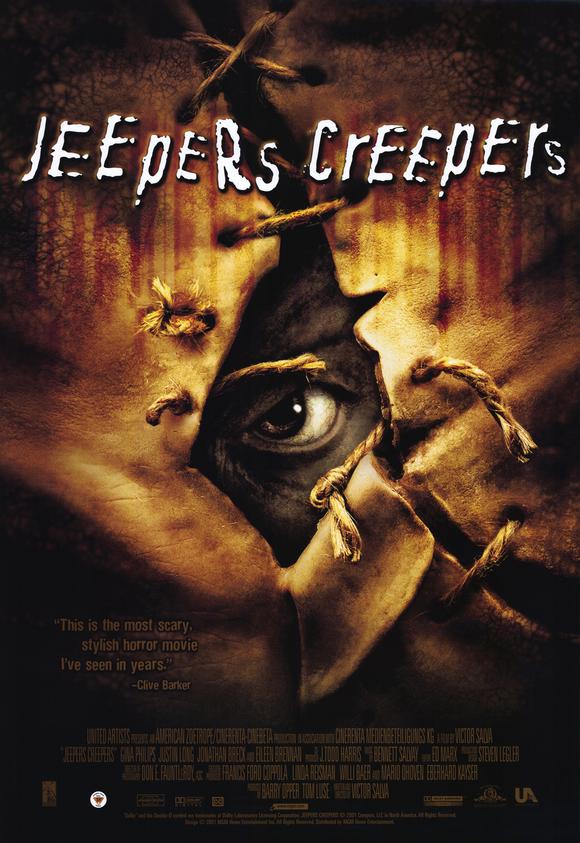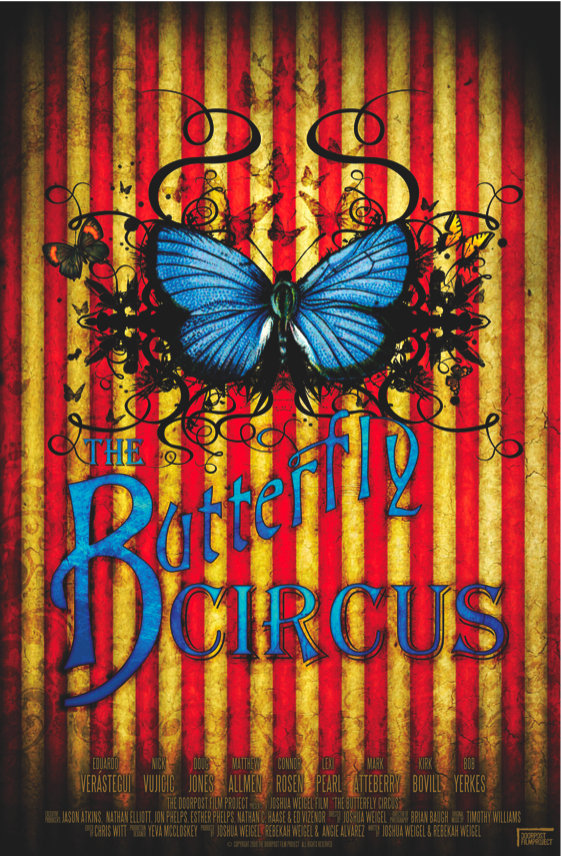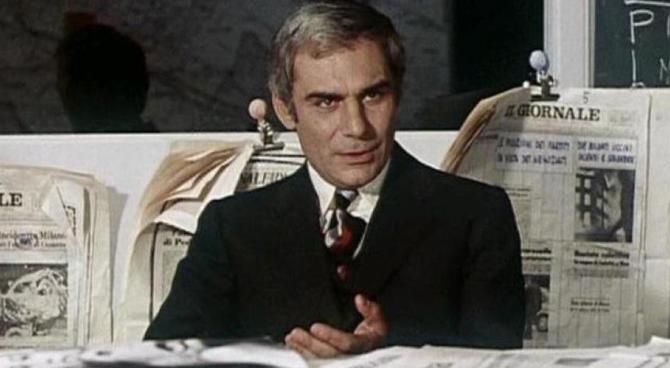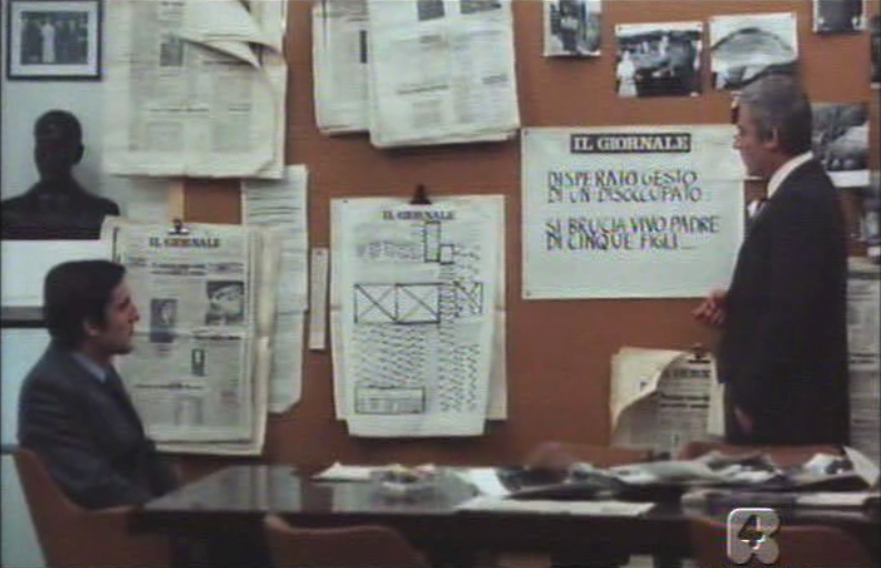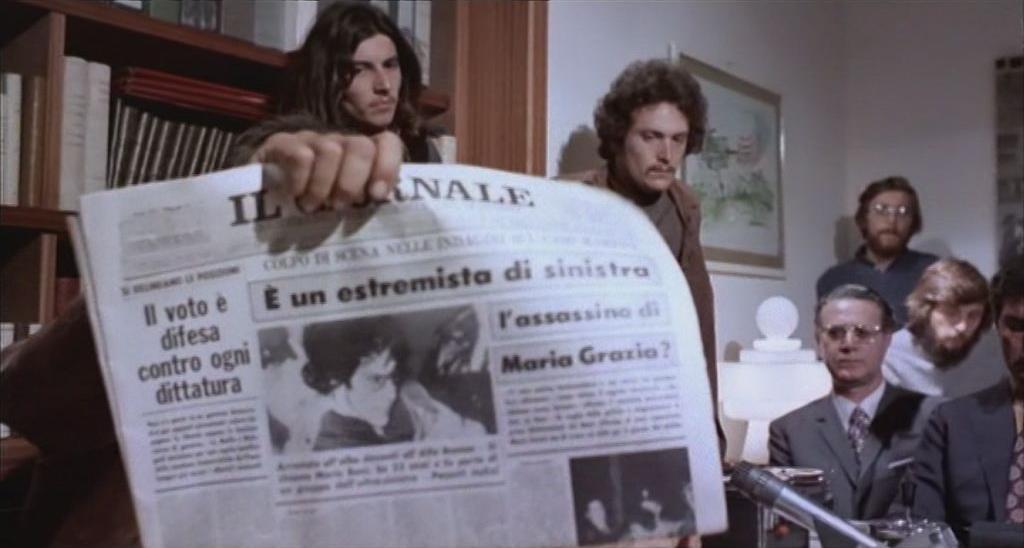In pochissime parole The substance è un film sul tema del doppio, ben oltre i canoni del sottogenere e ricco di cinematografia horror classica come non se ne vedeva da tempo. Un lavoro complesso, stratificato su almeno due direttive (la società dello spettacolo e la questione femminile) e che fa ampio uso dei canoni cinematografici tipici dei classici dell’horror anni Ottanta. Un tema, quello del doppio, da sempre al centro di cinematografia e letteratura mondiale, declinato come espressione della crisi di un personaggio in senso universale, sociologico: “il” conflitto per eccellenza. Un sottogenere di film, quelli incentrati sul doppio (Doppelganger) che suggerisce, da che mondo è mondo, miriadi di metafore sociali, psicologiche ed esistenziali. Il punto è che una discreta parte di queste pellicole si limitano a esibire l’aspetto scenografico limitando l’apparato simbolico, o al limite fanno l’esatto opposto con risultati comprensibili a pochi. The substance trova un equilibrio anche in questo, e tanto basta.
Film del 2024 della regista Coralie Fargeat, al suo secondo lungometraggio dopo Revenge, rientra nello spinoso novero degli horror sociologici, e presenta un body horror (l’horror incentrato sulla genetica del corpo e sulle sue degenerazioni), sulla falsariga di come l’avrebbe concepito David Cronenberg in quel gioiello noto come Inseparabili (la storia, per chi non lo ricordasse, di due gemelli chirurghi che si scambiano e confondono i rispettivi ruoli). Ma si dirige con maestria, essenzialità e gusto del macabro strizzando l’occhio a uno degli horror sociali più famosi di ogni tempo: Society di Brian Yuzna, un mini trattato sociologico, anche stavolta in chiave grottesca, del mondo ipocrita delle apparenze e dei VIP. C’è realmente tutto, dentro The substance, senza neanche l’esigenza di esibire autoindulgenza, richiamarsi ad una pompa magna cinefila fine a se stessa, senza autocelebrazione, senza pretenziosità, senza l’ossessione del riferimento culturale da nerd che finirebbe per dare più fastidio che altro. Al netto degli eccessi di un finale esageratamente gore (e forse un po’ troppo lungo, che abbiamo deciso di non rivelare per non togliervi il gusto di scoprirlo da soli) The substance non lascerà il pubblico indifferente, specie se paragonato al precedente lungometraggio della Fargeat quasi sulle stesse tematiche che, a dirla tutta, aveva convinto solo in parte. E le tematiche sono e rimangono di genere, naturalmente: patriarcato, questione femminile, parità di diritti, tutti declinati in chiave splatter.
Non a caso Peter Bradshaw ha scritto sul The guardian che Roger Corman avrebbe certamente amato The substance, dato che è un’opera imbevuta di riferimenti smart ai classici del genere: Society, La cosa di John Carpenter – e potremmo spingerci addirittura fino a Elephant Man di David Lynch. The substance è probabilmente uno dei migliori esempi di horror splatter moderno per il quale la metafora è tanto ben costruita da evocare uno studio scientifico di genere, e per cui i dettagli fanno la differenza (anche quelli più apparentemente insignificanti: su tutti il fatto che i produttori televisivi siano rappresentati sempre e solo come maschi di età avanzata). Non a caso, il film si apre con l’immagine di un uovo nel cui tuorlo viene iniettato quello che si scoprirà essere un siero per ringiovanire le persone, il quale produce la scissione del tuorlo in un doppio identico per partogenesi (anche qui, non a caso, un processo di fecondazione senza spermatozoi).
La società delle apparenze di THE SUBSTANCE non è solo e semplicemente bigotta e conformista: è imbevuta di cultura patriarcale, di un mansplaining irritante e superbo, di aspettative sociali irrealizzabili quanto ambite, intollerabili per qualsiasi donna che, di sicuro, mai potrà mantenersi “giovane & bella” come vorrebbe (o meglio, come il mondo maschile si aspetta). Il mito dell’eterna giovinezza evocate sulle prime, pertanto, diventa un pretesto per costruire un horror femminista, sulla falsariga di Revenge della stessa regista e con maggiore consapevolezza di stile, mezzi e modi, più centrati in questo caso sull’horror puro che sulla exploitation. Con le idee più chiare sul messaggio da recapitare al pubblico, con l’idea che il cinema possa ancora, contrariamente all’aspetto meramente speculativo amato dalla maggioranza dei cinefili, essere espressione di critica sociale in senso praticamente marxista. Woke, diranno i detrattori!
Del resto The substance è anche un corposo splatter incentrato sulle mostruosità della società dello spettacolo, lo stesso spettacolo che secondo Guy Debord consiste in “un rapporto sociale fra individui mediato dalle immagini“. Non bisogna, in altri termini, limitarsi a vedere l’aspetto esteriore delle immagini patinate delle atlete di aerobica perfette quanto sessualmente allusive, ma bisognerebbe considerarle frutto di un contratto, di una burocrazia televisiva che pretende di conoscere e modellare i gusti del pubblico (qualsiasi cosa si voglia intendere con esso), in uno scenario di un mondo maschile tendenzialmente gretto quanto ambivalente – qui rappresentato come volgare e irrispettoso verso le donne più avanti con l’età quanto servile e disponibile, grottescamente, nei confronti delle giovani.
The substance, col suo incendere inesorabile ed essenziale (e la sua forma prima da thriller, poi da body horror, infine da splatter puro con tanto di litri di sangue che sgorgheranno da ogni dove), racconta una storia ambientata ai giorni nostri che (probabilmente non a caso) strizza l’occhio agli anni Ottanta (come fa anche Maxxxine, ad esempio). Serve a creare un riferimento culturale ben riconoscibile ma, a ben vedere, se esistono le penne USB non possono essere gli anni Ottanta. Perchè forse non è quello il punto: e allora diciamo sì all’immaginario iconico da fitness televisivo (inteso non in termini salutisti, ma puramente estetici), e rappresentiamo un mondo in cui la chirurgia estetica si potrà fare anche in casa. Il fai-da-te che osanna l’individualismo sfrenato del mondo in cui viviamo, per cui non esistono che post verità ed ognuno, letteralmente, si fabbrica in casa la propria, arrivando a rimodellarsi il corpo in autonomia. Al tempo stesso, il rapporto sociale in gioco è tra la donna e la società di oggi, ovviamente patriarcale, una donna ridotta a blanda fisicità, a forme sempre perfette, invidiabili, prive di imperfezioni; una donna pressata ossessivamente ad essere bella quanto passiva, sempre sorridente, presente agli eventi, socialmente impeccabile, sessualmente attiva.
Elisabeth (Demi Moore) conduce un programma televisivo sul fitness per cui tutto sembra andare per il meglio, dato che il pubblico la segue con interesse e lo show gode di grande successo. Dopo aver finito le riprese di una puntata, proprio nel giorno del suo cinquantesimo compleanno, sente casualmente il suo produttore fare considerazioni sulla necessità di sostituirla con una showgirl più giovane. La circostanza la manda in crisi esistenziale: poco dopo fa un incidente d’auto, da cui esce miracolosamente illesa. È a questo punto che un ambiguo infermiere le consegna una chiavetta USB con su scritto THE SUBSTANCE – il film sarà periodicamente intervallato da queste scritte emblematiche, tutte in maiuscolo, che sembrano assolvere una funzione analoga a quella dei cartelli portati in scena dal teatro brechtiano.
La chiavetta contiene la pubblicità di una misteriosa azienda che si occupa di chirurgia estetica “fai da te”, in grado di fornire un kit per far ringiovanire chiunque volesse farlo. Da questo acquisto Elisabeth sarà effettivamente rigenerata e potrà proporsi al suo stesso programma in veste di Sue (Margaret Qualley), con l’unico dettaglio che il suo corpo non è stato propriamente sostituito, ma si è scisso in due: i due corpi sono dipendenti tra loro, hanno bisogno di essere alimentati periodicamente e uno potrà trarre giovamento dall’altro, come un parassita. È una situazione puramente cronenberghiana, a ben vedere, tipica del body horror di ogni latitudine, in cui da un lato c’è l’ossessione per l’estetica perfezionista (e la critica sottintesa al fatto che una donna che passa i cinquanta anni debba ricevere un trattamento sociale ben più crudele di quanto avvenga per l’uomo), dall’altro c’è l’ossessione per uno spettacolo artefatto e mortifero, che “deve” andare avanti ad ogni costo. E in ultimo, ma non ultimo come importata: la lotta tra i due corpi giovane / anziano di Elisabeth e Sue non esiste, non è mai esistita e mai potrà esistere, perchè è solo l’ennesimo conflitto interiore di una donna: un’allegoria talmente potente da dare l’impressione di uscire dallo schermo durante la proiezione.
Sue non sarà pertanto solo l’alter ego giovane, dinamico, bello e propositivo di Elisabeth: ad un certo punto inizierà ad (auto)abusare del suo vecchio corpo, per egoismo ed avidità personale, mentre Elisabeth sarà sempre più sola, affranta e sregolata emotivamente per la scelta compiuta. Con risultati sempre più devastanti, come prevedibile, e con il merito da attribuire alla regia di aver costruito un horror compatto, molto ben girato, privo di fronzoli e che sicuramente farà discutere (farà discutere soprattutto chi percepirà l’opera come un attacco allo status quo, e che finirà per rilevarne difetti inesistenti).
In definitiva ci sono discrete probabilità che con The substance Coralie Fargeat (classe 1976, che firma regia e sceneggiatura) sia rientrata con questo film nell’olimpo dei cult, dei film che rivedremo anche in futuro nelle retrospettive, affiancandosi a mostri sacri del cinema horror come Cronenberg e Carpenter. Non a caso, forse, tra le prime donne a muoversi (finalmente) in questa direzione.