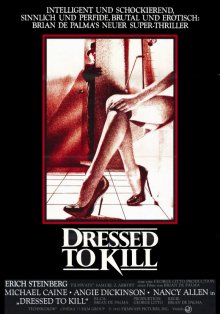Apparentemente morto nel capitolo precedente, il crudele villain con la maschera inespressiva Michael Myers è tornato sulle scene.
In breve. Molto simile al primo episodio, ne costituisce un prosieguo naturale e funziona, a conti fatti, solo in parte. Non esente da difetti, ma certamente dignitoso.
Secondo episodio del reboot di Halloween di John Carpenter, che segue direttamente – e senza troppi preamboli – l’ottimo capitolo precedente girato da Rob Zombie: era francamente difficile bissarne le qualità (sempre soggettive, ovviamente, ma a mio parere è inequivocabile ci siano), ed il nostro regista riesce solo in parte nell’impresa. Lo fa, peraltro, impreziosendo la pellicola con spunti onirico-surreali del tutto assenti dal feeling generale della saga (la visione del cavallo e della madre di Michael, entrambi in bianco), che servono soprattutto a spezzare quella che, in mano ad altri registi, avrebbe rischiato di diventare monotonia. D’altro canto, pero’, si evidenzia il lato isterico e spaventoso della psiche di Laurie, che ignora di essere sorella di Micheal Myers ed accentua, per questo, il proprio lato più oscuro. Se in generale poteva essere uno spunto interessante, in certi momenti questo sembra un po’ monocorde.
Il livello di splatter è prevedibilmente alto anche qui, con una sorta di seguito naturale delle vicende narrate in precedenza, e che mi pare opportuno vedere prima, per evitare che molti dettagli scorrano troppo velocemente senza comprenderne il senso. In questo Zombie è ancora una volta magistrale: il suo horror è rapido (in certe scene d’azione, forse troppo), diretto, essenziale e ricco della giusta dose di gore, che viene spiattellata in modo inesorabile ad un pubblico che, forse quasi esclusivamente, lo ama per questo motivo. Già Zombie aveva sfatato il tabù dell’intoccabilità dei classici, facendo togliere la maschera a Myers (una cosa impensabile, ai tempi dell’uscita), arricchendo la trama di un certo senso onirico e simbolico (sul cavallo bianco ed il suo significato ci sono varie interpretazioni), rielaborando la storia come se fosse un soggetto proprio – ed in effetti lo è: probabilmente la sua è anche l’unica strategia per dare dignità al concetto, perlopiù travisato, del fare un remake.
Un problema di fondo di questo film è anche legato alla sua indistinguibilità dalla miriade di seguiti anche precedenti: non si tratta di Halloween II degli anni ’80 (quello che Carpenter sceneggiò e fece girare ad un esordiente Rosenthal), ovviamente, per quanto addirittura alcune scene siano simili (Myers nell’ospedale, ad esempio). Soprattutto – per certi versi – la rilettura della saga proposta dal regista, pur validissima nel suo esordio, in questa sede sembra smarrire un po’ di mordente, nonostante i tributi (vari horror classici ed uno al Rocky Horror Picture Show, con le tre ragazze vestite da Magenta, Columbia e Frank-n-further), riuscendo di meno a sorprendere e riavvolgendosi a spirale su idee già note, sia pur con l’apparizione improvvisa ed inquietante della madre di Michael, sempre accompagnata dal figlio da ragazzino. Alcune sequenze onirico-surreali rimangono sopra le righe, se non altro, ed è anche curioso come Loomis, la storica figura del dottore che aveva curato Myers, diventi quasi un personaggio negativo, avido e privo di scrupoli nel cercare di vendere il proprio libro. Alla base del film, la tagline “Family is forever“: Myers cerca ancora una volta la propria famiglia, per potersi ricongiungere ad essa.
A quanto pare il regista decise di girare il seguito (cosa che inizialmente si sarebbe rifiutato di fare, a suo stesso dire) solo per evitare che la visione complessiva ne risultasse alterata da qualcun altro, buttandosi a capofitto nell’impresa che sa ancor più di kolossal, con questo secondo episodio. Il film stavolta è girato a 16mm in 1.85:1, a differenza del precedente remake che era invece in 2.39:1 (che per motivi tecnici Zombie ha dichiarato di non amare troppo). Di fatto non sembrano sussistere troppe differenze a livello di dinamiche d’azione e di omicidi, come è facile immaginare, senza contare che non sono neanche trascorsi troppi anni dal precedente (appena due): Myers diventa un’ombra che si aggira per uccidere nei modi più brutali, questa volta (dettaglio considerevole) comparendo in più occasioni senza maschera. Il Faerch che interpretava il giovane Myers, peraltro, viene qui sostituito da un altro interprete abbastanza somigliante, probabilmente perchè all’epoca sarebbe sembrato più grande rispetto al film precedente. Nota considerevole sul film, peraltro, è legata al fatto che alcuni attori interpretano più ruoli diversi: Jeff Daniel Phillips ad esempio è sia Howard Boggs che Uncle Seymour Coffins, mentre Dick Warlock ne interpreta addirittura tre.