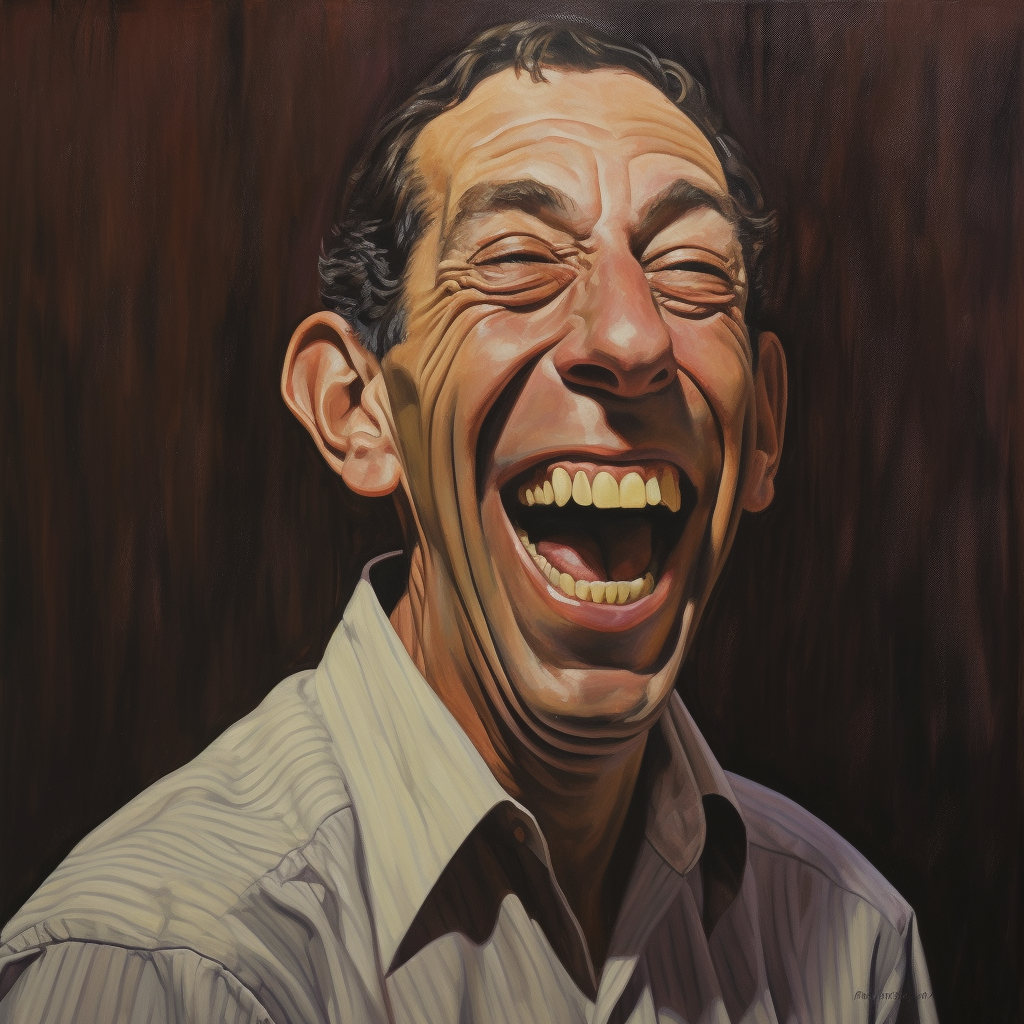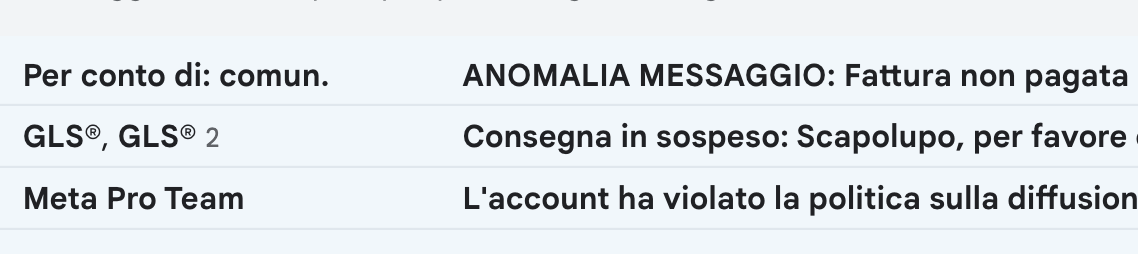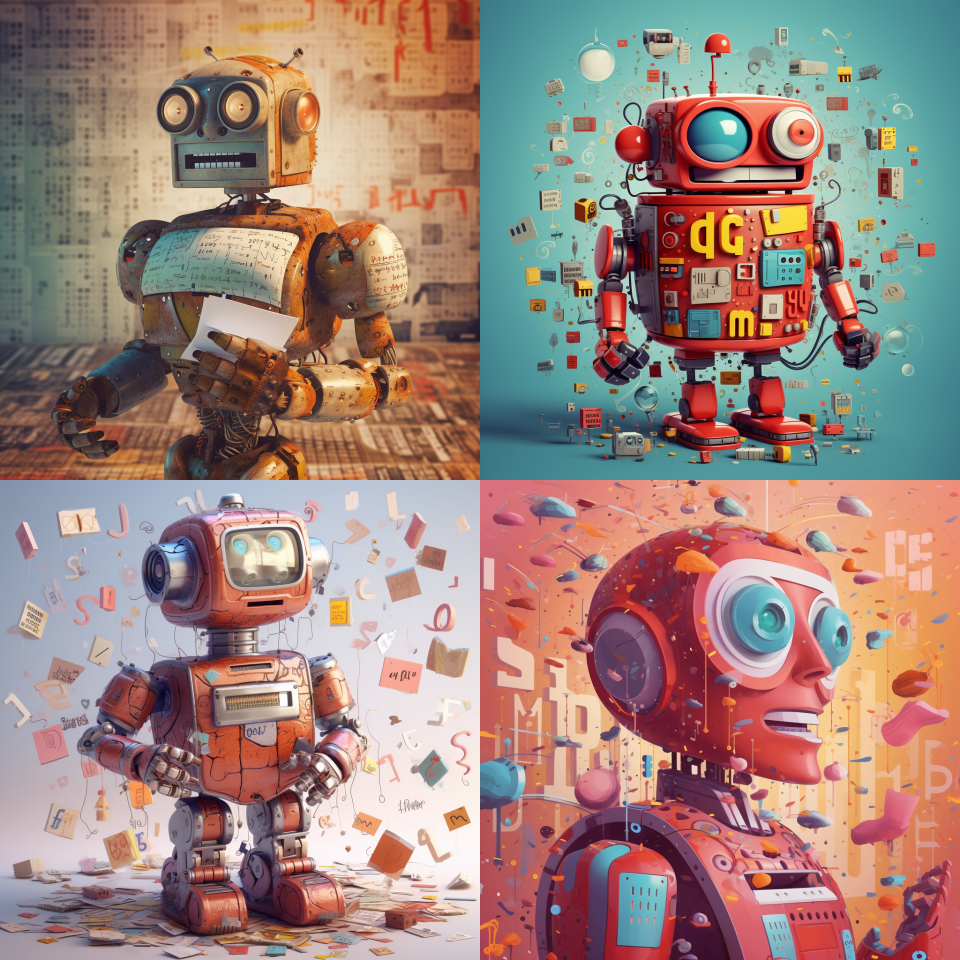Se si cerca su Google “girlfriend experience” uno dei primi risultati, almeno allo stato attuale, è una FAQ in cui la domanda recita “dove posso trovare girlfriend experience“: la risposta, naturalmente, è su Amazon, e fa riferimento alla serie TV del 2016 di tre stagioni, uscita qualche anno fa, ad opera dei registi Lodge Kerrigan e Amy Seimetz. Nel primo episodio si mostra uno spaccato della vita di Christine, studentessa di giurisprudenza che trascorre le giornate tra studio, tirocinio in uno studio legale e relazioni occasionali, e quella dell’amica Avery, che lavora come escort proprio in termini di Girlfriend Experience.
Eppure dove posso trovare girlfriend experience è una domanda che suona spaventosamente ambigua, perchè nulla sappiamo sul reale intento di ricerca da parte dell’utente e non sappiamo, in definitiva, se fosse desiderio di una fidanzata simulata o di una serie TV. Di fatto l’acronomo GFE, che in genere accompagna nel gergo di internet le Girl Friend Experience, è un servizio sessuale vero e proprio, in cui si chiede – al di là della prestazione sessuale – che la donna (o l’uomo, nel caso di una boyfriend experience o BFE) mostri un attaccamento sentimentale alla persona. Quindi a parte il sesso ci saranno scherzi, coccole, intimità e via dicendo. Il dizionario urbano, caustico come al suo solito, definisce BFE / GFE come Affection oriented escort, ovvero sex worker orientate all’affetto. E molte escort, a quanto pare, offrono questo servizio nella miriade di acronimi di natura prettamente sessuale, tra cui esce fuori GFE come se fosse una threesome o un 69.
Girlfriend experience è sostanzialmente una escort che offre più del semplice sesso, ma anche baci, coccole, carezze e abbracci. È pura distopia, a pensarci. Ma forse già pagare per il sesso si affaccia sullo stesso scenario, perchè ci costringe quantomeno a fare i conti con l’incapacità, la sfortuna, la mancanza di contesto, il disagio che provano troppi di noi nello stringere una relazione sessuale anche occasionale. Perchè non è facile darsi e concedersi facilmente, e perchè ci sentiamo sempre più insicuri nel farlo. E se possiamo pagare anche per questo, se da un lato è il trionfo del capitalismo – che, come previsto da Marx, si insinua ovunque – d’altro canto costringe a fare i conti con l’aspetto sostanziale della questione, che è proprio quella dimensione sociologico-distopica di solitudine di cui troppo poco, forse, si parla nel dibattito pubblico.
Un dibattito che tiene giustamente in considerazione gli aspetti alienanti della vita di coppia, delle coppie bianche che convivono in modo stabile senza sesso e via dicendo, ma che – al tempo stesso, per una assurda disparità di trattamento – non da’ abbastanza spazio alla solutudine dei single che hanno, se non altro, la possibilità di rivivere certe esperienze pagando. Anche se queste esperienze non sono prettamente sessuali, di fatto. Fa strano, giustamente, ma va contestualizzato e – quasi certamente – accettato. Sono le conseguenze del mondo frenetico e deregolamentato in cui viviamo, nel quale la relazione è un “di più”, un lusso per pochi, anche se si trattasse di relazione puramente occasionale, in molti casi.
Per un’esigenza prettamente indotta dal mondo che li circonda, che gli urla troppo spesso in faccia “sono tutti fidanzati tranne te”, generando inutile sofferenza di natura comparativa. Ma il capitalismo è abile a confrontare le prestazioni e fin troppo scontato, in effetti, che faccia classifiche tra le persone, anche se i punti non valgono letteralmente nulla e sono esclusivamente indicativi di status esterni; e questo almeno fin a quando non sarà seriamente messo in discussione.