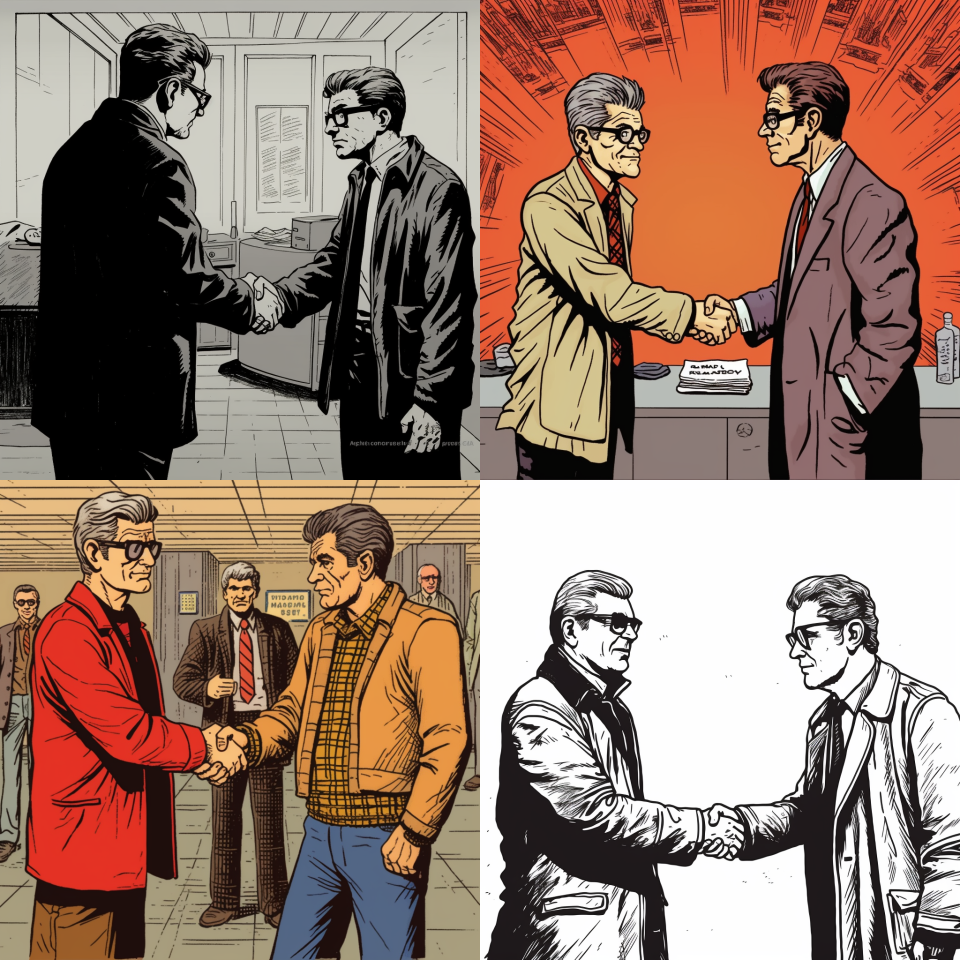Rialzati o cuore, sballottato da tormenti infiniti e oscura solitudine. Resisti contro chi ti minaccia con una croce in mano o ti accerchia fra luci tremule di un villaggio superstizioso. E se l’alba ti uccide, non disperare. E se la notte è tua, non gioire. θυμέ ἄνα δέ. Rialzati, o cuore, sulla nostra oscurità interiore. L’apostrofe è una figura retorica con cui l’autore si appella al proprio lettore, e nel caso di Archiloco (qui citato in meta-versi che non ha mai scritto, ma che avrebbe potuto – se avesse conosciuto la figura di un vampiro) è un modo artistico per appellarsi all’animo.
Un appellarsi oggi inconsueto dato che la figura di Dracula è relegata a un immaginario quasi svanito, al limite dell’irraccontabile, del vetusto. Un racconto smarrito in mille divagazioni sul tema che hanno finito, alla lunga, per renderlo ben lontano dall’essenza radicale della sua prima versione. Perchè vale la pena ricordare che il conte Dracula (se preferite, il conte Orlok) è Il non-morto, espressione di un desiderio che non trova pace, oltre che ben diverso dal vituperato morto vivente. Il vampiro come espressione solipsistica della volontà di inseguire il desiderio, persi nel sogno dell’immortalità, nell’ombra di una pulsione di morte ben cristallizzata narrativamente.
Eppure nel racconto originale Dracula sarà addirittura grato a Van Helsing, alla fine, e questo per avergli consentito, con la sua distruzione, di poter finalmente riposare in pace. Allo stesso modo (mentre si osserva in silenzio l’incedere di una storia che, per Eggers, è orrore come pura idea) l’animo di chi guarda è tormentato da richiami ancestrali a valori eterni, che vanno dal mito dell’eterna giovinezza a quello, più desueto, di un amore senza fine, in grado di risorgere ogni notte a patto di trovare nuovo sangue. Per quanto si possa essere profondamente disillusi e distratti dalla quotidianità, a conti fatti, quella di Nosferatu continua ad essere una storia che strugge, appassiona, disorienta – per quanto sia ben nota, come di un amore non ricambiato, a senso unico, destinato a fallire eppure intenso, per il quale verremmo biasimati da chiunque – lo stesso biasimo di chi oggi non amerà questa pellicola, perchè dai, ancora con Dracula state, ma basta – una follia senza mordente, puro masochismo, uno strazio che avresti potuto evitare eppure hai deciso di viverlo, se non altro fino all’alba – il momento simbolico in cui quel sogno svanisce.
Da un lato cinematografico il tema dei vampiri è tra più noti e sfruttati nella storia, e non è mai agevole riproporne uno senza auto-relegarsi al ruolo di ennesimo cineasta da b movie. Cosa che questo Nosferatu si guarda bene dall’essere. Un vampiro del genere forse oggi fa sorridere, al limite in chiave grottesca o satirica, fa alludere di riflesso ad una sensualità immortale, come dire, è difficile crederci, è particolarmente difficile onorare il patto spettatore-regista legato alla sospensione di incredulità. Non è agevole prenderlo sul serio, soprattutto dopo che decine di opere lo hanno di fatto privato dello spirito del suo tempo – quello fatto di oscura malinconia, terrore sublimato e rappresentazione del desiderio e della sua pura, irraccontabile, oscena, inevitabile perversione.
Ciò di cui parliamo pone una svolta, perchè Eggers relega il mito del vampiro ad un mondo antico, fitto di superstizioni ancestrali e mitologie occulte. Un mondo essenzialmente pagano e dalla fatua modernità (fatua perchè i topi invaderanno la città, portando la peste e la quarantena), in cui anche le persone più razionali sono segretamente attratte dal mondo dell’occulto. Poco importa che la scienza stia nel frattempo muovendo i primi, timidi passi, perchè conta solo la suggestione del pensiero magico. Soprattutto siamo in un mondo in cui la medicina era ancora poco sviluppata, non esistono ancora psicologia e psicoanalisi – per cui i deliri mistico-malinconici di una donna come Ellen Hutter, protagonista centrale del film, alla ricerca di una figura indefinita da cui si sente attratta, viene banalmente declassata ad esaurimento nervoso – e per l’epoca in cui viviamo, per inciso, tanto vale legarla al letto, in caso esagerasse. La singolarità del Nosferatu di Eggers, del resto, è anche quella di averlo costruito su un archetipo femminile fragile emotivamente quanto decisivo narrativamente, al punto di restituire l’arcaico mistero della storia originale di Bram Stoker in una chiave rivoluzionaria e, a ben vedere, ben adeguata alla modernità.

Il film di Eggers risulta pertanto un gotico oscuro, solo in apparenza fuori tempo massimo, espressione di un folk horror ancestrale dal montaggio snello, in cui nulla è di troppo e tutto è funzionale alla trama. Ne risulta un lavoro asciutto e perfetto nella forma, che saprà essere divisivo per il pubblico abituato alle versioni fumettistiche, vuotamente romantiche e accattivanti dei vampiri. Nosferatu relega, in altri termini, la narrazione agli aspetti più oscuri e antichi del gotico, riportandolo alle origini dell’orrore, con la stessa convinzione oscura che doveva avere Bram Stoker quando mise mano al proprio Dracula.
La migliore versione della storia, senza timore di esagerare, forse dai tempi di Dracula di Francis Ford Coppola di inizio anni NOvanta, considerando pure che la saga vampirica ispirata al conte è sempre vissuta di alti e bassi, di titoli altisonanti quanto vacui, e di lavori meno noti o più sostanziali: basterebbe considerare la varietà tematico-stilistica di opere come Blade, Underworld, Intervista col vampiro, Hanno cambiato faccia, la saga di Twilight, Miriam si sveglia a mezzanotte, L’ombra del vampiro per rendersene conto. Da troppo tempo si trattava di un jolly narrativo da spendere a casaccio, privato dell’oscuro mood gotico che lo rendeva una delle migliori opere horror mai pubblicate, al pari dei capolavori di Lovecraft e Poe. Qui si torna alle origini, e lo si fa con la convinzione dello stesso cineasta che ha prodotto folk horror immarcescibili come The Vvitch.
Eggers si richiama sia al Nosferatu di Murnau che a quello di Herzog, ricalcandone creativamente lo spirito e i contenuti e adeguandoli ai tempi che cambiano. Soprattutto conferendo alla trama un insolito (per un film di vampiri) spessore psicologico ai personaggi, per i quali i limiti tra psicosi e malattia organica sono sempre labili, in grado di lasciare deliziosi dubbi allo spettatore. Di fatto, il Nosferatu di Eggers è anche un film costruito sui dettagli: in primis la scelta della location (il castello di Perstein, lo stesso usato da Herzog per la sua versione dell’opera), poi lo stile frenetico e privo di tempi morti con cui le sequenze si susseguono. Ecco Thomas che scoperchia la bara del vampiro, riuscirà a colpirlo con un piccone? Van Helsing? Dovrebbe essere lui, ma non ne siamo sicuro. La peste arriva in città, e con lui il Conte Orlok, proteso a conquistare il mondo e diffondere un male proto-lovecraftiano sulla terra. Guardate adesso il conte Orlok, è talmente spaventoso che il regista si guarda bene dal mostrarlo prima che il film si avvii verso la fine. Il sangue e la violenza la fanno da padrone nella giusta misura, sono sequenze fatte essenzialmente di sprazzi, sangue che vediamo solo per rapidi istanti perchè conta più lo studio d’atmosfera, l’esaltazione della scenografia macabra e surreale. Poi va rilevata la scelta dei simbolismi animaleschi, decisamente classica: vampiri associati ai topi e alla diffusione della peste nera in Europa, cacciatori di vampiri associati al contrario ai gatti. Sono elementi che piaceranno ai fanno dell’horror concettuale e metafisico, effettivamente, e che potrebbero deludere chi non ha idea di cosa sia un Horror, o magari si aspettava l’ennesimo rehash fumettistico tipo Blade.
La caratterizzazione del conte Orlok / Dracula, di suo, deriva qui dal folklore rumeno (sulla falsariga della versione di Herzog, in effetti), a cominciare dai baffi e dai dettagli fisici sinistri che le accompagnano l’essenza. La forma del protagonista è a suo modo inedita, soprattutto per la scelta di mostrarne chiaramente le fattezze solo nella parte finale del film, facendolo diventare un’ombra oscura e accennata, a evocare virtualmente il Freddy del primo Nightmare. Forma allungata, incedere minaccioso e imprevedibile, unghie lunghissime, Orlok parla quasi sempre lingua rumena (con cui sembra poter comunicare anche telepaticamente con le vittime), mentre attorno a lui sta per nascere il mondo in cui viviamo, con le città evolute asimmetricamente rispetto ai villaggi, con i primi che esaltano il culto della produttività e i secondi che evocano riti ancestrali dimenticati dai più.
Per il resto “Blood is life” (come viene detto nella seconda parte del film): il sangue è vita, e sarà dei vampiri.

Per molti versi quello di Eggers è un esperimento azzardato, almeno sulla carta, che esibisce una grande prova registica e concettuale su un terreno scivoloso, in cui il rischio è che il pubblico possa lamentarsi sia di interpretazioni troppo letterali (considerandolo poco originale) che troppo azzardate (considerandolo, al contrario, poco fedele all’originale). Non era agevole tornare alla figura orrorifica che più di tutte ha influenzato il mito del vampiro: una storia che, in questa sede, si richiama a suo modo al romanzo episotolare di Bram Stoker “Dracula“, lo stesso che costò il fallimento della Prana-Film, condannata a pagare i diritti del Nosferatu di Murnau. Per quello che ci riguarda, qui l’esperimento è da considerarsi perfettamente riuscito.
L’orrore di Eggers, come già in The Northman e The Vvitch, si richiama ai classici del genere, ed è di natura squisitamente folkloristica: si lega ad un mondo fatto di villaggi retrogadi, tradizioni locali antiche quanto macabre, un mondo ancora tecnologicamente e scientificamente non troppo evoluto quanto affascinato dall’esoterismo e dell’occulto. Il tutto viene arricchito da un singolare mood proto-lovecraftiano per eccellenza: ciò che è sepolto nel passato, magari in un antico castello, deve rimanere lì. Per forza. Se andiamo a riscoprilo o stuzzicarlo, peggio ancora se per scopo di lucro (come fa il povero sss), non può finire bene. E fa impressione sentire oggi questa storia, attuale più che mai, con la peste nera che arriva da una barca in cui enormi e numerosi topi porteranno il contagio che infesterà realmente l’Europa.

Dal canto loro – in un’ambientazione dei primi anni del 1800 – i personaggi rivivono sullo schermo in un’atmosfera da grand guignol, spesso e volentieri illuminata e allestita come se fossimo a teatro, tra cui svettano per eccellenza le prestazioni di William Dafoe nei panni di uno professore allontanato dalla comunità scientifica per il suo interesse per l’occultismo (Van Helsing?), che strizza l’occhio alle nuove attitudini psicologiche, che sarebbe nata solo qualche decennio dopo con i laboratori di Wilhelm Wundt.
Con uno squisito equilibrio tra oscurità e gore, gran parte del film di Eggers si focalizza pure sul lato psichiatrico dei vampirizzati, con una modalità che mai si era vista con tale vividezza: come Orlok è una metafora della diffusione del contagio pestilenziale (tanto è vero che i morsi sul corpo delle vittime potrebbero essere ratti come non-morti), allo stesso modo le sue vittime sembrano vacillare, muoversi a fatica, soffrire le pene dell’inferno per un problema di salute mentale, prima che fisica.
È il mito di Nosferatu frammisto alla vera storia di Daniel Paul Schreber, il magistrato che si era convinto di parlare con Dio e di poterne condizionare l’operato. Le sue Memorie di un malato di nervi sono un classico della letteratura psichiatrica, e il caso vuole che sia vissuto nello stesso periodo in cui è ambientato il film di Eggers. Null’altro da aggiungere, a questo punto: il tributo è probabilmente involontario, ma serve a sottolineare come gran parte della brillanza di questo ennesimo Nosferatu risieda nell’averla voluta mettere sul piano clinico-psichiatrico in un momento storico in cui la medicina non aveva ancora lo sviluppo attuale, era ritenuto accettabile legare e narcotizzare i pazienti e Freud non aveva ancora proposto i propri studi sui sogni dei pazienti e sulla rilevanza degli stessi.
Orlok non è solo un vampiro predatore di sangue, ma diventa una metafora dell’essere ancora vivi. O, se preferite, dell’essere probabilmente non-morti.
Rialzati o cuore, sballottato da tormenti infiniti e oscura solitudine. Resisti contro chi ti minaccia con una croce in mano o ti accerchia fra luci tremule di un villaggio superstizioso. E se l’alba ti uccide, non disperare. E se la notte è tua, non gioire. θυμέ ἄνα δέ. Rialzati, o cuore, sulla nostra oscurità interiore.