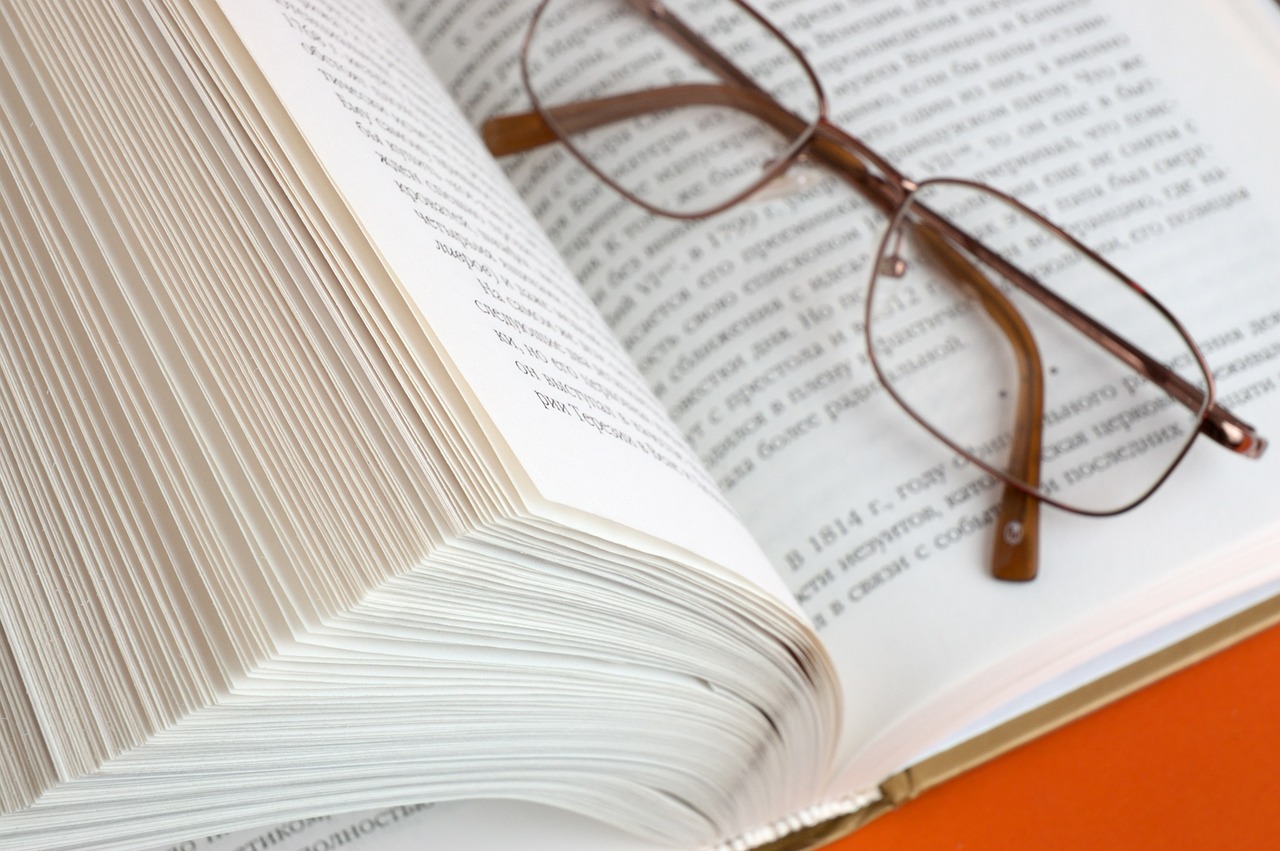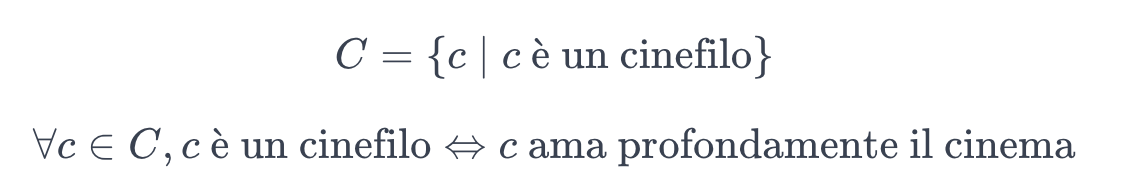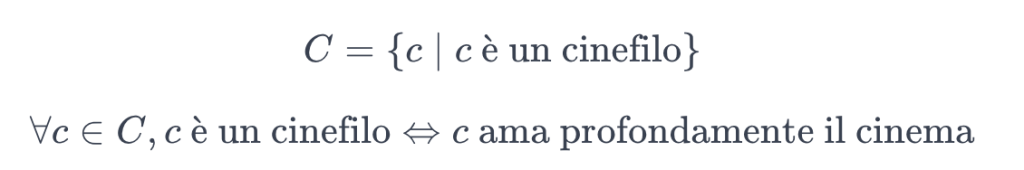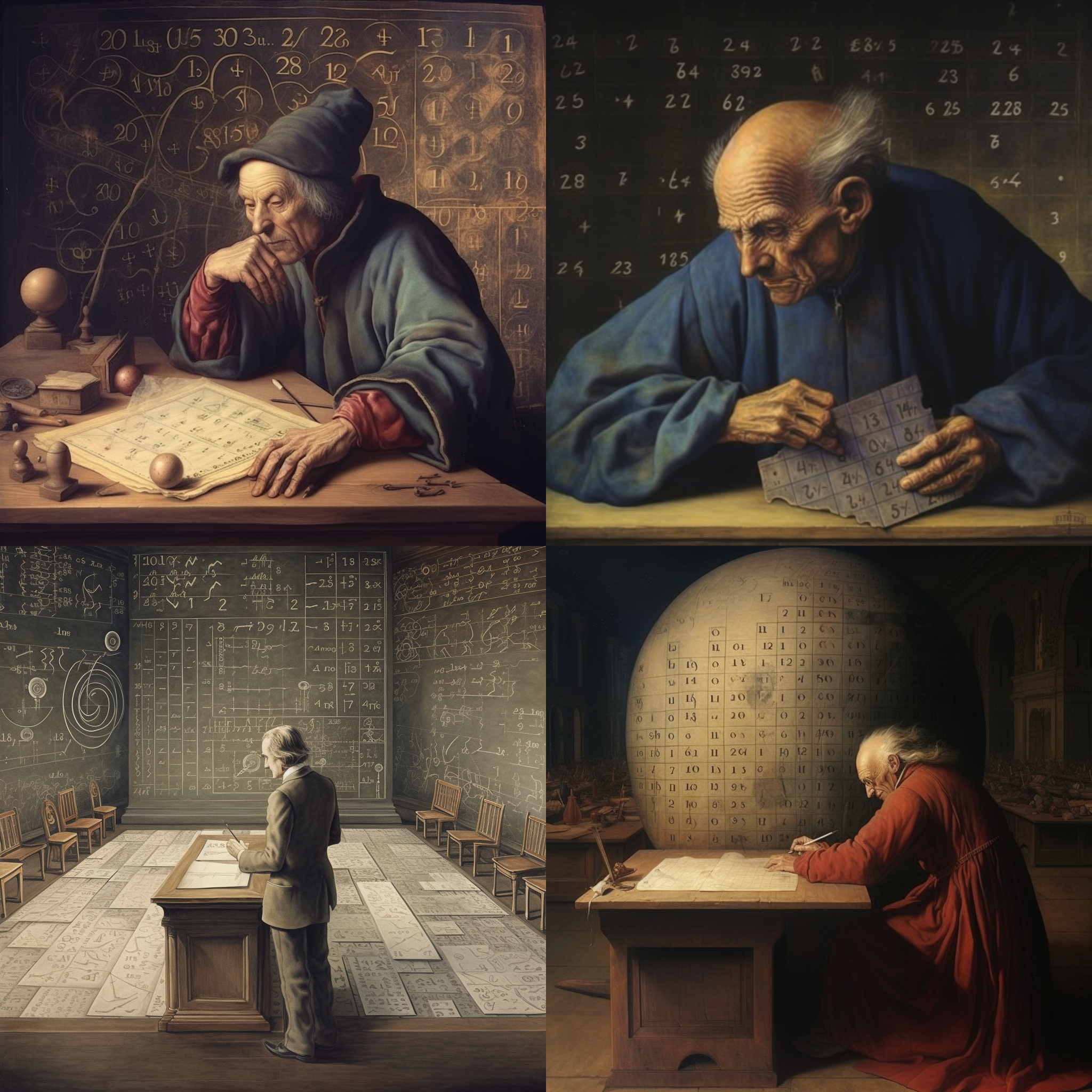Nel cuore di una notte oscura e tempestosa, nel laboratorio segreto di un eccentrico scienziato di nome Blackwood, una strana macchina era in fase di progetto. Ossessionato dall’idea di riuscire a viaggiare nel tempo, aveva dedicato anni alla costruzione di un dispositivo capace di piegare lo spazio-tempo. Ripensò alla moglie che lo aveva lasciato, e a tutte le cose che andavano a rotoli nella sua vita: normalmente era tutto in senso opposto a quello che avrebbe voluto.
La macchina, che lui chiamava “Cronovoro“, era concepita come un intricato agglomerato di cavi, ingranaggi e cristalli luminescenti. La gente del villaggio blaterava che Blackwood stesse sfidando le leggi dell’universo, giocando con poteri che non avrebbe dovuto toccare. Del resto, come avresti potuto credere a quelle critiche? Cosa potevi aspettarti da persone che credevano convintamente che la terra fosse piatta?
La notte in cui Blackwood decise di testare la Cronovoro, una tempesta imperversava furiosamente. I lampi illuminavano la notte, rivelando il suo volto invecchiato e gli occhi impazziti dalla determinazione. Con un cuore trepidante, avviò il dispositivo. Attese qualche minuto, poi sospirò e si lanciò nella voragine temporale che si era effettivamente aperta davanti a lui.
Per un attimo, sembrò che il tempo stesso si fosse sospeso. Blackwood si ritrovò in un’oscurità opprimente, dove le forze sconosciute dello spazio-tempo giocano con i suoi organi. Poi, con un impeto di energia, fu scaraventato fuori dal vortice e atterrò con un tonfo sordo.
Apri gli occhi e si trovò in un mondo che sembrava stranamente familiare, ma al tempo stesso perturbante. Uscì fuori in strada per rendersi conto: le strade erano illuminate da una luce più cupa del solito, fatiscente, mentre edifici decrepiti si ergevano come ombre spettrali. Era la versione apocalittica del suo vecchio villaggio. Viaggio nel tempo. Ci era riuscito!

La Cronovoro aveva invertito l’effetto desiderato: anziché spostarsi nel passato, aveva proiettato lui stesso in un futuro distrutto. Il mondo che osservava era il risultato di un’implosione temporale, dove le cose erano esattamente nel verso opposto in cui avrebbe voluto. Una curiosa metafora fisica della sua stessa esistenza, tutto sommato.
Nel buio e nella disperazione, Blackwood cercò di ritornare indietro, di raddrizzare la distorsione che aveva creato. Almeno in quel caso. Tuttavia, la Cronovoro si era rotta, intrappolandolo in quel mondo post-apocalittico come un autentico prigioniero del tempo. Il suo destino era stato sigillato in quella realtà distorta, in cui il passato, il presente e il futuro si erano fusi in un’esplosione di dolore e rimorso.
La storia del Dottor Elias Blackwood divenne leggenda e monito per coloro che osavano forzare i confini del tempo.
Definizione implosione
implosione è un termine che deriva dal latino “implodere”, composto da “in” (dentro) e “plodere” (scoppiare). Si riferisce a un processo in cui la pressione interna di un oggetto o di una struttura diminuisce così drasticamente che l’oggetto stesso collassa o si contraggono verso l’interno invece di esplodere verso l’esterno come avviene nell’esplosione.
Esempio di implosione: Immagina una bottiglia di vetro chiusa ermeticamente con l’aria all’interno. Se questa bottiglia venisse immersa in un ambiente a bassa pressione, come ad esempio una camera a vuoto, la pressione all’interno della bottiglia diminuirebbe mentre la pressione esterna rimane costante. Questa differenza di pressione potrebbe causare il collasso della bottiglia, poiché il vetro non è abbastanza forte da reggere la differenza di pressione, e quindi si rompe verso l’interno invece di esplodere verso l’esterno.
In senso più ampio, l’implosione può essere utilizzata per descrivere il collasso o la contrazione violenta di strutture o oggetti, come nel contesto di un edificio che crolla verso l’interno invece di espandersi in un’esplosione durante una demolizione controllata.
(Immagini illustrative generate da Midjourney)