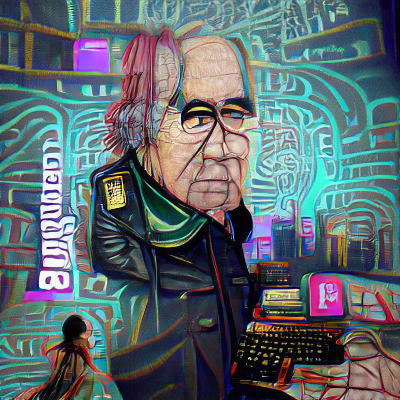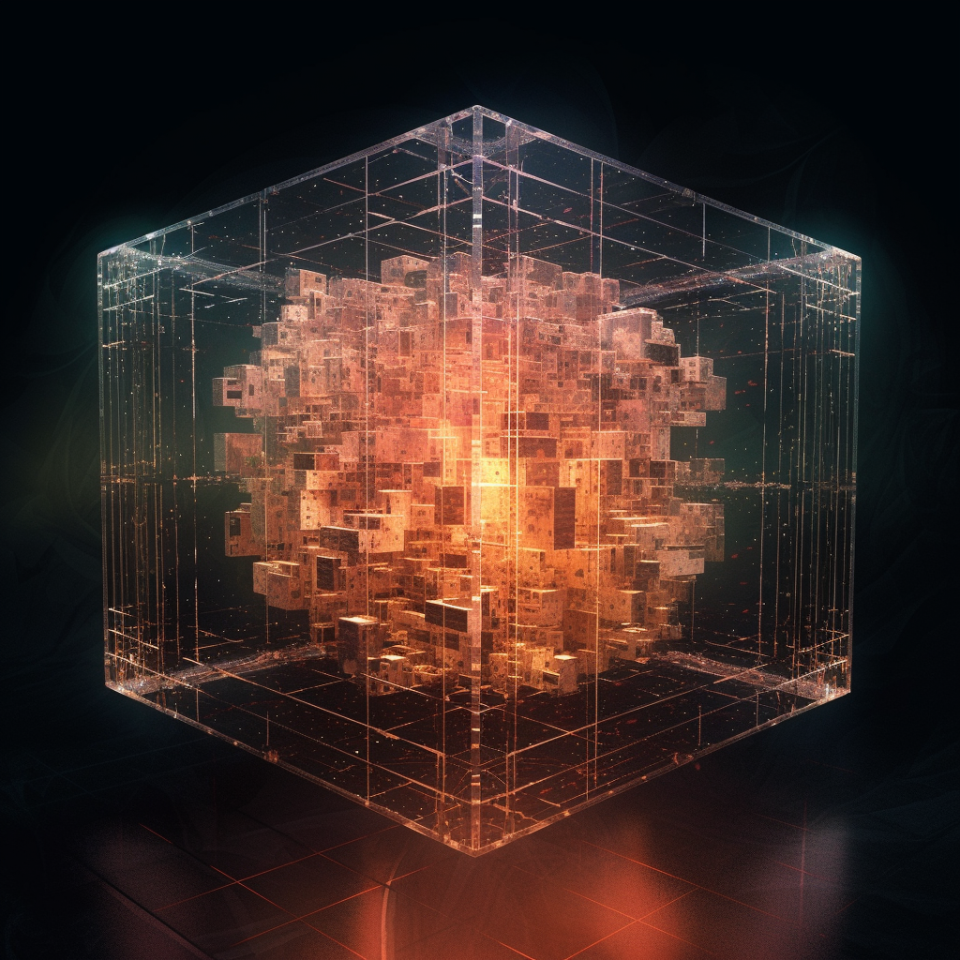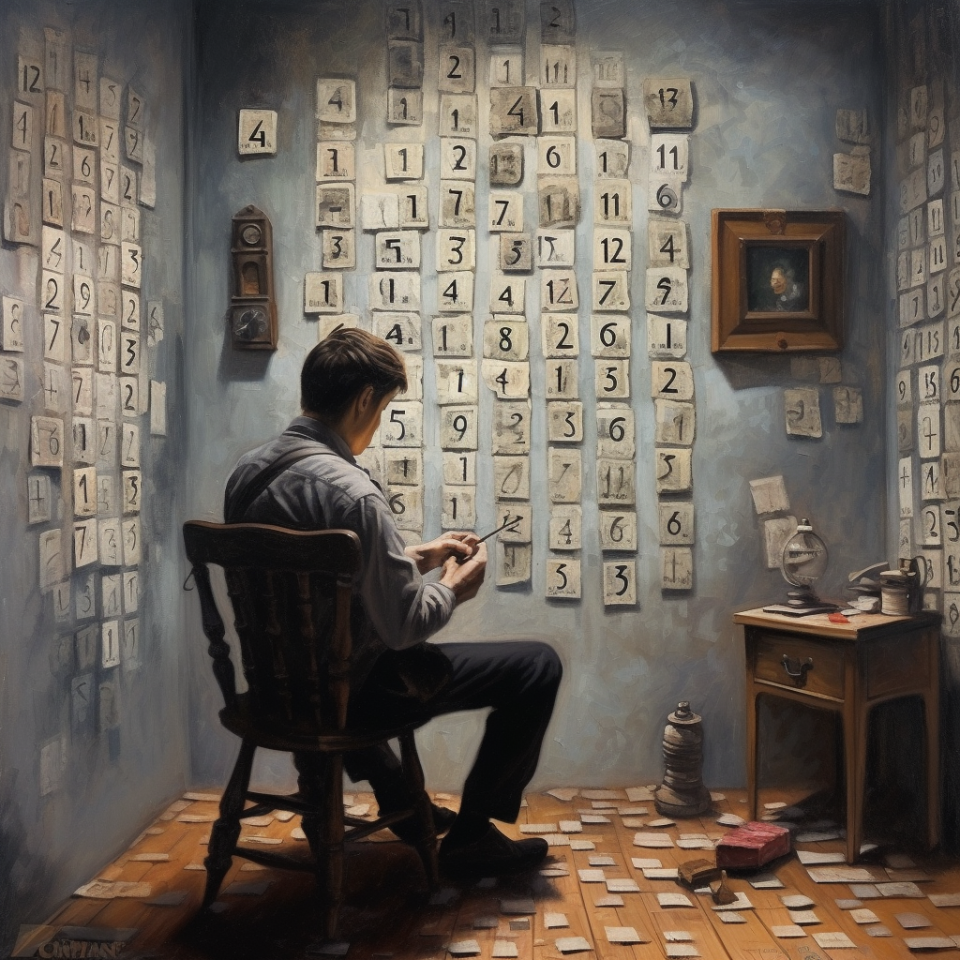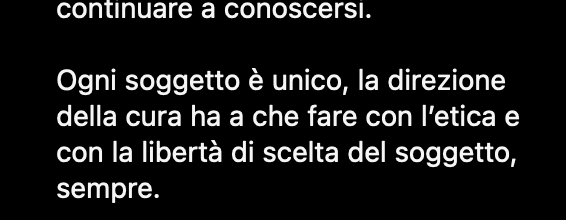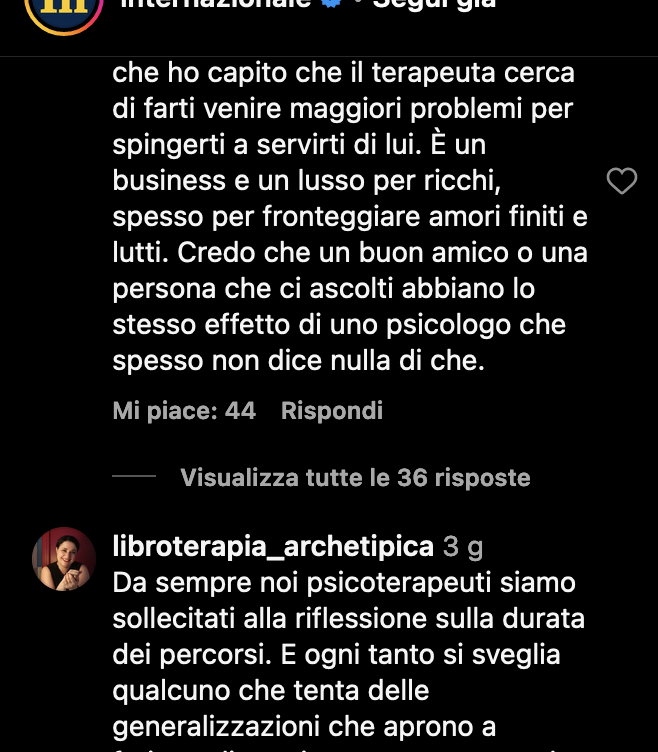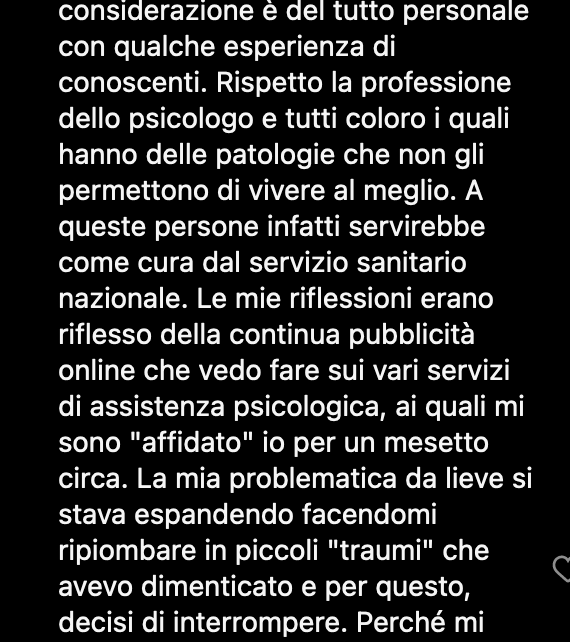In italiano, la parola “simulacro” deriva dal latino “simulacrum“, che significa “immagine” o “rappresentazione”. “Simulacrum” a sua volta è composto da “simul”, che significa “allo stesso tempo” o “insieme”.
In origine, il termine si riferiva a una rappresentazione o immagine di qualcosa, come statue o idoli. Nel tempo, il significato di “simulacro” si è ampliato per includere non solo rappresentazioni fisiche ma anche imitazioni che non riflettono necessariamente la realtà. In ambito teorico o filosofico, un simulacro può riferirsi a una rappresentazione che ha preso il posto della realtà stessa o che è considerata più reale della realtà originale. Nell’informatica, un classico simulacro può essere considerato ad esempio una videochat.
Come aveva provato a spiegarci tempo fa un’intelligenza artificiale, Baudrillard sostiene che la realtà sia modellata dal linguaggio (in parte sulla falsariga di Lacan), e concepisce lo scambio simbolico come uno scambio di merci in funzione puramente simbolica. Questo, in altri termini, significa che gli oggetti hanno valore in funzione del prestigio o l’appartenenza che conferiscono e non della loro reale utilità. Alla lunga, lo scambio diventa fuorviante e può trasmettere un’idea o un’immagine distorta della realtà.
Iperrealismo
Per Baudrillard il reale e l’immaginario non sono distinguibili, per cui finisce tutto per spostarsi sul piano dello (scambio) simbolico. Il lavoro, radicalmente, è una morte lenta e inesorabile per l’uomo in contrapposizione a quella veloce e violenta che avviene realmente. Reale e virtuale sono talmente similari che il reale è collassato nell’iperrealtà: passando di medium in medium, infatti, il reale si dissolve progressivamente, diventando un reale che somiglia a se stesso e provoca una autentica vertigine di simulazione realistica.
Se il reale è ciò di cui è possibile fare una riproduzione equivalente, ovvero risponde al principio di riproduttività, l’iperreale si troverà dentro una simulazione, un simulacro di terzo ordine.
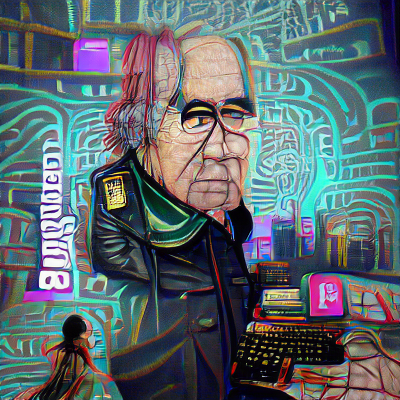
Simulacri
Il concetto di simulacro assume un significato differente a seconda del livello a cui fa riferimento, ma potrebbe farsi risalire a Lucrezio (1 secolo AC), che nell’opera De rerum natura definisce i sottili veli che ricoprono le cose come forma e apparenza, per l’appunto, come simulacri. Se in senso lato un simulacro è una forma di modello per una macchina, con particolare riferimento alla sua forma esterna
Nella dottrina epicurea, esposta da Lucrezio (sec. 1° a. C.) nel IV libro del De rerum natura, pensare ai simulacri significa credre in una dottrica per cui dalle cose si staccherebbero dei sottili veli atomici, del tutto identici alle cose, i quali, venendo in contatto con i sensi, determinerebbero sia le percezioni sia i sogni. Nella tecnica, modello al vero di una macchina o di una parte di essa, generalmente riproducente la sola forma esterna.
Simulacri di primo, secondo e terzo ordine (Baudrillard)
Vengono chiamati da Baudrillard simulacri
- del primo ordine quelli legati al concetto di contraffazione, risalenti all’epoca classica,
- di secondo ordine quelli legati alla produzione (età industriale)
- del terzo ordine quelli relativi alla modernità.
La tecnologia e la conseguente tecnocrazia sono già presenti da tempo, radicati nella società, e si fondano sui simulacri dell’organizzazione statale, scolastica e via dicendo.
I simulacri di terzo ordine sono, infine, veri e propri modelli di simulazione, governati dal principio di digitalità e rispondenti alla logica binaria basata su 0 e 1. La stessa che Leibnitz chiamava “l’eleganza mistica del sistema binario” non introduce solo un codice di rappresentazione, come l’informatica teorica ha sempre insegnato: è un vero e proprio spirito di fondo, che crea sistemi automatici di domanda e risposta in cui non esistono sfumature, e tutto è bianco/nero, pro/contro e via dicendo.
L’ordine neocapitalistico cibernetico
Il medium è il messaggio. (McLuhan)
Si fonda così un “ordine neo-capitalistico cibernetico” (concetto poi ripreso da Nick Land) in cui la digitalità assilla tutti i messaggi, ed appare soprattutto in forma di test e/o sistema domanda/risposta, prettamente binari ed in cui non esistono terze o quarte possibilità: ne esistono soltanto due, 0 e 1. La logica binaria diventa, secondo Baudrillard, l’essenza della modernità.
Il sistema di terzo ordine è infido, secondo Baudrillard, perchè induce instantaneità di giudizio, si pone come sistema di test perpetuo per l’utente umano. Gli stessi messaggi inviati e ricevuti nel sistema non hanno più un ruolo informativo, bensì di test e sondaggio degli utenti.
L’oggetto non è più funzionale, non vi serve – scrive Baudrillard ne Lo scambio simbolico e la morte – semmai vi sottopone ad un test. Il test, di fatto, serve a tradurre ogni conflitto o problema complesso in un gioco di dualità forzato, in cui sarai sempre pro-zero oppure pro-uno (oppure, dualmente, contro-zero / contro-uno). Lo schema binario di domanda e risposta disarticola ogni discorso, introducendo una logica di realtà di tipo iper-reale. I sondaggi ad esempio fanno riferimento pertanto al simulacro dell’opinione pubblica e “manipolano l’indecidibile“.
Ciò provoca una circolarità totale, perchè gli interrogati si dipingono sempre come la domanda li immagina e li sollecita ad essere, [il che diventa] una modalità di profezia che si autoavvera (per l’accelerazionismo, una iperstizione).
Automi e robot
la contrapposizione tra automi e robot è fondamentale in Baudrillard: i primi afferiscono ai simulacri del primo ordine, e ancora a questo stadio assumono una differenza o una faglia tra reale e simulacro.
Nello specifico, l’automa è una contraffazione del reale, mentre il robot lavora in automatico e rappresenta un simulacro di secondo ordine, in grado di liquidare il reale ed annullare la divergenza tra i due livelli (realtà e simulazione).
Foto di copertina: Baudrillard di fronte ad un simulacro simile ad uno smartphone, in versione cyberpunk (generato da StarryAI)