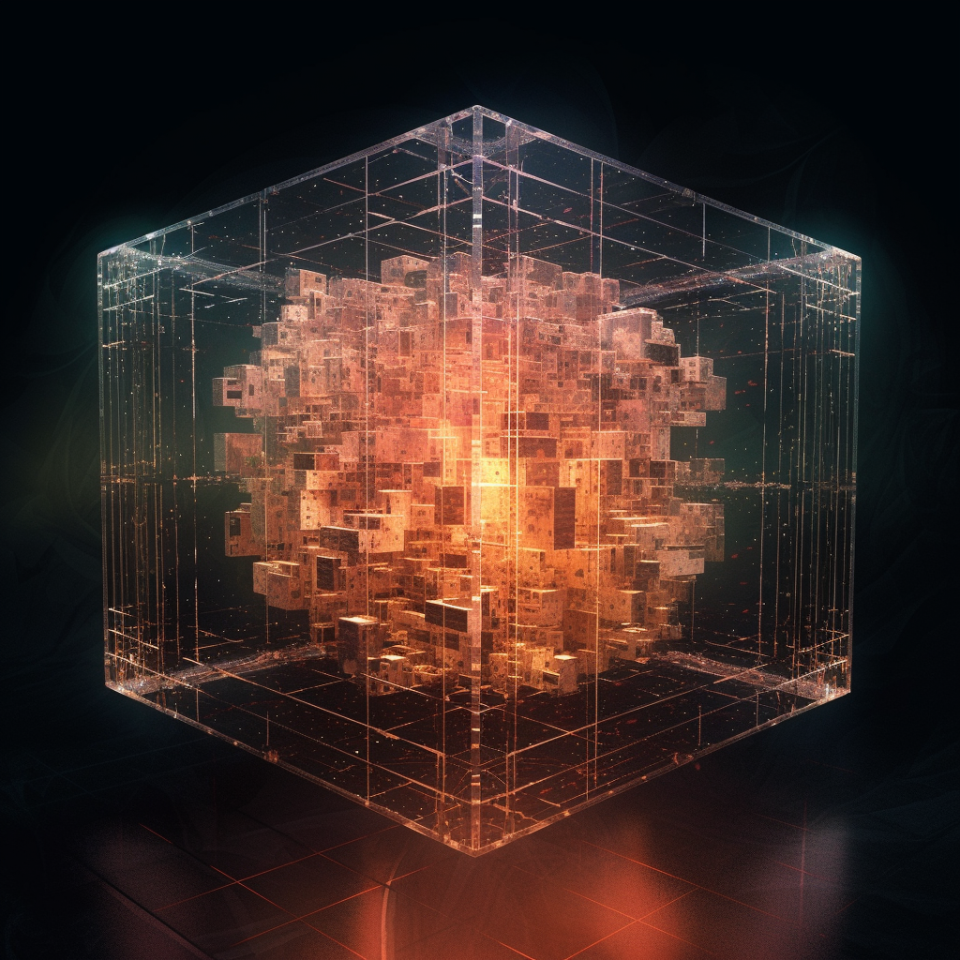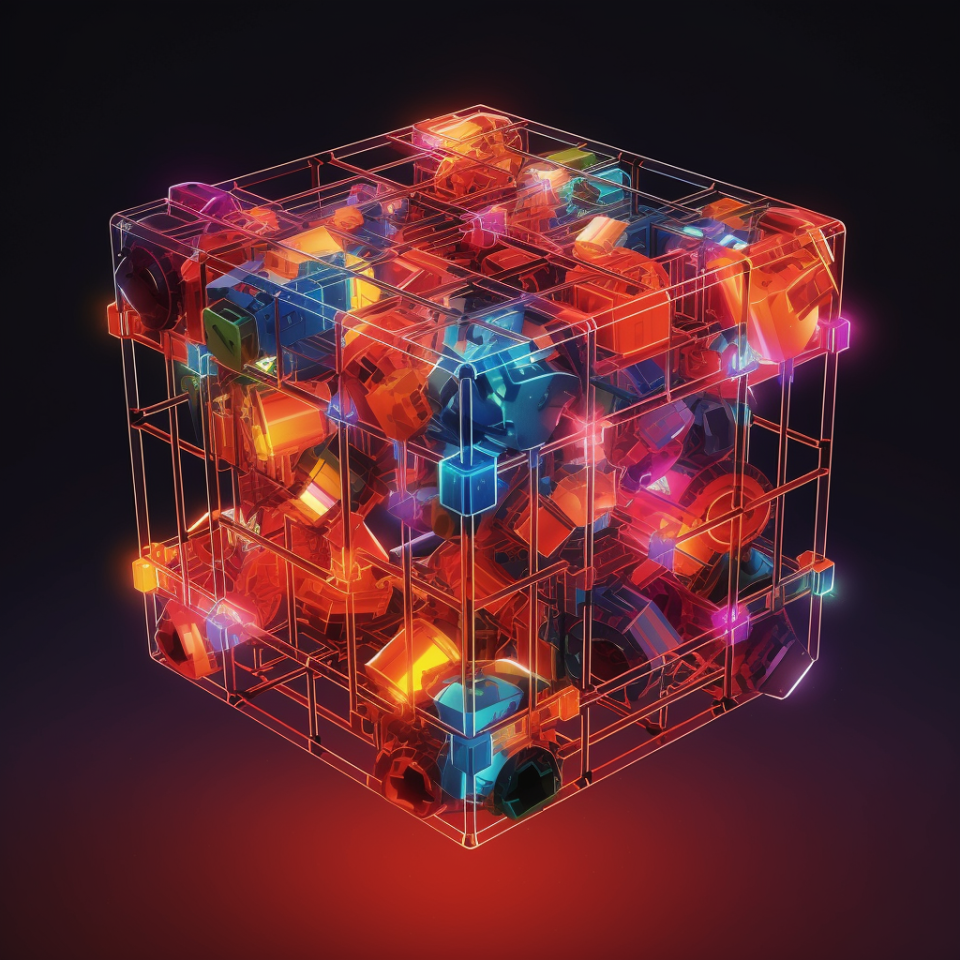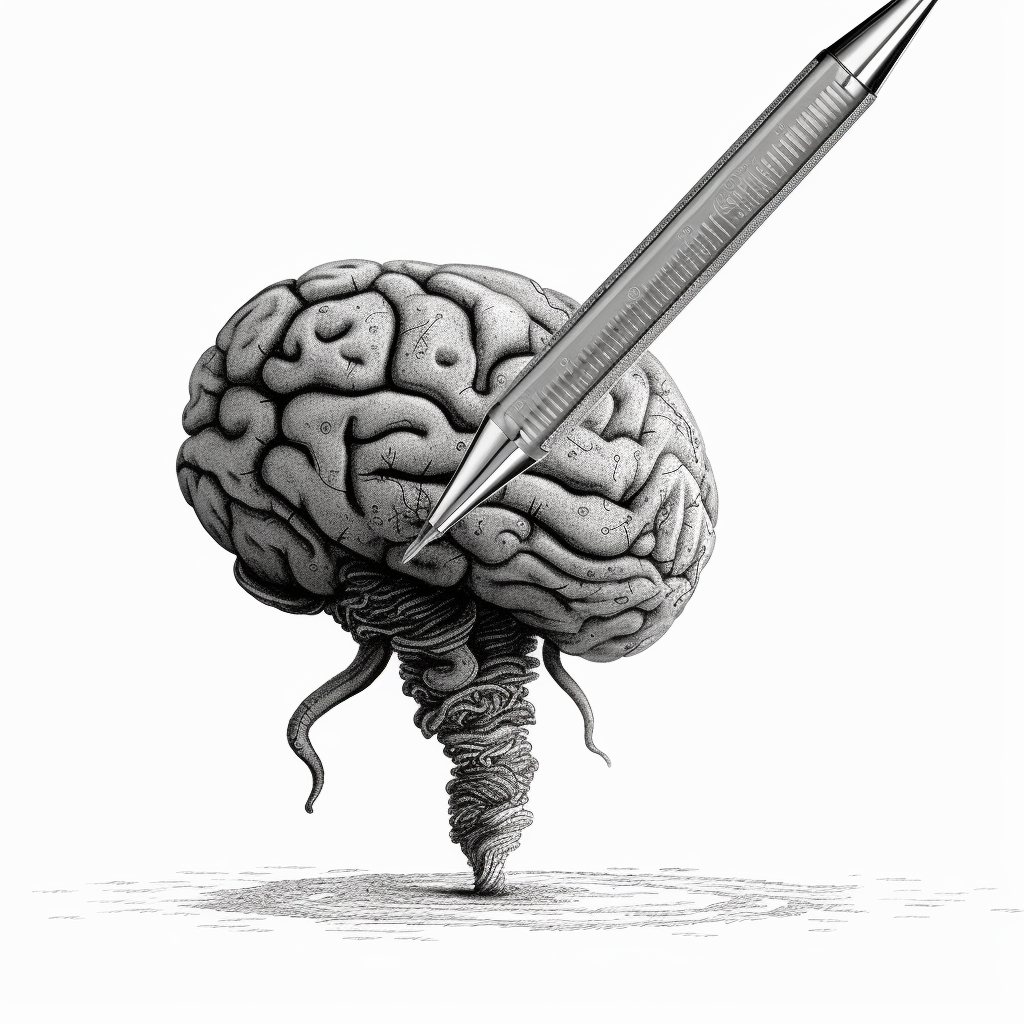(l’intervista che segue è stata tradotta da lipercubo.it ed è tratta dal sito orphandriftarchive)
Delphi Carstens intervista Nick Land.
Anno 2009.
Nella seguente intervista Nick Land risponde ad alcune domande sui meccanismi dell’Iperstizione nel contesto dell’apocalisse – un tema leggero – giusto per cominciare col botto.
Q1. Potresti approfondire cosa c’è di occulto… cosa sarà rivelato dall’apocalisse?
R1. Ciò che è nascosto (l’Occulto) è un ordine del tempo estraneo, che si tradisce attraverso “coincidenze”, “sincronicità” e indicazioni simili di una disposizione intelligente del destino. Un esempio è il modello cabalistico occultato nelle lingue ordinarie – un modello che non può emergere senza erodersi, dal momento che la comprensione generalizzata (umana) e l’uso deliberato dei gruppi di lettere come unità numeriche chiuderebbe il canale della “coincidenza” (informazione aliena). È solo perché le persone usano le parole senza numerizzarle che esse rimangono aperte come canali per qualcos’altro. Dissolvere lo schermo che nasconde queste cose (e nascondendole, permette loro di continuare), significa fondersi con la fonte del segnale e liquidare il mondo.
Q2. Scrivere sull’apocalisse la ricaccia nell’ombra/la codifica in modo più pesante… oppure l’atto di indagare sull’apocalisse aiuta a decodificarla e attualizzarla?
R2. Per i teisti, il primo. Per i naturalisti trascendentali (come i cibernetici iperstizionali), quest’ultima.
Q3. Potresti approfondire il concetto di “sforzo iperstizionale”? Iperstizione è una parola chiave nel lessico della mia tesi… mi chiedevo se potessi scomporre il termine in un linguaggio che i normali accademici (come il mio supervisore!) possano capire. L’iperstizione è la spina dorsale o il canale in cui confluisce tutto ciò che è apocalittico, ma di cosa si tratta esattamente? Potresti definirlo? Il modo in cui lo capisco dal Catacomic è che si tratta di un meme o di un’idea attorno alla quale si cristallizzano idee/traiettorie). (i grassetti sono miei, ndt)
R3. L’iperstizione è un circuito di feedback positivo che include la cultura come componente. Può essere definita come la (tecno-)scienza sperimentale delle profezie che si autoavverano. Le superstizioni sono semplicemente false credenze, ma le iperstizioni – per la loro stessa esistenza come idee – funzionano in modo causale per realizzare la propria realtà. L’economia capitalista è estremamente sensibile all’iperstizione, dove la fiducia agisce come un tonico efficace, e viceversa. L’idea (fittizia) del cyberspazio ha contribuito all’afflusso di investimenti che lo hanno rapidamente convertito in una realtà tecnosociale.
Il monoteismo abramitico è anche molto potente come motore iperstizionale. Trattando Gerusalemme come una città santa con uno speciale destino storico-mondiale, ad esempio, si è assicurato l’investimento culturale e politico che trasforma questa affermazione in verità. L’iperstizione è quindi in grado, in circostanze “favorevoli” la cui esatta natura richiede ulteriori indagini, di trasmutare le bugie in verità.
L’iperstizione può quindi essere intesa, dal lato del soggetto, come una complicazione non lineare dell’epistemologia, basata sulla sensibilità dell’oggetto alla sua postulazione (anche se questa è ben distinta dalla posizione soggettivistica o postmoderna che dissolve la realtà indipendente dell’oggetto in strutture cognitive o semiotiche). L’oggetto iperstizionale non è una mera invenzione della “costruzione sociale”, ma è in un modo molto reale “evocato” all’esistenza dall’approccio adottato nei suoi confronti.
Q6. Esiste l’iperstizione al di fuori del tempo e come si nasconde? Ciò è affascinante, soprattutto in relazione al meme dell’apocalisse, che non lo è affatto. Come si relazionano i due termini?
R6. Il tempo è l’operare nel tempo storico di ciò che sta fuori (ma si costruisce attraverso) il tempo storico. L’Apocalisse chiude il circuito.
D7. In che modo l’iperstizione si collega al capitalismo come campo di forza?
R7. Il capitalismo incarna dinamiche iperstizionali a un livello di intensità senza precedenti e insuperabile, trasformando la banale “speculazione” economica in un’efficace forza storica mondiale.
Q8. Puoi dire qualcosa sul tema della finzione – cioè storia e filosofia come finzione, e finzione come attualizzazione più intensa del potenziale storico / scientifico / tecnologico / sociologico?
R8. L’iperstizione è in equilibrio tra finzione e tecnologia, ed è questa tensione che conferisce intensità a entrambe, sebbene l’intensità della finzione debba tutto al suo potenziale (catalizzare i “divenire” iperstizionali) piuttosto che alla sua realtà (che può essere mera espressività umana). .