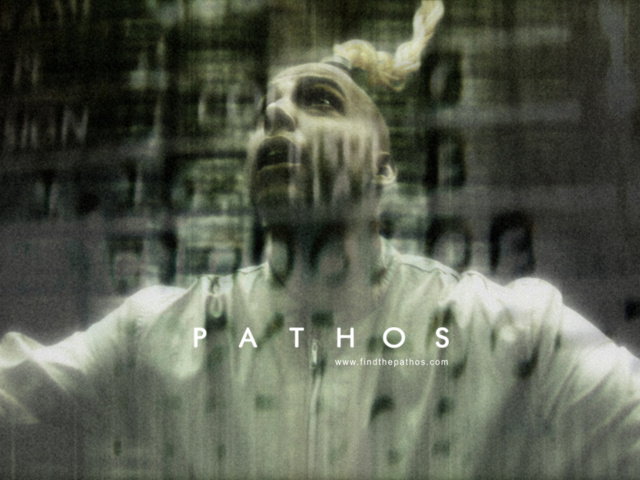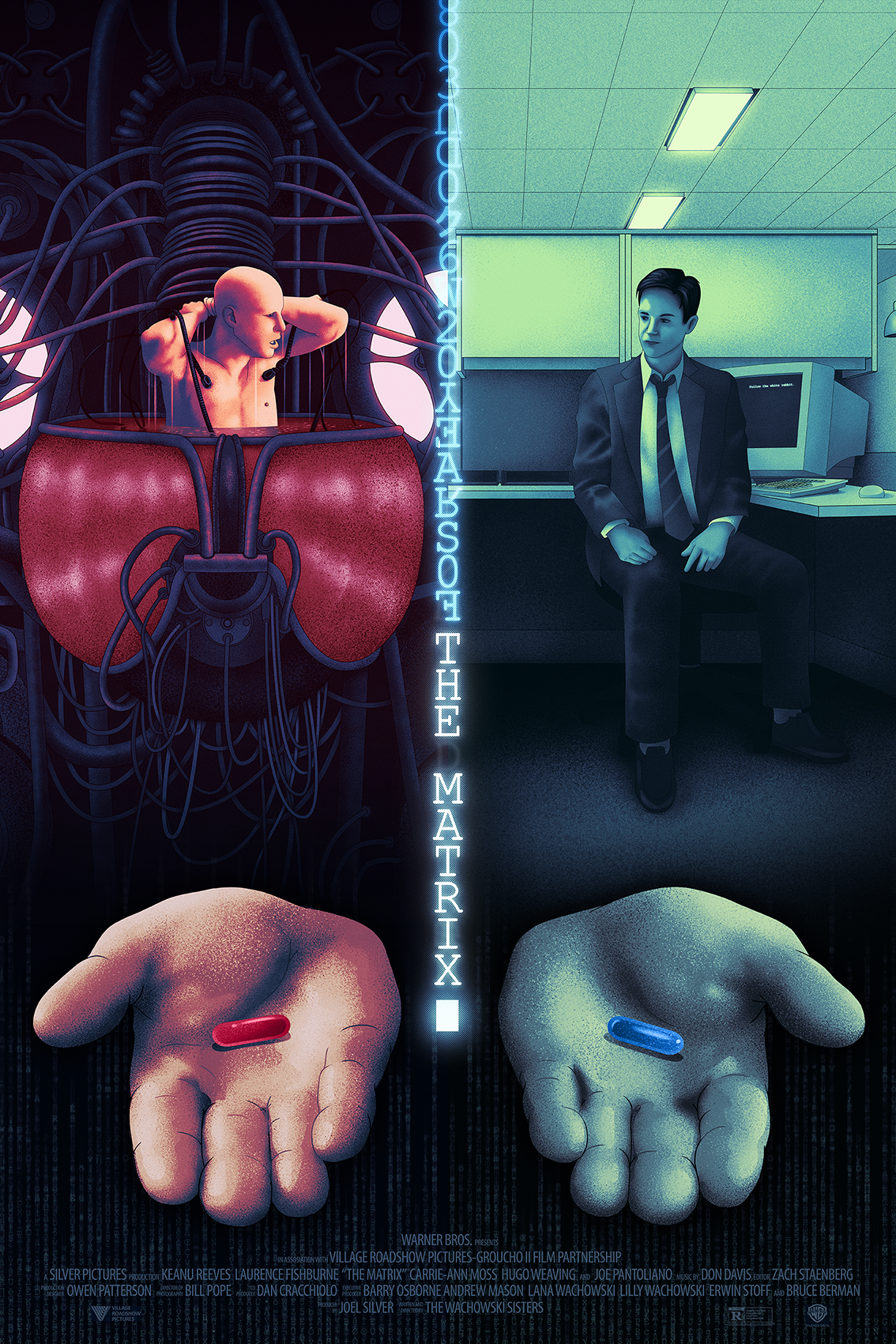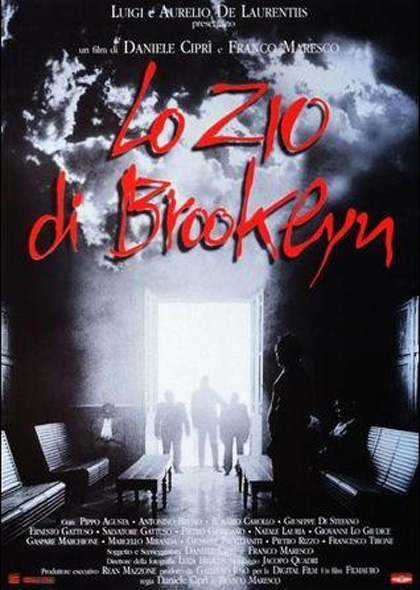Lo zio di Brooklyn del titolo è un personaggio che non dice una parola nell’intero svolgimento della trama, e che l’unica che dirà (quando vorrebbe rivelare il proprio nome) sarà coperta da un sonoro peto. Giocando sui toni del grottesco all’italiana brutalizzati ed essenzializzati dentro una Palermo che sembra post-apocalittica, Ciprì e Maresco realizzano questa opera prima nel 1995, dovendo buona parte della propria fama all’attenzione che gli volle dedicare Enrico Ghezzi su Rai Tre.
Girato nel bianco e nero più ruvido che si possa immaginare, fu caratterizzato da personaggi grotteschi, isterici e rivoltanti. All’epoca fu in grado di innescare polemiche a non finire sul contenuto del film, senza che nessuno capisse che i due registi stavano inventando qualcosa di nuovo, qualcosa che sarebbe stato (spesso malamente o confusamente) imitato da molti altri: un cinema d’essai che sbeffeggia e parodizza prima di tutto se stesso, poi la critica snob (c’è il personaggio del critico musicale, che spesso sbaglia e non trova le parole giuste per esprimere concetti che, nelle intenzioni, vorrebbero essere parecchio elaborati), e poi attacca almeno una parte del pubblico delle sale.
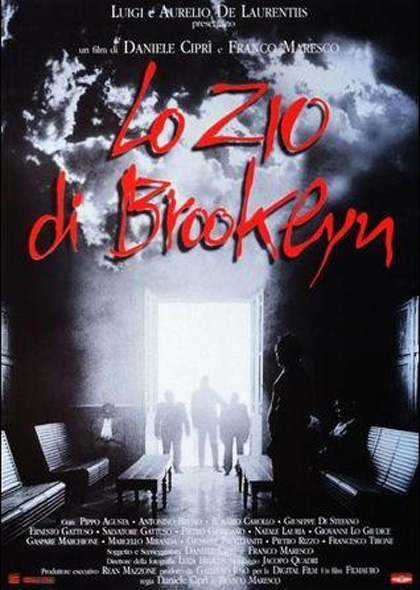
Viene quasi in mente, a riguardo, il mai abbastanza compreso “Largo all’avanguardia, pubblico di merda” di Roberto “Freak” Antoni e dei suoi Skiantos. Il codice comunicativo dei personaggi è stravolto rispetto a qualsiasi canone cinematografico, o addirittura di buon gusto: molte scene sono cinicamente inquadrate da lontano, e i due nani protagonisti, ad esempio, comunicano mediante rutti.
[il dadaismo] rifiuta gli standard artistici, come dimostra il nome dada che non ha un vero e proprio significato, tramite opere culturali che erano contro l’arte stessa.
Soprattutto le canzoni interpretate nel film sembrano voler rivestire un’importanza fondamentale – e con dei tratti dadaisti, nell’uso delle parole, in alcuni passaggi.
(rivolto alla camera) 1,2,3,4…
Ma cosa fa?
Conto gli spettatori! … 5,6,7, …
Il fimm da schifo! Il fimm fa schifo! Dove vai, lurido cane rognoso! Uno spettatore se n’è andato via.
Lo Zio di Brooklyn: il degrado penetra nei classici della musica italiana
Il contesto del film è interamente popolare, e dai tratti rozzi e semplicistici, tanto da suscitare una sensazione straniante fin dall’inizio. Già dal trailer, del resto, si intuiva che molto del film sarà determinato dall’accostamento tra i temi sobri ed eleganti della musica italiana vs. volgarità e peti vari.
Il riferimento, qui, sembra essere la celebre esibizione di Wanda Osiris di uno dei suoi brani più famosi, Sentimental, in cui la diva scendeva le scale durante il canto – in modo malamente imitato dal buon Paviglianiti (attore palermitano scomparso nel 2000).
Parte del feeling generale de Lo zio di Brooklyn è incentrato sul tema della desolazione, della solitudine e dell’amor perduto, almeno a sentire le parole delle canzoni proposte: il film non ha una colonna sonora vera e propria, per cui è lecito andare a riascoltare le canzoni che sono state reinterpretate per l’occasione dagli improbabili, trash e grotteschi personaggi.
Cammela (Chianese, Palombo)
In questa sequenza il personaggio di Anciluzzu canta “Carmela” (di Gugliermo Chianese and Salvatore Palombo) mentre aspetta le patate che ha chiesto al vicino. La scena ha una valenza teatrale e fortemente straniante, avviene senza un esplicito motivo e si avverte una costante dell’intera pellicola: i personaggi cantano e, nel contempo, danno l’idea di voler fuggire dallo schermo, trovando rifugio tra quegli stessi spettatori che, paradossalmente, finiranno per rigettarli.
Mamma di Cesare A. Bixio e Bruno Cherubini
La sequenza vede un personaggio cantare (fuori campo) il celebre ritornello di Mamma di Bixio, Cherubini con forte inflessione siciliana, stonando spesso e volentieri, degenerando in un improbabile falsetto, mentre due personaggi (il mago Zoras e Lo Giudice, protagonista di uno dei medley più importanti del film) si fissano ad un tavolo.
Poco dopo, gli gli verrà consegnato una collana, che non dovrà togliere per nessun motivo perchè dagli improbabili effetti magici.

Ancòra di G. R. Testoni
Uno dei brani più indimenticabili del film, a questo punto, è Ancora di G. R. Testoni. Il testo del brano è intatto, e mantiene la sua carica grottesca: sembra che il personaggio sia un improbabile musicista di strada, che cerca l’approvazione di quel pubblico tanto “temuto” di cui sopra.
https://www.youtube.com/watch?v=7d355UPxTKk
Chella llà (U. Bertini)
Al minuto 13:00 circa, per citare un ulteriore esempio, si può gustare una versione parodizzata ed ultra-ermetica di “Chella lla” (originale scritto da Umberto Bertini e musicata da Di Paola/Taccani), intervallata da pernacchie ed insulti (“Suca!”), oltre che da un testo leggermente cambiato.
Uuuula! Vàsami, vàsami, vàsami, prrr!
Chilla lla chilla lla
te pare ca mpazzisc e poi me sparo
polli… tutti polli sono!
Playboy di G. Lo Giudice
Playboy di Giovanni Lo Giudice, tanto per fare un esempio ancora più dada, ripete ossessivamente la parola del titolo con un testo delirante, probabilmente improvvisato sul momento dall’attore.
Il testo recita pressappoco questo:
playboy, playboy, playboy,
playboy, playboy, playboy
no, non sono un playboy,
sono un ragazzo romantico,
che crede ancora nell’amor,
perciò ti dico no,
il playboy oggi è quello che ha i soddi,
anche se è basso, pelato o grasso
Il senso del brano, sconnesso e volutamente fuori tempo in molti passaggi, assume una valenza grottesca se inquadrato nel giusto ambito: bisogna pensare che non ci sono personaggi femminili nel film, e che – soprattutto – poco prima abbiamo assistito alla famosa (ed oggetto di infinite polemiche) scena di zoofilia con una mula.
Lo stesso tema ricorre in seguito all’interno dello stesso film, dove assume una parvenza dai toni più tragici, rassegnati e desolanti. Che senso ha, a quel punto, essere un playboy – se comunque vivi in una città abbandonata, dai tratti post-apocalittici, in cui basta avere i soldi per vivere bene, e potresti diventare un Casanova anche se sei basso pelato o grasso?
Curtiello cu curtiello (Fiorini, Di Domenico)
Questo pezzo viene proposto durante il minaccioso interrogatorio di Tommasino nei confronti di due diseredati, che ne elogiano (nonostante tutto) le doti canore.

L’originale è stata interpretata tra gli altri da Mario Merola, ed è nota per la sua versione cinematografica.