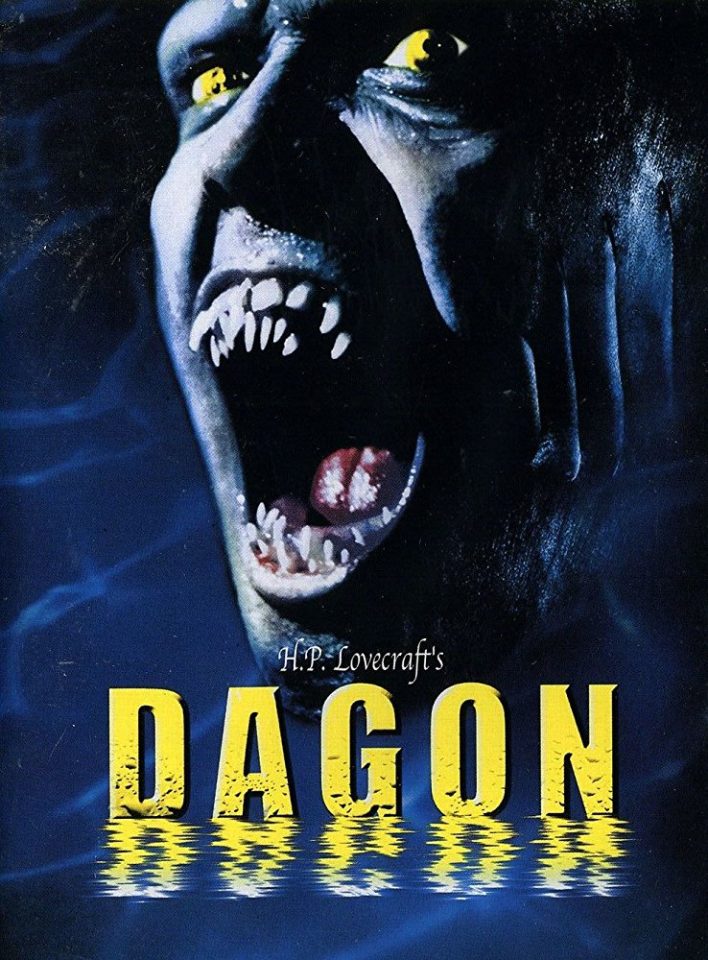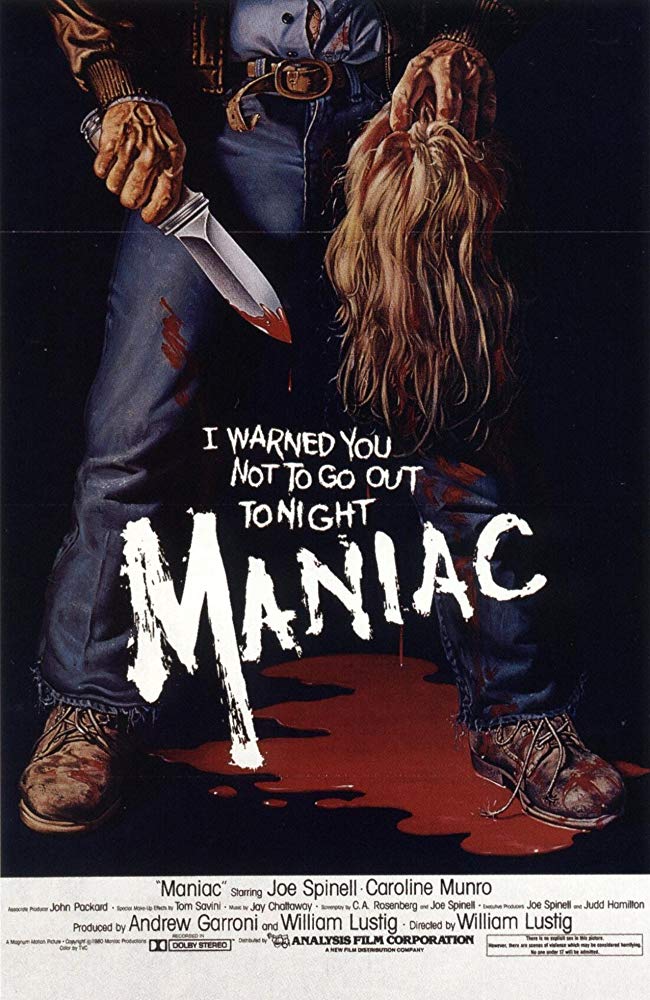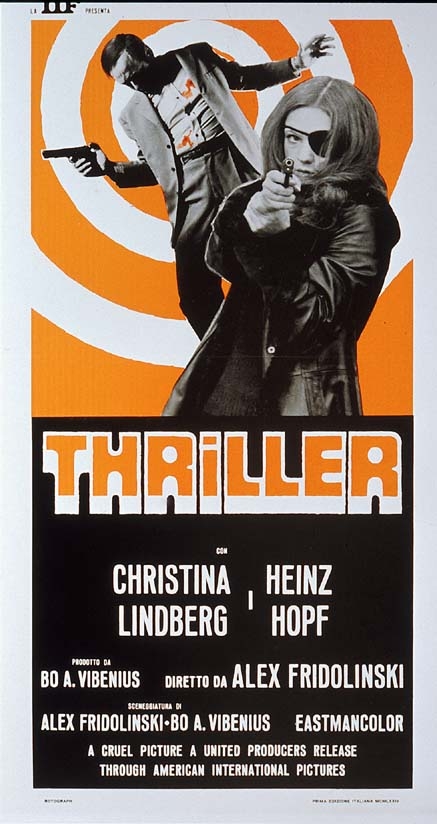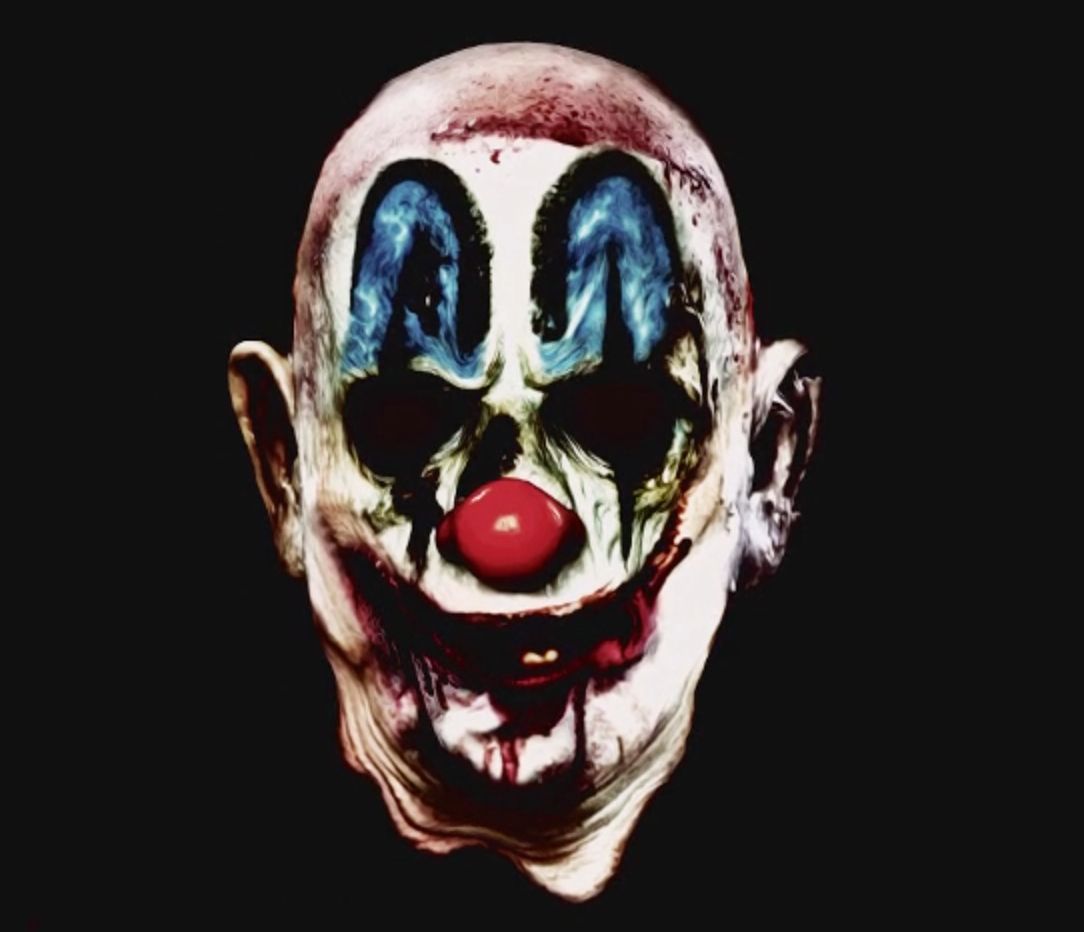“Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” è un classico del cinema italiano che, a prima vista, potrebbe sembrare un affresco spensierato di un’avventura estiva come tante, giusto nei pressi del mar Mediterraneo (più precisamente dalle parti della Sardegna). Questa considerazione nasce – quasi certamente – dall’averlo ridotto ad alcune scene emblematiche, o dall’averlo reso un meme senza badare alla sostanza (che è mastodontica, a ben vedere).
Diretto dalla sapiente regia di Lina Wertmüller, si tratta di un vero e proprio trattato socio-politico sulle differenze di genere e di classe, rappresentate da un lato dal maschio comunista (il marinaio Gennarino) e dall’altro dalla donna borghese (la snob Raffaella). Il conflitto è esasperato dal fatto che i due saranno costretti a rimanere su un’isola deserta da naufraghi, condividendo loro malgrado la cattiva sorte. Ma cosa succederà alla loro relazione?
Prima di raccontare ciò che questa gemma del cinema anni Settanta ha rappresentato per generazioni di cinefili è opportuno precisare ciò che questo film non è: non si tratta propriamente di un film d’amore, se non di un amore tragico e dalla conclusione quasi nichilista. Non si tratta nemmeno di un riassemblamento favolistico sulla falsariga di Incantesimo nei mari del sud (più noto negli anni Ottanta come Laguna blu), come la storia dei due naufraghi che finiscono per innamorarsi potrebbe suggerire allo spettatore non troppo attento. Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto è semmai uno dei film più politici mai girati in Italia, e anche uno dei più controversi e discussi: la relazione tra l’insopportabile e frustrata Raffaella (Mariangela Melato) ed il rude e patriarcale Gennarino (Giancarlo Giannini) è una metafora della relazione tra la classe sociale sfruttata e quella sfruttatrice, e naturalmente di cosa succederebbe se quella relazione fosse invertita (l’effetto di una rivoluzione primitiva e senza fronzoli, in sostanza). Se la circostanza oggi probabilmente si capisce poco è soprattutto per via della regressione dialettica che la politica ha subito, diventando uno scontro frontale delle ideologie a singhiozzo, che si richiamano solo quando serve o al limite per denigrare l’avversario. All’epoca dell’uscita del film la percezione era differente, perchè anche un film così finiva per suscitare reazioni più o meno scomposte, provando al contempo a ingenerare un dibattito sensato sui temi della violenza di genere, della lotta di classe e del contesto sociale in cui vivevamo a quei tempi.
Nell’amore non c’è volgarità… ve la siete inventata voi borghesi, la volgarità.
Nonostante le difficoltà iniziali Raffaella e Gennarino si adeguano allo stile di vita dell’isola, sia pure tra mille contrasti e prefigurando una forma di amore che, per quanto grottesca, è realistica, al punto potrebbe assimilarsi ad almeno una storia di vita reale che potremmo aver vissuto, stare vivendo o aver sentito da un amico o amica. Il richiamo al primitivismo è l’essenza del film, che prova ad immaginare come vivrebbero due novelli Adamo ed Eva in una società senza tecnologia e senza progressi, declinandosi come film che non riesce a far sorridere senza far riflettere, che non esita a portare il parossismo fino ad una violenza che, di per sè, non ha nulla di scenografico o di puramente visuale.
La violenza del film, quando compare, è cruda, realistica, inattesa, quasi documentaristica: nella situazione iniziale Raffaella è una borghese colta, fintamente impegnata nella politica e sprezzante verso meridionali e classe operaia in genere, mentre Gennarino è un marinaio che conosce il mondo e possiede “il senso delle cose” e della pratica, al punto che riesce ad organizzarsi per sopravvivere sull’isola deserta senza intoppi. La donna, da sfioratrice del mondo appoggiata sugli allori, dovrà scendere ad inaccettabili compromessi pur di continuare a vivere, riscoprendo una parte di sè sepolta nel proprio inconscio e nel proprio essere spensieratamente borghese. In questo frangente Gennarino diventerà sempre più violento e aggressivo nei suoi confronti, formalmente con il pretesto di insegnare alla donna cosa significa lavorare per vivere, mentre Raffaella subirà passivamente la violenza, nascondendosi dietro un’ambiguo atteggiamento fatto di sopravvivenza, rassegnazione e presunto amore.
È chiaro che si tratta di un film figlio del suo tempo, che oggi non sarebbe più realizzabile e susciterebbe reazioni ancora scomposte – proprio per quella violenza di cui si parla, decisamente insolita rispetto alla media, che finisce quasi per strizzare l’occhio a certa exploitation del primo Wes Craven o di Mario Bava. Nel momento in cui la relazione tra i due protagonisti si ribalta, infatti, esce fuori il lato oscuro del personaggio di Gennarino, il quale (nonostante la parvenza simpatica e da Peppone della situazione) è un uomo possessivo ed espressione di quello che oggi viene indicato con lo slogan men are trash: un un uomo egocentrato e tendenzialmente violento che considera la donna una preda da braccare. Nonostante abbia subito insulti e soprusi dettati dall’arroganza di Raffaella, in effetti, non è scontato che il pubblico empatizzi con lui. È in questo mood che mi sembra di ravvisare una qualche somiglianza con ciò che suscitano i film exploitation, che all’epoca andavano piuttosto bene e che, ancora oggi, sono difficili da distribuire e popolarizzare (nonostante ci sia una forte nicchia di pubblico che continua a seguirli).
Chiaro che, con gli occhi di oggi, non bisogna commettere l’errore di considerare il tutto pura graphic violence (come i tarantiniani puri saranno tentati a fare) o peggio, di ergerla a manifesto del politicamente scorretto, addirittura finalizzandolo al voler normalizzare la violenza sulle donne. Il punto infatti non sembra la violenza sulla donna in astratto, ovviamente deprecabile in ogni luogo e tempo (lo dimostra se non altro l’insistere della camera su gesti che prima sono aggressivi, poi sono violenti, ad un certo punto diventano amorosi o sessuali e poi, tragicamente, si assestano come un mix indefinito tra amore e violenza). Nè tantomeno possiamo farci bastare la falsa rassicurazione che sia stata una regista a realizzare l’opera, perchè questo rischierebbe anche involontariamente di depotenziare il senso dell’opera e banalizzarlo. Il focus di Travolti da un insolito destino è invece la relazione politica tra due classi, l’inconciliabilità tra due estremi che hanno rovesciato il loro rapporto in senso rivoluzionario (il naufragio) e pagano le conseguenze della violenza insita in ogni rivoluzione (e da questo sembra trapelare, se non altro, disillusione). Le ripetute botte su Raffaella, unita al suo continuo scandalizzarsi per ciò che accade (addirittura durante le scene d’amore), è una misoginia realistica funzionale a raccontare un fatto politico, a denunciare che una rivolta puramente di pancia porta comunque alla rovina dei protagonisti, su cui lo spettatore non potrà fare a meno di fare delle riflessioni soprattutto in vista del twist finale, mai abbastanza citato quando straziante nel suo incedere: Gennarino rimarrà tragicamente solo per aver dato troppo amore senza rendersene conto, mentre Raffaella tornerà nella zona comfort che detestava.
Questa prospettiva testimonia che dopo più di cinquanta anni dall’uscita (il film arriva nelle sale nel 1974) molte questioni di genere sono rimaste irrisolte (ed è questo che fa riflettere, alla fine), mentre gran parte della destra e una discreta parte della sinistra continua ad avere seri problemi in fase di accettazione dell’altro, così come ad uscire dagli stereotipi della “donna del popolo” primordiale, controllabile e poco evoluta, ma anche della pluri-citata “bottana industriale” cinica ed opportunista anche in amore. Luoghi comuni, forse, ma che vengono bellamente attribuiti ancora oggi a utenti dei social e influencer, in un mondo popolato di Raffaelle e Gennarini. Quei due protagonisti, forse, siamo noi – e non ce ne siamo ancora accorti.
Se si guarda il film dalle prime sequenze emergono aspetti dai quali sembra impossibile prescindere: in primis ci troviamo durante una vacanza di benestanti, ma su una barca a noleggio. Non di proprietà, e viene il sospetto che si tratti di esponenti della mid class, nè proletari nè propriamente borghesi. I marinai invece sono tutti meridionali o comunque di umili origini, mentre gli affittuari della barca leggono ostentatamente L’Unità, giornale ufficiale del fu Partito Comunista Italiano. Raffaella, dal canto suo, sembra fin da subito una chic odiosa e distaccata (ostentatamente critica verso chiunque, ma non certo una dei borghesi di Hanno cambiato faccia, per intenderci): critica i comunisti sovietici ma fa discorsi ecologisti, strizza vagamente l’occhio ai progressisti per vezzo ma poi sembra radicata nel mondo agiato e stucchevole a cui appartiene. Perchè la denuncia più forte di Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto pone l’accento sul fatto che non basta evidentemente essere rivoluzionari e incazzati contro le palesi ingiustizie che subiamo per cambiare le cose, nè basta una dittatura proletaria per risolvere la questione. La regia, in questo, è ossessivamente concentrata a mostrare ogni dettaglio della nuova vita della strana coppia, mostrando un’isola in cui sembra esserci ben poco da scoprire e quasi nulla per sopravvivere (a parte le uova degli uccelli, i pesci, le aragoste e naturalmente l’amour).
Se dobbiamo riorganizzare la società, sembra suggerire il film, dobbiamo comunque fare i conti con gli abusi e le degenerazioni che saranno insiti nella natura umana, non semplicemente sfiorare la questione in maniera blanda o teorica come fa la protagonista. Personaggio peraltro incapace di difendersi e costretta a soggiacere all’amore per pura sopravvivenza, travolta dall’insolito destino di essere in balia di un proletario che tutto può giusto su un’isola deserta, ed è condannato ad un’esistenza grama e piatta non appena rientrato nella civiltà. Che questo film finisca per disturbare per varie ragioni, far sorridere e provocare disagio – o addirittura fastidio – anche dopo mezzo secolo suggerisce, se non altro, l’importanza delle tematiche che tratta, e la loro pressante attualità. Per i due naufraghi la disavventura è un modo, alla fine, per provare a riappropriarsi di se stessi e della propria istintualità repressa, senza riuscirsi e anzi, sacrificando il proprio mondo.
Ma se vuoi stare qua e vuoi mangiare, devi lavorare! Hai capito?
Travolti da un insolito destino è considerato molto impropriamente una commedia all’italiana con un messaggio semplice e chiaro, ma i toni risultano multi-sfaccettati, forse più grotteschi che vuotamente divertenti, un po’ come nel mood dell’epoca e di quel tipo di regia (le regie “militanti” sono state molto frequenti negli anni Settanta, e in parte degli Ottanta). Se Roger Ebert elogia questo film e lo fa risalire a L’anima e la carne, del resto, la rivista Première lo annovera tra i 100 film che hanno sconvolto il mondo, nonchè “uno dei film più audaci mai girati”.

IMDB si è divertito a snocciolare i temi principali che tratta il film, in una divertente alternanza tra italiano ed inglese (si tratta probabilmente di tassonomie create dagli utenti stessi): la lista fa pensare a ciò che il film non è, letta d’un fiato, anche se effettivamente tutti i temi sono tabù affrontati dal film. Parliamo di sodomy, misogyny, rapporto marito moglie, trophy wife, machismo, upper class, lower class, social class, class society, society, mare, ship, mediterranean sea, rape turns to consensual sex, enemies become lovers, castaway, incagliato, abuso, domestic abuse, yacht, stranded on an island, italiano, slapped in the face, island, role reversal, naufragio, diretto da una donna, razzismo, triple f rated, female topless nudity, survival adventure, poverty, wealth, horny wife, cheating wife, horny woman begs for sex, large breasts, sexually dissatisfied wife, woman humiliates man, wife raped, naked female breasts, comunista, female sex slave, class difference, submissive woman, sex scene.
Tra momenti di tensione e di ironia sempre ben bilanciati, “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” offre in definitiva uno sguardo critico verso la società e le sue convenzioni, spesso con un pizzico di sarcasmo. Se vi aspettate un film leggero, preparatevi a confrontarvi con elementi come la disparità di classe e le relazioni interpersonali complicate, il tutto condito da una buona dose di umorismo e spunti di riflessione.
Il film è stato girato sulla costa orientale della Sardegna, in provincia di Nuoro, e per qualche tempo è stato previsto un sequel, anche l’idea fu abbandonata dopo la scomparsa di Mariangela Melato. Fu pero’ realizzato un remake, intitolato “Travolti dal destino” (titolo originale Swept Away) diretto da Guy Ritchie e interpretato da Madonna e Adriano Giannini, figlio di Giancarlo. Un film che, in almeno un’occasione, Mariangela Melato stroncò come “orribile”, che non coglieva il senso dell’opera originale, nè nel senso politico nè in quello più sentimentale o sociale.