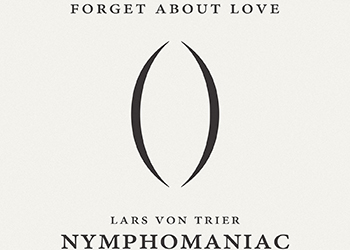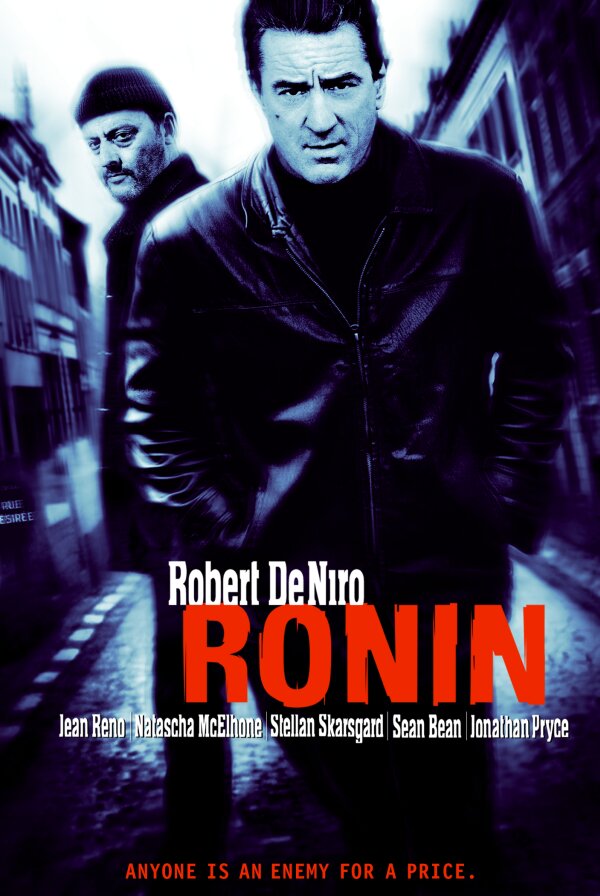Capolavoro di horror gotico all’italia di Pupi Avati, ambientato in un suggestivo paese italiano che diventa teatro di orrori sepolti nell’inconscio collettivo.
Stefano è un maestro di restauro, interpretato da Lino Capolicchio, che viene inviato in una chiesetta di uno sperduto paese padano – molto dettagliata la ricostruzione dei luoghi fatta sul Davinotti online, a tal proposito – al fine recuperare un prezioso dipinto raffigurante il martirio di San Sebastiano. L’autore dell’opera è un pittore del posto, morto anni prima e apparentemente suicida, alla cui storia il protagonista inizia ad interessarsi. Con lo svolgersi di una intricatissima trama si verrà a scoprire di una misteriosa “casa dalle finestre che ridono“, così chiamata per le finestre bizzarramente dipinte con caratteristiche labbra, la quale nasconde imprevedibili verità. L’autore dell’opera è il defunto Buono Legnani, artista maledetto e soprannominato “Pittore di Agonie”, dato che amava ritrarre le persone pochi istanti prima della loro morte, usando il proprio braccio come tavolozza dei colori. Il passato dell’artista sembra essere macchiato da torbidi e morbosi segreti. Stefano si troverà coinvolto in un’atmosfera maligna e perversa, nella quale in definitiva niente (e soprattutto nessuno/a) è quello/a che sembra.
Un cult recentemente rieditato in DVD per il suo 25° anniversario dall’uscita, ricco di contenuti speciali ed approfondimenti, trasmessi sulle televisioni commerciali più volte negli ultimi anni in edizione uncut. La casa usata per le riprese – e che da’ il nome al film – si trovava a Malalbergo, nei pressi di Bologna, e stando a IMDB è stata demolita poco dopo la fine delle riprese. Gran parte del film si incentra sul martirio di San Sebastiano, figura iconica della cultura cristiana, spesso rappresentato nel cinema (da Carrie di Brian de Palma a Sebastiane) e generalmente simbolo di sopportazione della sofferenza, di coerenza estrema con i propri ideali. Nel film di Avati è un simbolo di una strana religiosità dai tratti pagani, che evoca sacrifici umani compiuti di nascosto dalla popolazione del posto – vagamente sulla falsariga della psicosi collettiva, realmente accaduta, che ha reso celebre i Diavoli della Bassa modenese.
Il film di Avati è clamoroso perché anticipa di diversi decenni quello che poi avremmo chiamato folk horror, l’orrore legato alle tradizioni popolari e ai culti segreti che ha avuto massima espressione con film come Oltre il guado, The Vvitch, Antlers e Road to L. del resto la parte horror è centellinata – quando arriva è sempre sostanziale: le coltellate alle vittime il pubblico sembra quasi doverle subire fisicamente – sia pure trattandosi pur sempre di un film a basso budget, che non consentiva l’utilizzo di effetti speciali troppo elaborati. Eppure il lavoro di Avati funziona, impressiona, appassiona e continua a funzionare dopo anni, rientrando nel novero dei film di culto per i quali l’etichette B-movie sembra stare anche un tantino stretta.
Una certa critica e parte del pubblico avevano subito notato la singolare ambientazione italiana per un film che, in generale, ci saremmo aspettati nel New Jersey o nel Texas. Ma ci troviamo – inaspettatamente per il genere – tra Comacchio e Minerbio, in Emilia Romagna, e di per sè la storia del film nasce da un fatto di cronaca che Avati ricorda e rielabora: la tomba di un prete che si scoprì contenere il corpo di una donna. La cadenza di tutti i personaggi in tal senso vuole essere inequivocabile,e caratterizza un’ambientazione che parla di noi e dell’insospettabile oscurità di certo folklore nostrano (si veda, ad esempio, l’Almanacco dell’orrore popolare di Camilletti e Foni).
Spiegazione del finale (spoiler)
Assistiamo sulle prime alla fuga di Stefano, che sembra riuscire a sfuggire alle due sorelle assassine che non hanno risparmiato dal martirio la povera Francesca. Ma il twist narrativo è in agguato: nessuno, in paese, sembra disponibile ad aiutare Stefano, che si aggira tra strade deserte e case con le finestre chiuse. L’unica persona che apparentemente dalla sua parte sembra essere l’imprenditore che gli ha finanziato il lavoro, che si limita a chiamare la polizia e rimane barricato in casa. A Stefano non resta che rivolgersi al prete del paese, che lo accoglie in modo apparentemente amorevole per poi rivelare l’orribile verità: la seconda sorella – quella che non si è mai vista in viso – è in realtà proprio lui. Stefano si ritrova nuovamente in trappola, pronto per la macabra evocazione del martirio di San Sebastiano. Avviene quindi ciò che Merenghetti chiama “il finale sospeso”: vediamo l’esterno della chiesa e sentiamo le urla di aiuto di Stefano, sentiamo le sirene della polizia evidentemente in arrivo mentre viene ripreso un altro con una mano che si appoggia allo stesso. Saremo curiosi di sapere cosa succede adesso ma partono i titoli di coda, e l’immagine si congela. La trovata di Avati è in questo caso quella di suggerire un’ambiguità: le autorità sono complici dell’orrore oppure no? Riuscirà Stefano a salvarsi una seconda volta? Detta in modo più coerente con gli standard narrativi della TV generalista, la polizia arriverà in tempo per salvarlo?
Una certa antropologia pessimista – forse anche una certa critica politica e sociale – suggeriscono che non ci siano speranze per il protagonista, ma al tempo stesso il prodotto rimane potenzialmente “commerciale” proprio perchè nulla esclude che possa avvenire un salvataggio con tanto di colpo di pistola che ferma le assassine proprio nel momento clou dell’ennesimo delitto.