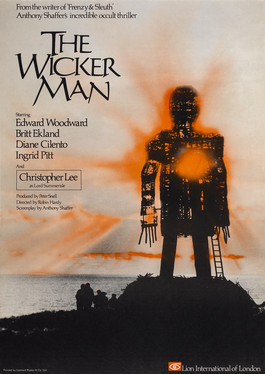Una storia cattiva e ricca di shock emotivi per un ennesimo, incredibile, film sui generis.
In breve. Riduttivo definirlo horror: un film completo, coinvolgente e altamente disturbing (sfido chiunque a proseguire la visione entro la prima mezz’ora). Per il pubblico dallo stomaco d’acciaio, s’intende, un’opera perfetta e riuscitissima, che metaforizza l’esistenza come se fosse un’esibizione circense. Da giudicare dopo averlo visto per intero o, in alternativa, rinunciare del tutto all’impresa.
Dopo aver assistito a quello che molti indicano come il capolavoro spiazzante di Shion Sono, non mi sento in piena coscienza di consigliare questo film al primo che passa per la strada. Non che sia brutto, intendiamoci, ma è davvero una cosa che tocca le viscere per la sua crudeltà. Un po’ come avvenuto per Il centipede umano e per A Serbian Film – due “pugni nello stomaco” tutto sommato visionabili con qualche precauzione; qui siamo di fronte ad un film che esprime l’eccesso della violenza domestica, espressa in tutte le forme possibili (padre-figlia, madre-figlia, padre-madre). Il contorno grottesco delle figure circensi, del resto, servono molto poco a creare un clima caricaturale, perchè nessuno – credo – avrà niente di cui sorridere per circa due ore. Soprattutto in Italia, dove siamo molto poco abituati a vedere film impostati in questi termini brutali, presi come siamo dai rigurgiti pseudo-intellettualistici dei trentenni che si comportano da tredicenni (ed al massimo accettiamo parte della produzione di Tarantino), e questo dovrebbe mettere in guardia il pubblico meno avvezzo al cinismo su pellicola. E attenzione, non parlo della violenza bizzarra alla Tarantino bensì di quella realistica, cattiva ed amara di American History X, per fare un esempio ben noto, elevata all’ennesima potenza.
Stange circus narra, molto in breve, la vita di una povera ragazzina di appena dodici anni (Mitsuko), turbata dal padre pervertito – il quale non solo la obbliga ad assistere ai rapporti sessuali con la madre, ma inizia a dedicarsi attivamente all’incesto. Il segno di questa esistenza terrificante sembra riversarsi nel racconto di una scrittrice disabile: dunque tra uno scambio di identità e l’altro, come chiedono nel film stesso, “cosa è reale e cosa non lo è“?
La cosa davvero sconvolgente, al di là dell’argomento decisamente morboso – che nel nostro paese avrebbe implicato articoli velenosi, polemiche nella TV spazzatura, richieste di ritiro dalla circolazione, accuse di oltraggio alla decenza, agli uomini, agli animali ed agli Dei – è stata a mio parere la capacità di Shion Sono di affrontare il tema spinoso (la pedofilia) senza sconfinare in dinamiche che qualcuno avrebbe trovato quantomeno ambigue o peggio autocompiaciute. Sì, perchè le scene più spaventose vedono il cinico preside (il padre), poco prima intento a fare moralismo sul bene e sul male e ad inneggiare all’amore verso i fanciulli – fare sesso con la consorte (la bella Masumi Miyazaki) mentre è in corso uno scambio di ruoli tra madre e figlia. Lo scambio avviene perchè il brutale padre-padrone rinchiude l’osservatrice (moglie o figlia, a turno) dentro la custodia di una viola, nella quale ha praticato un buco, e forzandola ad assistere all’amplesso.
Tutto appare stravolto, a quel punto, per la piccola Mitsuko: anche il rapporto con la madre, inizialmente mite ed affettuosa, che diventa gelosa e indisponente nei suoi confronti. È l’idea di fondo ad essere profondamente disgustosa: e il tutto non diventa un mero pretesto per fare snuff, sia ben chiaro, perchè costruisce i presupposti solidi per un finale che, alla fine, compare limpido sotto gli occhi dello spettatore. Non aggiungo altro, per non rovinare la visione a nessuno, permettendomi di ricordare che lo stesso regista ha affermato che non è l’amore morboso verso i fanciulli ad essere il fulcro di questo suo lavoro.
Del resto, circa trenta anni fa, per il semplice sospetto che un minorenne avesse visto il bel corpo di Barbara Bouchet (cosa che avrebbe potuto fare ugualmente con una rivista qualunque, per la verità) Lucio Fulci subì un processo in piena regola, nel quale dovette dimostrare che il minore che porta l’aranciata alla procace protagonista di “Non si sevizia un paperino” fosse stato sostituito da una controfigura. Nessuno vuole processare, si spera, Shion Sono, osannato come regista horror ma, in verità, autentico cinesta fuori dalle righe, capace di strutturare le sequenze, creare ambienti da sogno (o da incubo), confondere i livelli della realtà e dare il giusto input agli interpreti. Qualche reminiscenza che sconfina in Shining di Kubrick (i corridoi lunghissimi nei quali si consumano i misfatti) e qualche altra chicca sparsa nel film contribuiscono ad autorizzarmi ad affermare che “Strange circus” sia un grandissimo (e molto incompreso) lavoro. Non per tutti, anzi i più sensibili stiano alla larga, questo è certo, ma qui resto dell’idea che Sono abbia girato il suo personale “Arancia Meccanica“; e, in caso, scusate se è poco.