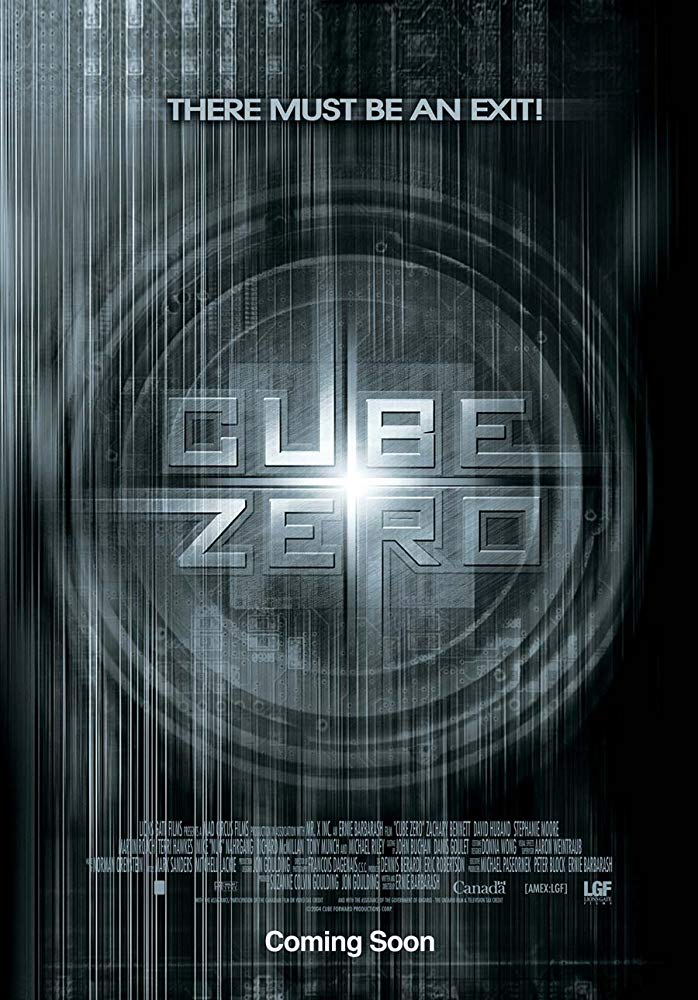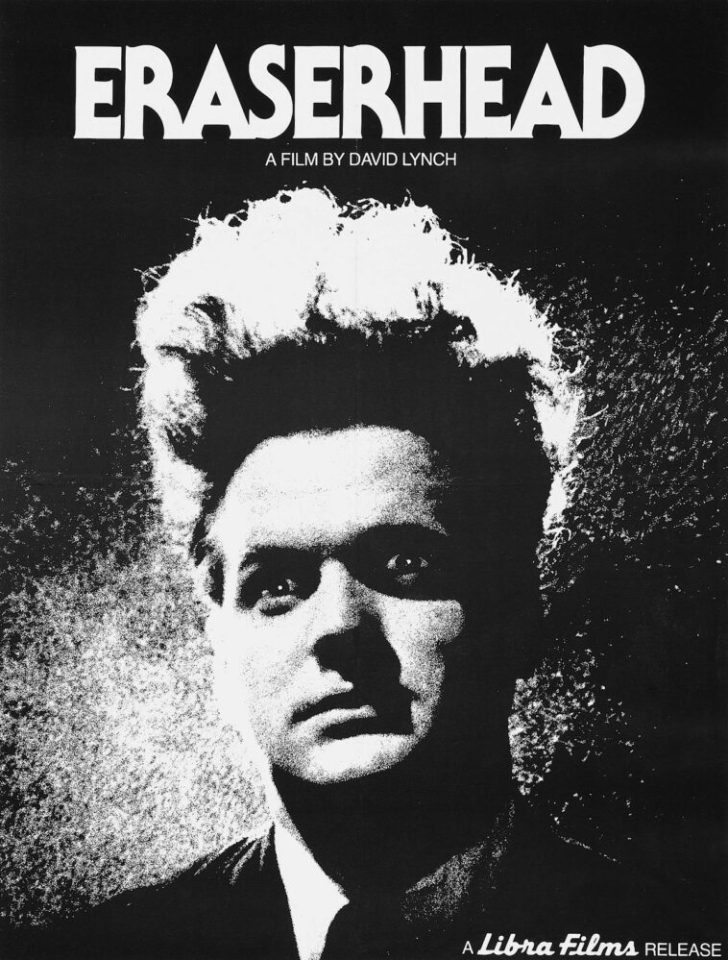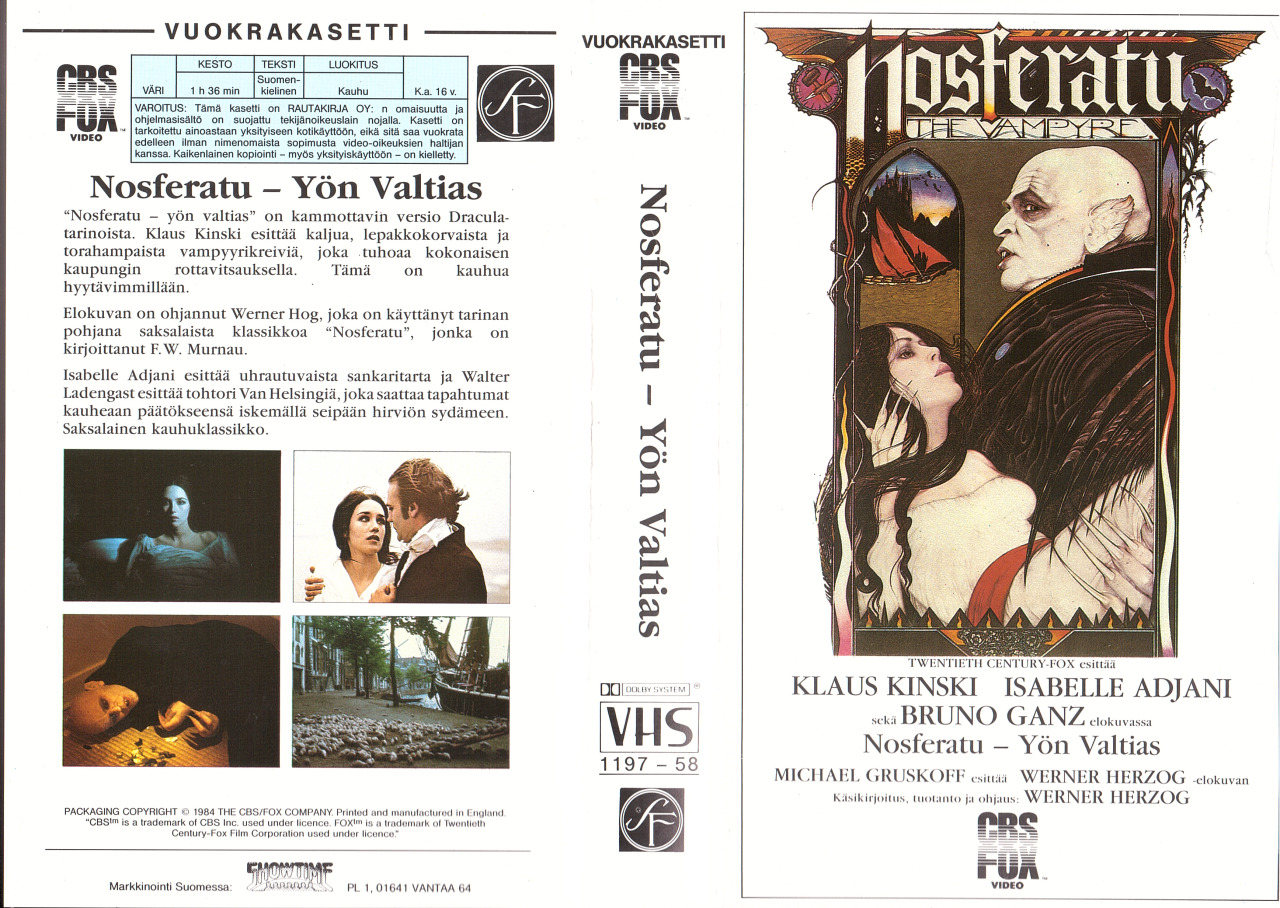Una donna si risveglia all’interno di un cubo iper-tecnologico cosparso di trappole: dall’esterno due “addetti ai lavori” stanno monitorando la situazione…
In due parole. Concettualmente vorrebbe riprendere (ed estendere) il capolavoro low-budget di Vincenzo Natali: ma il tentativo è riuscito in parte, ed il film è salvato dal baratro dell’anonimato da qualche effetto splatter sopra le righe. Coinvolge fino ad un certo punto, non dice granchè narrativamente e non c’è traccia, soprattutto, dell’atmosfera asfittica e tenebrosa del capitolo originale.
Da un punto di vista prettamente narrativo Cube Zero (nonostante le vaghe suggestioni del titolo, ed un inizio promettente) conferma una regoletta molto semplice, ovvero che i prequel riescono ad essere più inutili dei sequel, visto che – come accade in questo caso – rimpinzano un pubblico già sazio cercando di fornire spiegazioni ai limiti della forzatura. Dietro il cubo, in pratica, vi è il solito complotto dei militari, che avrebbero costruito una struttura cubica per intrappolarvi le persone e spiarle mediante avanzatissime telecamere (erano più “simpatici” quando fabbricavano zombi in laboratorio, verrebbe da dire). Un qualcosa di cui – e qui vengono i problemi – si fatica a comprendere lo scopo nonostante le spiegazioni in corso, e che fa quasi rimpiangere le violenze gratuite (tanto per capirci) dei più infimi torture porn (il livello di graphic violence di Cube Zero è elevato, ma quantomeno in quei controversi horror c’è uno psicopatico dichiarato come fautore dei crimini).
Se la sceneggiatura di questa pellicola del 2004 è piuttosto caotica e rimpinzata di dettagli inutili (quando non confusionari: a che serve aver”firmato il consenso” da potenziale prigioniero, se tanto ti cancellano la memoria?), si potrebbe dire qualcosa di meglio sulle interpretazioni, per quanto i personaggi sembrino un mero riciclo di quelli visti nel primo episodio. Credo quindi, nonostante qualche suggestione gore e qualche dettaglio tutto sommato non malaccio, che in questo capitolo il Cube devastante e nichilista del 1997 sia diventato un concentrato di aria fritta, strutturalmente più inutile e controproducente dell’abusivismo edilizio nel deserto. E anche ragionando nell’ottica utilitarista dei cattivi, del resto, non si vede la ragione per cui si dovrebbe tenere intrappolata gente all’interno di una struttura complicatissima, per testarne chissà quali capacità o reazioni, a maggior ragione del fatto che nessuno – o quasi – sembra essere riuscito ad uscirne vivo. Tanto valeva farli fuori direttamente, oppure confinarli nel solito ospedale come avveniva in film decisamente più riusciti (e molto meno pretenziosi) quali The experiment, Asylum Blackout o Il corridoio della paura. Tanto valeva, in alternativa, spingere sugli aspetti poco noti e misteriosi del Cube, piuttosto che ammettere – come fa uno dei personaggi – che quella struttura sia stata costruita coi “soldi dei contribuenti” (sic).
Vedere l’impiegato nerd ribellarsi e calcolare mentalmente i percorsi del cubo (con tanto di animazione tridimensionale) è un innesto più da film per adolescenti che altro, e non sembra tanto cònsono allo spirito originario, cinico e simbolista della pellicola originale, della quale qui restano solo vaghi, e zoppicanti, accenni. Guardare poi i militari incappucciati che narcotizzano altre povere vittime, in quest’ottica, rischia di produrre lo stesso effetto sul povero spettatore, che più o meno dalla metà del film in poi si accorge di qualche aspetto visuale e narrativo un po’ troppo “commerciale”, e questo fa crollare quasi tutto l’impianto, troppo proteso – in altri termini – a strizzare l’occhio al grande pubblico cercando di valorizzare più la pancia che la testa (macchinazioni governative, soldati controllati mediante chip, impiegatucci che obbediscono agli ordini come bravi cagnolini ed una strategia di boicottaggio ai limiti del ridicolo).
In definitiva un film che potrebbe deludere anche il fan “cubistico” più incallito, e che rientra probabilmente nei gusti di un settore di pubblico piuttosto ristretto: quelli che guardano tutto a prescindere, che sono intimamente masochisti o che magari scrivono spesso recensioni di film.