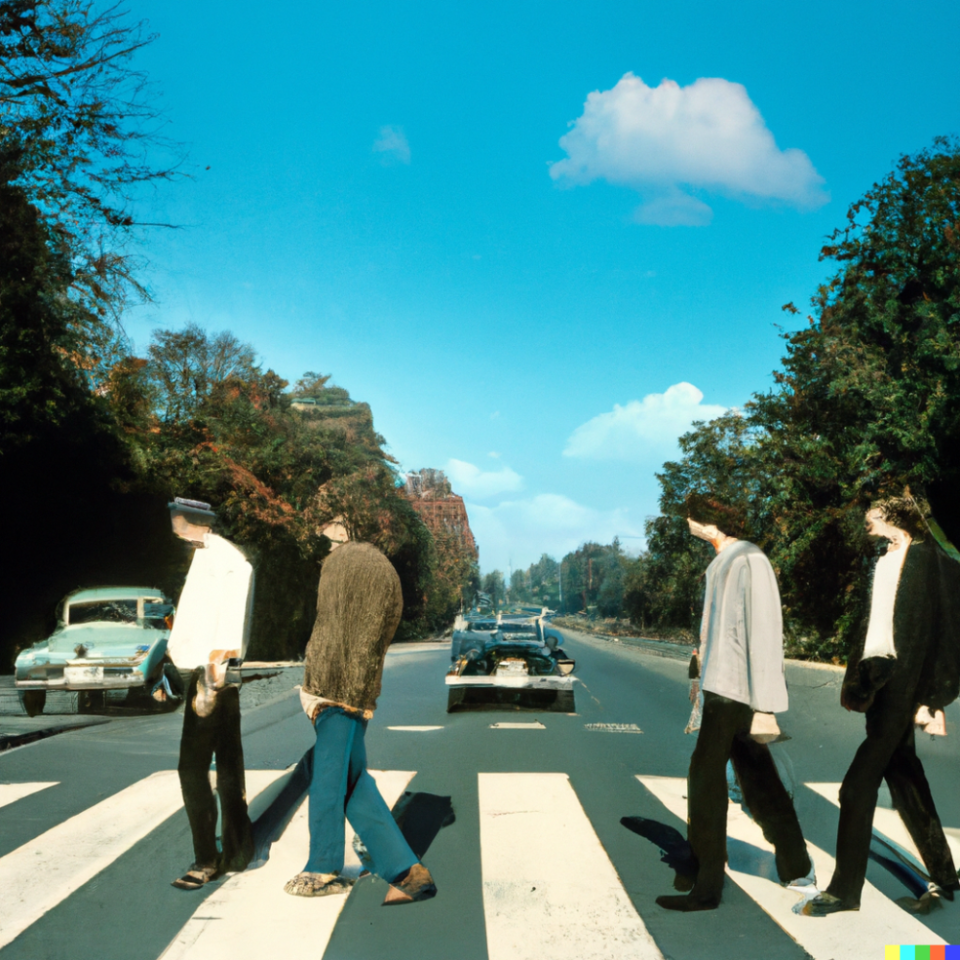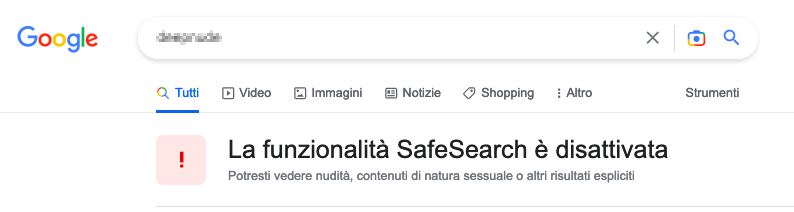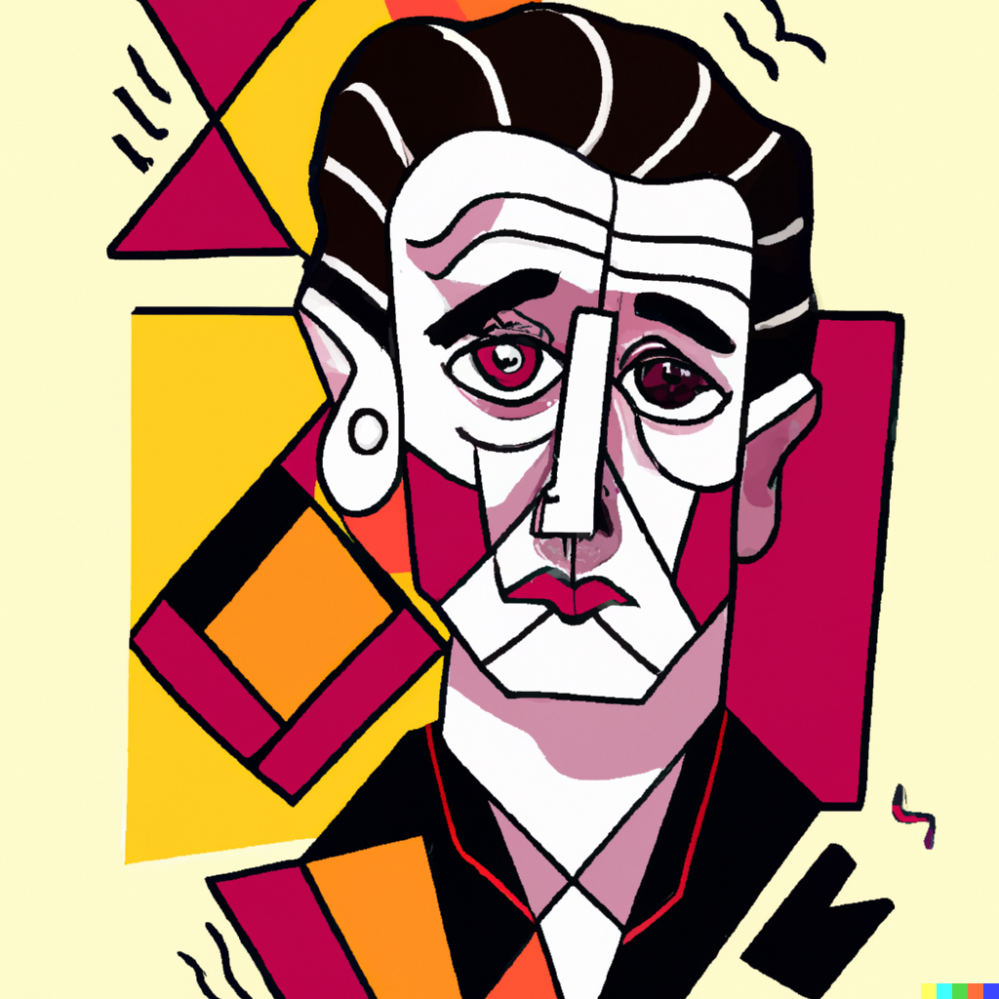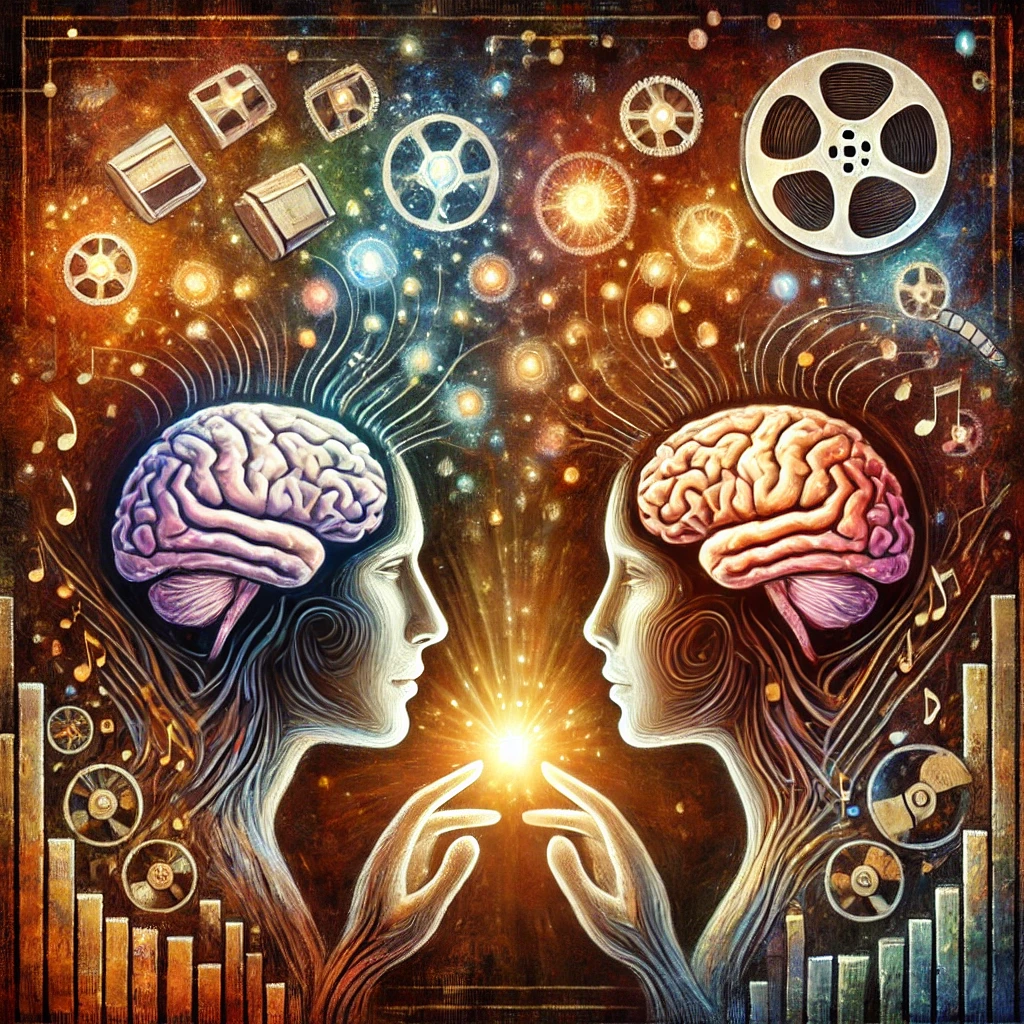Deepnude rappresenta, per quello che ne resta e ne sappiamo ad oggi, una delle forme più incredibili di pornografia reperibile su internet. No, su questo articolo non vi forniremo alcun link per scaricare deepnude, bensì ci concentremo sul parlarne in modo diretto e comprendere perchè sia considerabile il funerale simbolico di ogni fantasia sessuale, a qualsiasi latitudine.
Una pornografia che, come abbiamo notato in varie occasioni, si è liberata molto spesso di qualsiasi forma di fiction e di eleganza formale, confinandosi nell’abisso del realismo, dell’amatoriale, prima con la diffusione di foto e video amatoriali (esibizionisti), poi non consensuali e successivamente, in un atto di assoluta estremizzazione, mettendo a disposizione app di intelligenza artificiale in grado di “spogliare” le foto altrui.
Deepnude è il nome dietro il quale si annida questa particolare forma di deepfake, oggetto di molte attenzioni da parte dell’opinione pubblica nei mesi scorsi: i bot Telegram (gran parte dei quali estinti) in grado di espletare la funzionalità, una proposta di legge del 2021 in merito, un chiacchiericcio abbastanza indistinto in merito (tra spiegoni parziali o totali) e, fino a qualche tempo fa, addirittura il codice sorgente pubblico per espletare la discutibile funzione per qualsiasi programmatore esperto.
I rischi nell’uso di un’app del genere, che sconsigliamo di usare per molteplici ragioni, rimane formalmente illegale per quanto, anche qui, la bolla non sia scoppiata del tutto, sono reali. Non solo per chi li fa, che spesso non valuta che potrebbe subire lo stesso trattamento a sua volta da parte di terzi, ma anche per chi addirittura paga per un’operazione del genere. Ci sono servizi a pagamento sepolti tra i risultati di ricerca, poi rimossi, poi riemersi, in una battaglia senza tregua che ricorda quella dei siti web pirata che appaiono e ricompaiono all’attenzione del gentile (?) pubblico. Uno strumento per troll, alla fine, uno dei tanti strumenti che internet mette a disposizione e che risulta difficile, se non impossibile, da limitare, se non probabilmente spingendo ad un ragionamento differente dal solito, in merito.
Le fantasie sessuali sono in genere derubricate a “dedicare qualcosa a qualcuno”, in un’ottica semplicistica quando puerile. Un’ottica errata e da rivedere, ma la cui adesione incondizionata potrebbe portare a curiosare su questi lidi. Il punto chiave di un’app come deepnude, a ben vedere, è che feticizza il sesso nel senso stretto (commerciale) del termine: pago (il più delle volte, queste app sono a pagamento o addirittura a canone mensile) non una persona attraente e sessualmente disponibile in presenza, come farei con una prostituta, bensì dono uno o più oboli in favore di un’intelligenza artificiale, la quale (si spera) possa concretizzare la mia curiosità sessuale di vedere il corpo della vicina, della collega o del capo autoritario.
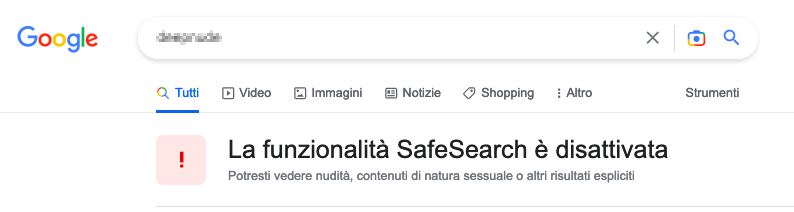
Le fantasie sessuali sono sottovalutate, e servono a compensare aspetti della vita non sessuali oltre, naturalmente, a tenere accesa la fiamma dell’interesse verso il sesso stesso con uno o più partner (male che va, anche da soli: è davvero ora di smetterla di derubricare la masturbazione ad attività per sfigati e sfigate). Si noti che le fantasie sessuali relegate ad un ambito mentale, salvo derive orwelliane prossime future, sono lecite, sempre, in ogni caso: possiamo immaginare di fare rough sex con la farmacista da cui andiamo sempre, possiamo sessualizzare la collega più giovane o fantasticare di sculacciare il capo autoritario. Possiamo immaginare le posizioni, l’atteggiamento, la pratica sessuale più atipica, il colore, la consistenza o la presenza assenza dell’indumento intimo, le espressioni facciali della persona oggettificata in quel momento, le pratiche più diverse e perverse: possiamo sognare che ci dicano sempr di sì, che non ci rigettino, che non ci respingano, che non ci facciano sentire in colpa. L’intelligenza artificiale del deepnude rimpiazza brutalmente tutto questo con una scelta su base statistica, rendendo la pornografia autentica macelleria virtuale. Un qualcosa su cui sarebbe ora di riflettere seriamente, almeno quanto parlare della deriva etica e morale annessa ad un qualcosa del genere.
Secondo la teoria sviluppata dallo psicologo statunitense Michael Bader (il suo saggio del 2018 Eccitazione. La logica segreta delle fantasie sessuali è illuminante in tal senso) la sessualità umana funziona in combinazione di vari livelli, non banali da raggiungere e spesso oggetto di psicosi: consolidamento del senso di sicurezza tra se stessi ed il partner (senza il quale è impossibile pensare eccitarsi), contrasto al senso di colpa, affermazione dell’idea di “spietatezza sessuale” senza la quale diventa molto complicato procurarsi e godere di un rapporto, problemi di transfert e identificazione che certe fantasie come il travestitismo risolvono. Non vogliamo sostenere che quelli che installano deepnude siano per forza malati psicotici (non abbiamo titolo per farlo, e non amiamo le etichette), ma sicuramente decidono volontariamente di abdicare le meraviglie delle fantasie sessuali in favore di “vedere” per forza qualcosa, con lo stesso criterio con cui si cercano video raccapriccianti sul web per il gusto masochistico di rimanerne turbati (o peggio ancora, di farci moralismo in seguito).
Il libro racconta il contenuto di varie sedute di pazienti (ovviamente anonimi o col nome cambiato) avuti da Bader, uno dei quali ad esempio fantasticava spesso su una ragazza molto più giovane di lui, fronteggiando un senso di colpa considerevole in merito. In realtà, spiega l’autore, la fantasia assume una valenza quasi terapeutica, in quanto assolve il fantasticante dal senso di colpa dell’aver ferito donne in passato, e nulla poteva meglio liberarne le fantasie dell’idea di una ragazza giovane e gioiosa, senza pensieri e senza rinfacciamenti di sorta. L’argomento vale, secondo l’autore, anche per le fantasie più pesanti, annesse a pratiche poco etiche o addirittura inaccettabili moralmente, che vanno dal sado masochismo alla pedofilia, passando per il cybersex, le parafilie come il pissing e le fantasie di sesso violento (il rough sex, anche lì fantasticato da diverse donne, anche nei casi in cui non si sarebbe mai sospettato: una paziente femminista militante o, nel caso di un uomo, un paziente risaputamente mite e gentile con la propria partner).
I commenti degli utilizzatori soddisfatti di servizi come deepnude, dando per buono per amor di discussione che siano reali, del resto evocano più il lettino dello psicologo che altro: sono felicissimo del servizio, perchè ha soddisfatto i miei sogni più veri. Grazie a questa app posso realizzare il sesso dei miei sogni. L’idea peggiore di deepnude è indubbiamente la sessualità non consenziente a cui si sceglie di partecipare, violando l’intimità dell’ignaro soggetto e togliendo di mezzo la fantasia, quasi declassandola a cosa di second’ordine. Ma la cosa ancora più brutale di deepnude, a questo punto, risiede proprio nell’idea di declassificare le fantasie a sesso di secondo o terz’ordine, sulla base della radicalizzazione del machismo per cui se una persona non posso averla e non riesco ad usare la mia fantasia ormai atrofizzata, posso farmi “aiutare” da un’intelligenza artificiale che spoglia le donne. Nel caso specifico, effettivamente, è un’intelligenza artificiale a prendere il posto della fantasia, deresponsabilizzando il soggetto e rendendolo, di fatto, intrappolato in una sessualità interdipendente dalla tecnologia.
Il punto chiave delle fantasie erotiche in genere, quali che esse siano, è che sono sepolte inconsciamente in ogni essere umano, e spesso compensano necessità della vita reale ed insoddisfazioni o frustrazioni di vario genere. Sono fantasie, per l’appunto, e rappresentano per le persone l’equivalente del potere della scrittura per autori tormentati come H. P. Lovecraft, he rappresentava come mostri secolari le sue stesse paure e, scrivendo, imparava ad affrontarle e tentava quantomeno di combatterle.
Per cui, sì: Deepnude è la Morte di qualsiasi fantasia erotica. Più precisamente, in senso strutturalista, è la Morte Simbolica, nel senso lacaniano del termine: perchè è l’espressione di un Altro con cui siamo in relazione, da maschi etero (e non solo, probabilmente) in relazione immaginaria. Tanto immaginaria che non esiste, non è mai esistita e mai esisterà, in uno slancio di tentato accelerazionismo che avremmo voluto conferire alle nostre vite sessuali. La morte è simbolica perchè uccide il simbolo, uccide la fantasia in quanto tale, distrugge qualsiasi parvenza di realismo alla fantasia stessa e si autoconsegna alle odiate tecnologie ed alle perversioni che solo esse sono in grado di darci. Del resto secondo Michael Bader le fantasie sessuali sono il buco della serratura attraverso il quale potremo vedere il nostro vero sè, e viene anche il dubbio che i deepnude (dietro quell’apparenza segreta, quanto perversa, che li rende sempre ricercabili su Google e attraenti per alcuni) finiscano per prendere il posto del sè, spersonalizzando la nostra esperienza, abusando della leva della curiosità e rendendola predeterminata da un algoritmo.
La fantasia sessuale (e non solo quella sessuale, del resto) non può essere definita adeguatamente da un algoritmo, che finirebbe per approssimarla in modo euristico, anche se ad alcuni va bene e forse, a quel punto, dovrebbero anche rivedere la propria autostima, o magari (se si può, senza traumi) la propria scala di valori. Cosa che rientra a pieno titolo nell’ambito della sessualità, ma non della fantasia: una forzosa fantasia che diventa uno spettro digitale che oggi, ancora, si aggira per la rete.
Foto di copertina: Anna Shvets