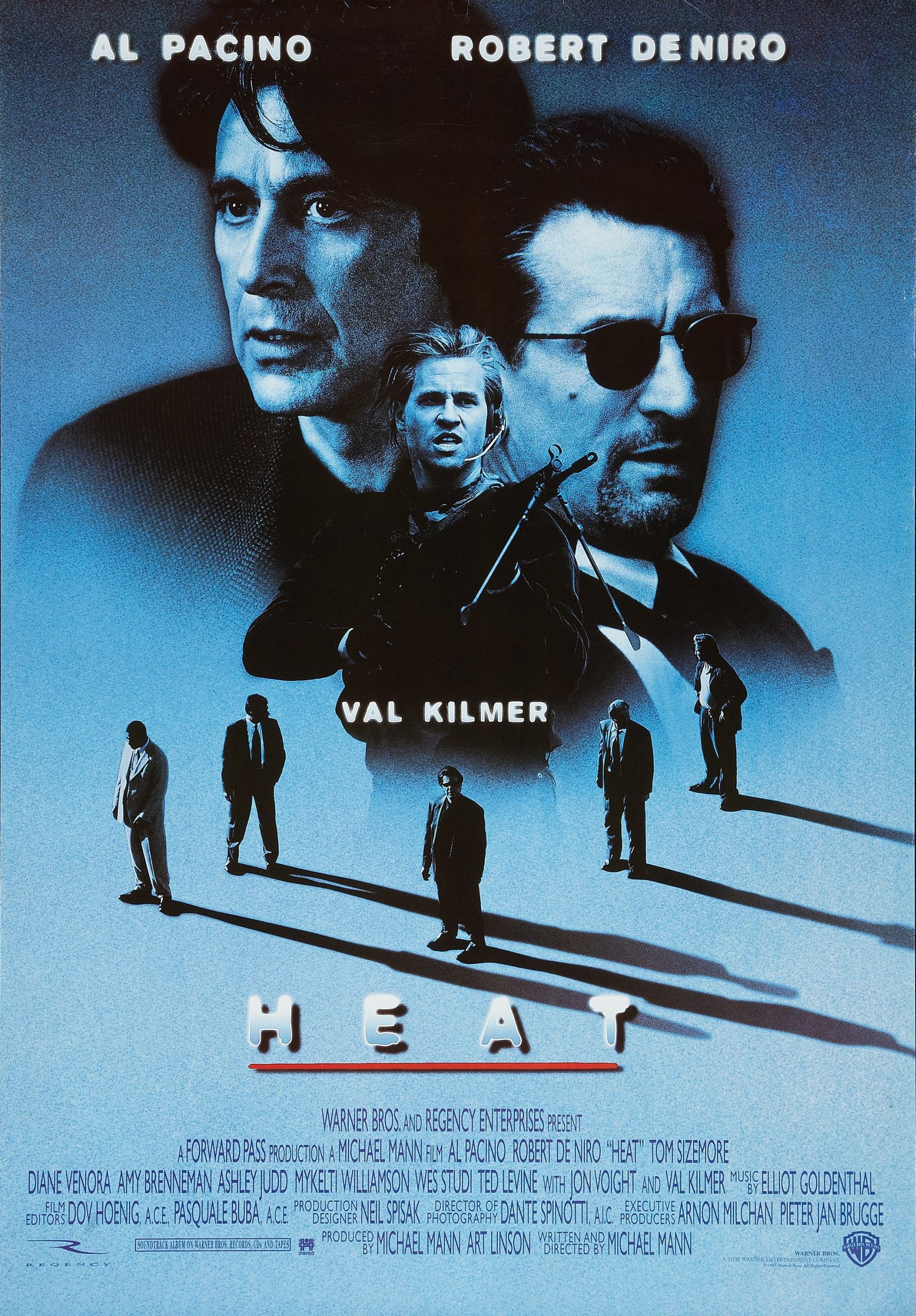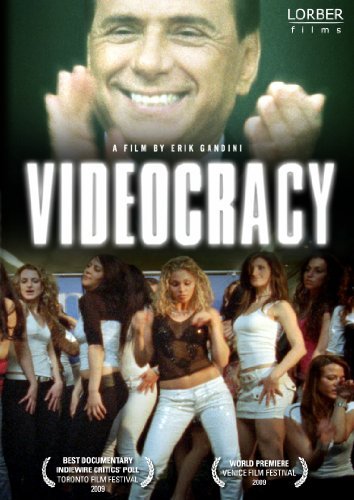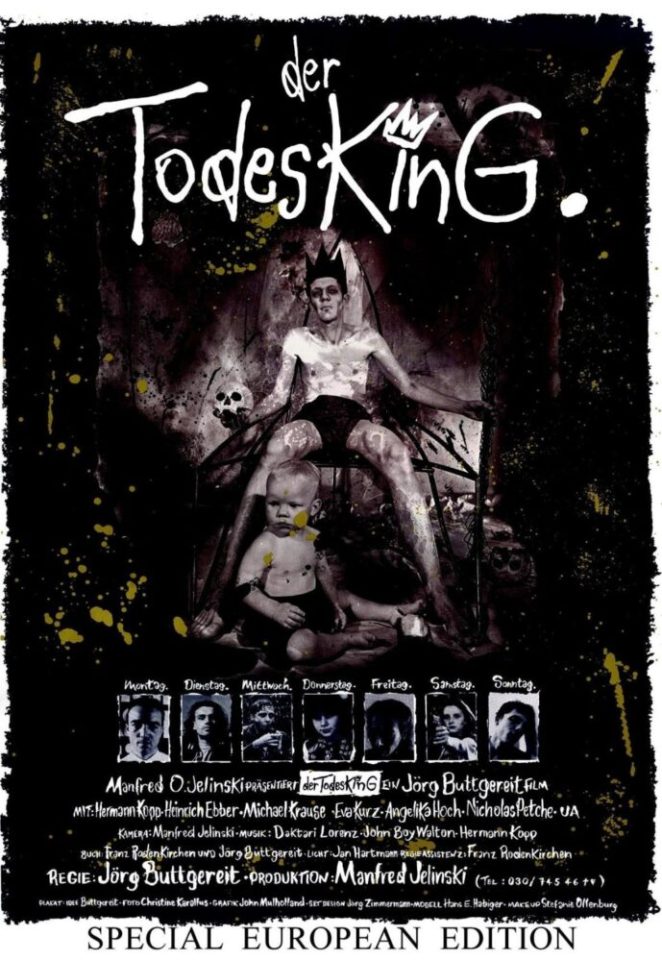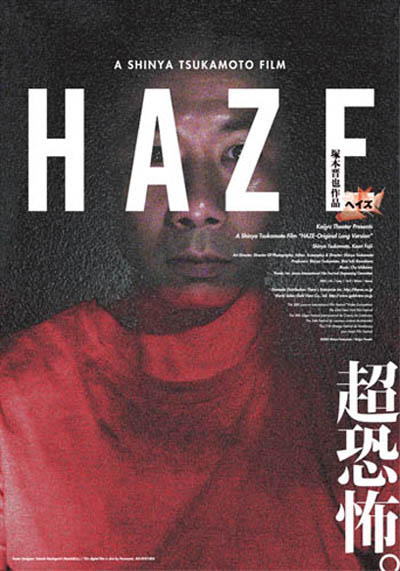Un gruppo di adolescenti americani scopre di avere un sogno ricorrente in comune: un uomo che li perseguita e che sembra in grado di trasformare ogni incubi in realtà.
In breve. Uno degli horror storicamente più importanti per atmosfera, storia, interpretazioni e “morale”. Standing ovation per la regia.
Commentare un film del genere a (più di) quaranta anni dalla sua uscita (1984) è un’impresa che richiede, come primo passo, la piena comprensione filologica del contesto in cui nasce: diversamente si rischia di ritenere che Fred Krueger sia nato come un villain da fumetto. La regia di Craven veniva dall’esperienza precedente (1982) di aver diretto la versione cinematografica di Swamp Thing (fumetto della DC Comics) il quale, guarda caso che (forse) non è un caso, parlava di un personaggio assassinato che torna in vita da una palude. La filmografia del regista che diventerà di culto per questo film è fino ad allora molto tormentata: ci sono due grandi successi exploitation: Le colline hanno gli occhi e L’ultima casa a sinistra, autentici saggi di pessimismo sociologico, almeno un film per adulti e qualche altro titolo poco noto o mal distribuito. Partire dalla cronaca che ispirò la scrittura del soggetto è forse il modo migliore per introdurci in una saga che la cultura pop ha declinato – forse erroneamente – più come un’icona fumettistica che come un simbolo di un orrore profondo, inesprimibile, atavico. In effetti Nightmare – come Venerdì 13 – è più noto come saga che come film originale, e questo naturalmente deriva dall’averlo reso un brand: ma sarebbe un delitto non sottolineare i meriti di questo cult del genere, invecchiato benissimo e ancora oggi spaventoso e sorprendente.
Una citatissima cronaca di fine anni Settanta raccontava di un gruppo di rifugiati cambogiani della tribu Hmong: sfuggiti alle persecuzioni di Pol Pot, si erano nascosti negli Stati Uniti. Molti di loro soffrivano di frequenti incubi, al punto di rifiutarsi di addormentarsi, pur di non farne. Fu ritenuto opportuno curare la loro insonnia con dei medicinali, e l’unico risultato che si ottenne fu farli dormire brevemente, farli risvegliare urlando e – a quanto sappiamo – morire sul colpo poco dopo. Ad essere vittime di questo singolare caso che Wes Craven sicuramente conosceva (e che stimolò la sua fantasia) fu il caso di un ragazzino scomparso senza una causa clinica evidente. Moltissime creepypasta e leggende urbane, del resto, hanno a che fare sia con un uomo misterioso che aggredisce le proprie vittime, approfittando (spesso e volentieri) della loro curiosità, sia con dipartite più o meno bizzarre, accidentali o casuali.
«One, two, Freddy’s coming for you,
three, four, better lock your door,
five, six, grab your crucifix,
seven, eight, gonna stay up late,
nine, ten, never sleep again!»
“Quando si addormentò, i suoi genitori si erano forse illusi che il problema fosse risolto. Poi sentirono delle urla nel cuore della notte e lo trovarono morto. Morto nel mezzo di un incubo” – raccontava Craven in un’intervista. La storia del piccolo rifugiato dal genocidio, terrorizzato dal dormire per paura di essere attaccato nei sogni e di non svegliarsi mai più, fu la molla che fece inventare Fred Krueger, vittima a sua volta di abusi da piccolo e diventato un mostro vendicativo che si muove dentro gli incubi.
Nell’atmosfera familiare in cui si ambienta il film la storia di Freddy sembra stonare malamente: solo i ragazzi si accorgono della sua presenza, facendo tutti lo stesso sogno con il medesimo “uomo nero” a tormentarli. Quelli che sembrano comuni incubi che lasciano scossi per qualche minuto per poi dileguarsi diventano casi di omicidio: alcuni ragazzi muoiono nel sono nei modi più cruenti, e uno di loro viene anche accusato dell’omicidio della fidanzata. Sarà Nancy, la giovane figlia dello sceriffo, a sfidare apertamente il mostro, mentre i genitori mostrano di nascondere qualcosa (sono stati loro a uccidere Freddy, si scoprirà). Il tema della giustizia sommaria è ampiamente trattato in questo Nightmare come già avvenuto, del resto, in altri celebri film del regista, e in un caso avevamo assistito a dei genitori che si imbattono casualmente negli assassini dei figli. In questo caso la logica è invertita, perchè sono i genitori ad aver ceduto alla vendetta: Fred era stato condannato per aver molestato e ucciso dei bambini, ma è uscito dal carcere per un errore burocratico. A quel punto i genitori della città hanno stabilito di ucciderlo dando fuoco alla fabbrica in cui si trovava, per poi seppellire il gesto nel proprio inconscio e dimenticarlo.
È frequentissimo, infatti, che la madre di Nancy inviti la figlia sempre più irrequieta a riposare, a nascondersi nell’oblio del sonno a dimenticare tutto, come se questo potesse cancellare quanto avvenuto ed evitare che possa rivoltarsi contro. Nightmare non è, a questo punto, solo una di saga del villain crudele che colpisce in modo seriale e senza limiti: è la materializzazione del senso di colpa di una generazione di genitori che non solo si sono fatti giustizia da soli, ma rifiutano di dare spiegazioni ai figli anche quando ci vanno di mezzo le loro vite.
Basandosi su quella storia in bilico tra cronaca e urban legend, Wes Craven costruisce una saga horror tra le più famose e citate al mondo – oggetto in questo primo capitolo di un remake di qualche anno, di tutt’altro sapore e fattura – e consegnando al pubblico una storia dai tratti epici o addirittura mitologici: un assassino che opera tra sogno e realtà, in grado di fuoriuscire dagli incubi delle sue vittime e diventare carne e ossa. Un qualcosa che solo la cultura classica di Craven (che nel film cita anche Shakespeare, ad un certo punto) poteva concepire, aspetto che rende l’idea dell’originalità del film già di per sè.
In questo primo Nightmare i personaggi si muovono tra incubo e realtà, e questo confine viene apertamente valicato dal mostro che, ad un certo punto, sembra essere entrato nel nostro mondo. Cosa di cui lo spettatore non è mai sicuro, in effetti: come tradizione amava girare in quegli anni, non si fa capire allo spettatore dove cominci l’incubo e dove finisca la realtà, conferendo così molto hype alla storia e rendendola affascinante. Tale caratteristica rende spaventoso un film che, senza questo accorgimento, poteva essere uno dei tanti slasher ottantiani (prodotti spesso senza infamia e senza lode). Nightmare è un rarissimo slasher sovrannaturale come pochi ne sono stati girati: un’ombra impalbabile, un uomo nero che sbuca da ogni angolo e terrorizza per vendetta i figli di chi l’ha ucciso. È uno dei leitmotiv più celebri dell’arte, quello delle colpe dei padri che ricadono sui figli, e non sorprende che sia arrivato anche in film non propriamente horror come Il sacrificio del cervo sacro. Quel senso di colpa, forse, non si è mai estinto sul serio.

Con la partecipazione di John Saxon (Donald Thompson), dell’icona del cinema horror Heather Langenkamp (la giovane Nancy) e la comparsa di Johnny Deep appena ventenne (Glen), Freddy (ovviamente Robert Englund) tormenta i sogni dei figli di coloro che lo hanno ucciso, attivando una singolare vendetta varcando le porte del sonno, senza perdere mai quel suo tocco di humor nero che lo rendono “più villain” di qualsiasi altro. Da un lato, infatti, le gag di Freddy servono ad accentuare la sua componente malvagia e aumentare il distacco dallo spettatore, dall’altro è piuttosto chiaro che questo personaggio simboleggi, più di qualsiasi altro, il senso di colpa collettivo che grava sull’umanità, colpevole di ergersi al di sopra degli altri, giudicandoli e spesso addirittura eliminandoli sulla base di un giudizio inappellabile. Ovviamente nessuno riuscirà mai a simpatizzare per un villain del genere – eccezion fatta, naturalmente, per i cinefili di vecchia scuola – o potrà mai essere colto dal dubbio che Freddy paghi per una colpa che non ha mai commesso. Non è questo il punto e probabilmente non vale la pena discuterne: eppure l’essenza di Freddy come personaggio rimane stregonesca, tant’è che viene mandato al rogo e poi torna in vita (in forma di demone) per farla pagare all’umanità.
Questo primo episodio è un film incalzante, spaventoso e con numerose scene cult: l’artiglio che esce fuori dalla vasca da bagno durante il bagno di Nancy, ad esempio, oppure il povero Glen che viene “risucchiato” nel proprio letto. Tutte scene non semplicemente “di cassetta”, ma cariche di valenza simbolica, con riferimenti alla scoperta della sessualità, al passaggio traumatico all’età adulta e al classico evergreen degli adulti che non ascoltano i ragazzi (ogni segnalazione della presenza di Freddy viene regolarmente bollata come una stupidaggine, o viene comunque minimizzata dai genitori). In questo senso Nightmare esprime la propria grandiosità come una critica sferzante a certa genitorialità, ai figli fatti per onorare le aspettative sociali, ai figli da esporre come trofei senza mai badare alla loro vita, ai loro problemi, ai loro incubi. E viene il forte sospetto che Freddy esprima esattamente questo tipo di orrore, a livello quantomeno inconscio, anche in considerazione del fatto che si tratta di un film moderno, veloce, atmosferico e senza fronzoli, per il quale il tempo non sembra essere trascorso.

Il fatto che sia stato ripreso nel 2010 nel remake di Samuel Bayer – il regista di Transformers, ad esempio – suggerisce ovviamente che, nell’industria cinematografica moderna, le idee scarseggino da un po’: per certi versi rifare “Nightmare – Dal profondo della notte” oggi è come chiedere a una persona di ringiovanire di quaranta anni, aspettandosi che lo faccia all’istante ed indignandosi se non riuscisse. Il film di Bayer non è male, a ben vedere, ma non riesce a ricalcare l’ombra autentica di questo originale, che è pur sempre un horror ispirato ad un fatto di cronaca e che ha fatto scalpore all’epoca, come farebbe oggi qualsiasi film si ispirasse a un fatto di sangue avvenuto in Italia, immaginando che l’assassino sia prima linciato dalla folla e torni a vendicarsi dei giornalisti che scrivevano titoli clickbait. Un’idea articolata del genere, probabilmente, poteva funzionare solo nei vecchi anni Ottanta, dove l’horror viveva una delle sue ennesime crisi creative e per rilanciarlo ogni regista era spesso costretto a ricorrere al surreale.
In fondo lo spessore di Nightmare conferito da Wes Craven in questo primo episodio, che aveva fatto scomodare più di un critico a riguardo, era annesso allo scherno sarcastico delle sue vittime, con il quale esacerbava la propria immoralità. Sebbene i temi principali del film siano la perdita dell’innocenza e la mancanza di comunicazione tra generazioni, Freddy diviene simbolo di un Male che, come spesso in Craven, finisce per ritorcersi contro giovani sprovveduti, mentre gli adulti stanno semplicemente a guardare.
Nel nostro paese esistono due versioni del film: una più corta di circa con il taglio delle scene più violente, e la “Director’s Cut” integrale che comprende varie scene censurate, inserite nella versione digitale, dove si nota che alcune parti non sono state nemmeno doppiate in italiano (sono in lingua originale). Per quanto riguarda la questione del finale, esiste una notissima “happy end” razionale che suggerisce si sia trattato di un semplice incubo, e due versioni “pessimistiche” in cui Freddy sbuca fuori in due modi imprevedibili (tutto questo materiale è disponibile nel DVD come “alternate endings“).
Per chi volesse tuffarsi nella croni-storia del personaggio, trovate su questo sito le recensioni di tutti i film “ufficiali” della saga (ad esclusione dei vari spin-off): Nightmare – Dal profondo della notte, Nightmare – La rivincita, Nightmare – I guerrieri del sogno, Nightmare – Il non risveglio, Nightmare 5 – Il Mito, Nightmare La fine.