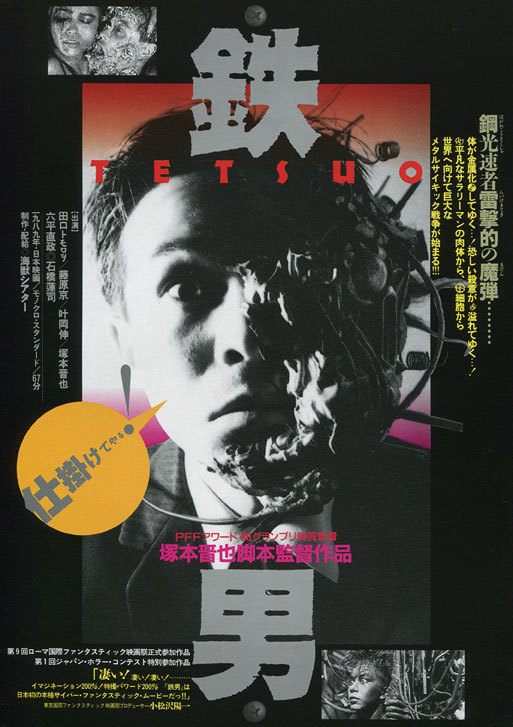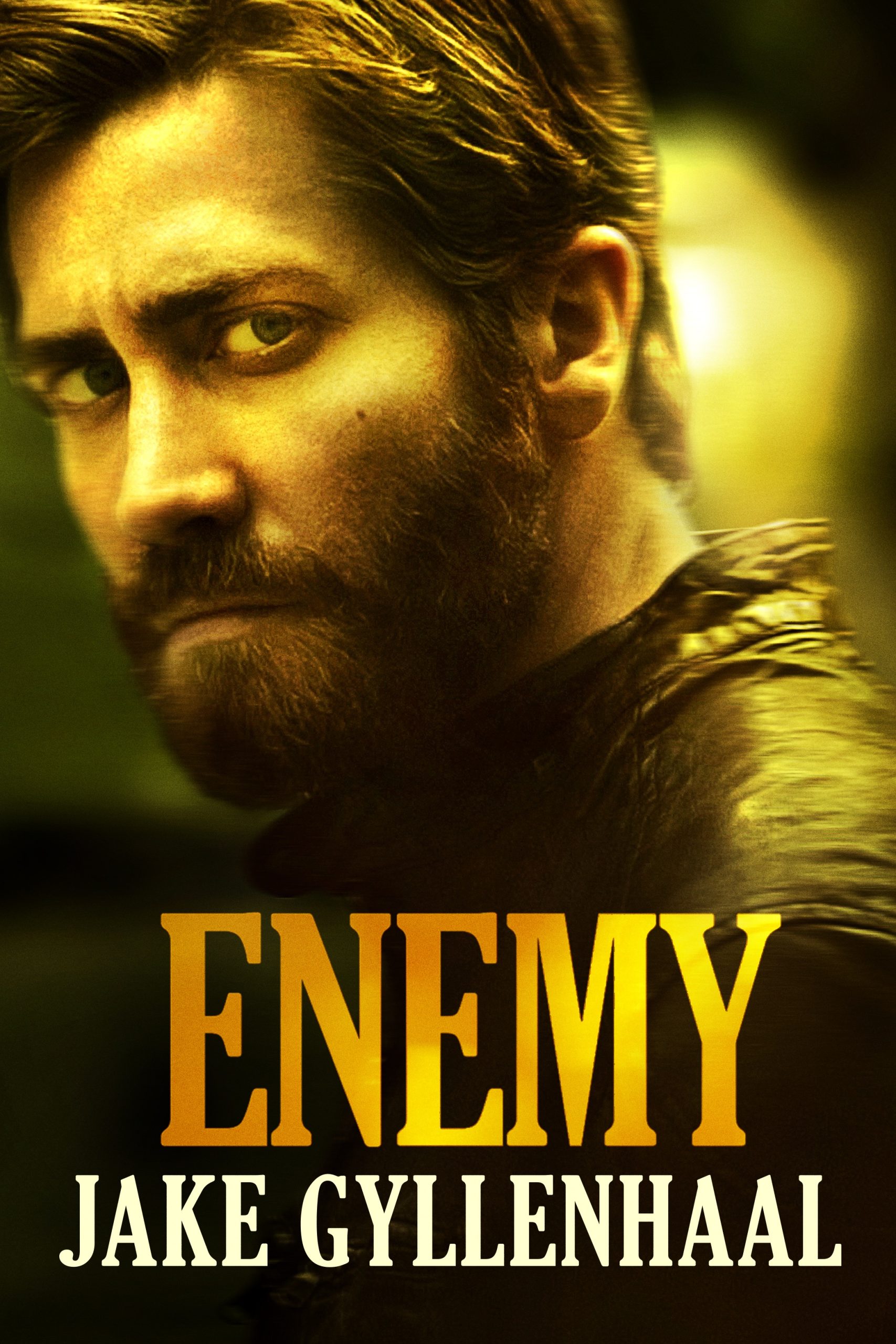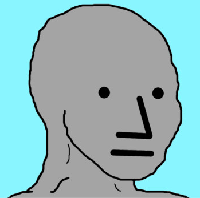Nel 1977 esce I nuovi mostri, sulla falsariga de I mostri e nuovamente incentrato su film costruiti a micro-episodi. Se il primo lavoro di questo tipo era stato diretto da Risi, questo è una regia collettiva, in cui curiosamente (ma non era insolito, per l’epoca) manca l’attribuzione degli episodi ai singoli registi coinvolti: Risi, Monicelli e Scola. Il film è stato anche recentemente proposto su Rai Movie qualche giorno fa, in una versione “intermedia” a livello di tagli, e come vedremo più avanti si tratta di uno dei film più arbitrariamente tagliuzzati dalla censura mai prodotti in Italia, e non è neanche chiaro se esista una versione realmente uncut.
I nuovi mostri è anche l’espressione di un umorismo che stava cambiando nel cinema (e non solo lì): quello che all’epoca del suo omologo di metà anni sessanta era, al massimo, humor nero accennato ed implicito, qui si decide di renderlo esplicito. Nel 1974, ad esempio, gli USA avevano prodotto Fritz il gatto, anche lì un umorismo inedito e anti-moralista, destinato a fare scuola e a rendersi a suo modo memorabile. Certe forme di enfasi, peraltro, sono da sempre state considerate eccessive e fuori posto sia dalla critica media che dal pubblico, e questo sicuramente non ha sancito un successo che, probabilmente, il film avrebbe meritato. È quantomeno paradossale, nonostante tutto, che la critica dell’epoca denigrasse lo scarso valore sociologico degli episodi (che sono effettivamente più che altro riflessioni nichiliste sulla natura umana), che in confronto de I mostri di dieci anni prima è sicuramente difficile da paragonare.
Il format in questione, per la verità, questa volta sembra reggere solo in parte: al netto di regie sempre solide ed efficaci, alcuni episodi sembrano “annacquati” ed appaiono quasi sconclusionati. Tant’è che la critica dell’epoca non si espresse in modo benevolo sul film, indicando al massimo un paio di episodi realmente memorabili (tra cui il pluri-citato Hostaria!), mentre il pubblico sembrò vedere il film con la stessa rapidità con cui lo dimenticò.
Se una mancanza di ispirazione può per certi versi essere tollerabile (i film episodici con più registi ne soffrono quasi inevitabilmente, anche in altri contesti), quello che andrebbe valorizzato in questo film del 1977 è il sentimento anarchico che lega gli episodi, quasi da autentici Monty Python all’italiana, ed in cui è evidente che in molti degli episodi si sia alzata l’asticella dell’azzardo, dell’osare e di conseguenza del potenziale scandalo.Il film è questo, alla fine, ed esprime le proprie potenzialità in modo penalizzato anche per via dei tagli superficiali che, negli anni, impedirono di apprezzarlo come unicum.
Gli episodi migliori de I nuovi mostri
Come dimenticare L’elogio funebre con un incredibile Alberto Sordi? Il funerale apparentemente commosso e solenne del capocomico di una compagnia cede il passo al ricordo del repertorio dello stesso, che poi fa degenerare il funerale in un delirio di doppi sensi, battute di bassa lega e balletti, ed infrange uno dei tabù più classici: quello di ridere irrazionalmente durante le esequie di qualcuno, in omaggio ad uno dei cardini della Satira con la “S” maiuscola (che deride alternativamente politica, sesso, religione e morte).
Senza parole è uno degli episodi forse più belli del film: una hostess a Fiumicino viene sedotta da un giovane mediorientale, mentre sentiamo due brani tipici di quegli anni per creare l’atmosfera (All by myself di Eric Carmen e Ti amo di Umberto Tozzi). L’amore sembra esclusivamente platonico e pare travolgere la donna, che riceve un mangiadischi con una delle due canzoni come dono: imbarcandosi poco dopo, provoca l’esplosione dell’aereo in volo dato che conteneva un ordigno. L’episodio è ispirato ad un fatto di cronaca realmente accaduto, conclusosi fortunatamente senza vittime: con la stessa dinamica descritta nell’intreccio, fu un volo in partenza da Fiumicino ad essere bersaglio dell’attentato, che tuttavia fece in tempo a rientrare in aeroporto, a causa di un’esplosione nel bagagliaio qualche minuto dopo il decollo.
Impossibile non citare, infine, Hostaria!, dove Gassman e Tognazzi interpretano il cuoco ed il proprietario di un’osteria tipica romana. I due sono estremamente litigiosi (e si capirà in seguito che sono una coppia) e, mentre discutono, continuano a preparare dei piatti che diventano disgustosi, in cui fanno cadere mozziconi di sigarette e scarpe: servono comunque quelle portate, e la clientela chic mostra comunque di apprezzarli.
Gli episodi censurati de I nuovi mostri
Il punto importante da inquadrare, a questo punto, è che la censura ha colpito duramente I nuovi mostri, e molti episodi, ancora oggi, si conoscono esclusivamente per le sinossi presenti su Wikipedia: quasi nessuno, di fatto, sembra averli visti. I nuovi mostri ad oggi, purtroppo, per la maggioranza degli italiani è una rubrica di Striscia la notizia, e ben pochi conoscono il film da cui quel nome è stato tratto quel nome.
La censura è quasi sempre inaccettabile, in effetti, nella misura in cui decide arbitrariamente, sulla base di criteri del tutto soggettivi, cosa si possa vedere e cosa invece non si debba vedere – e ciò ha risvolti più pesanti di quello che sembra: in molti casi la censura ha colpito, in passato, cose ed aspetti sui quali oggi si sorvola tranquillamente. Del resto si tratta solo di film, ed il cinema non dovrebbe mai avere un ruolo troppo didascalico o “essere da esempio”, proprio perchè – citando il personaggio di Volontè in Indagine su di un cittadino al di sopra di ogni sospetto – se ci convinciamo che il popolo è minorenne, diamo spazio a possibili espressioni di potere autoritarie e, soprattutto, quello che “ci va bene” censurare oggi, potrebbe rivoltarsi contro i nostri stessi gusti o preferenze un domani.
Il vero punto critico del film è l’episodio Pornodiva: una storia amara e decisamente crudele, in cui una coppia viene ingaggiata per girare un porno contenente sesso con animali, e si scoprirà che arriveranno a coinvolgere la figlia di sette anni, con una piccola scimmia, per guadagnare il massimo dall’ingaggio. Non una storia per bambini, ovviamente, quanto molto realistica, che venne brutalmente rimossa nel passaggio televisivo, e a quanto pare anche in alcune versioni in DVD del film.
Oppure pensiamo ad Autostop, dove Ornella Muti interpreta una avvenente autostoppista che viene molestata più volte dall’automobilista che le ha dato un passaggio, arrivando a fingere di essere evasa da un carcere femminile e di essere armata per difendersi. Senza troppi complimenti, a quel punto, l’uomo la uccide, facendo emergere un dramma di sessismo e prepotenza. Peraltro, resosi conto che la donna era disarmata, non mostra alcun rimorso davanti ai carabinieri (nella versione cut manca questo finale).
Anche Cittadino esemplare è stato censurato ed è tremendamente incisivo, probabilmente inibito alla visione per via del suo pessimismo antropologico: vediamo un uomo assistere ad un delitto e rientrare a casa come se nulla fosse, gustandosi un bel piatto di amatriciana. Il sospetto è forse uno degli episodi meno efficaci del film, ma manca anch’esso da varie uscite in TV: si parla di un carabiniere infiltrato in un gruppo di contestatori dell’epoca, che durante un arresto di massa, propina una goliardica pernacchia contro il proprio superiore, venendo rimproverato bonariamente – e lasciando immaginare al pubblico cosa gli sarebbe successo se fosse stato un autentico contestatore.
La cosa anomala del film, peraltro, è che molti episodi anche “innocenti” sono stati rimossi, forse perchè considerati inefficaci: molti italiani non hanno pertanto potuto godere dell’episodio Mammina e mammone, ad esempio, in cui Tognazzi è uno strepitoso caratterista che vive di espedienti. Stesso discorso per Sequestro di persona cara, in cui si evidenzia l’ipocrisia di un uomo a cui è stata rapita la moglie, che fa un appello accorato ai rapitori per riaverla indietro, quando in realtà aveva staccato i fili del telefono.