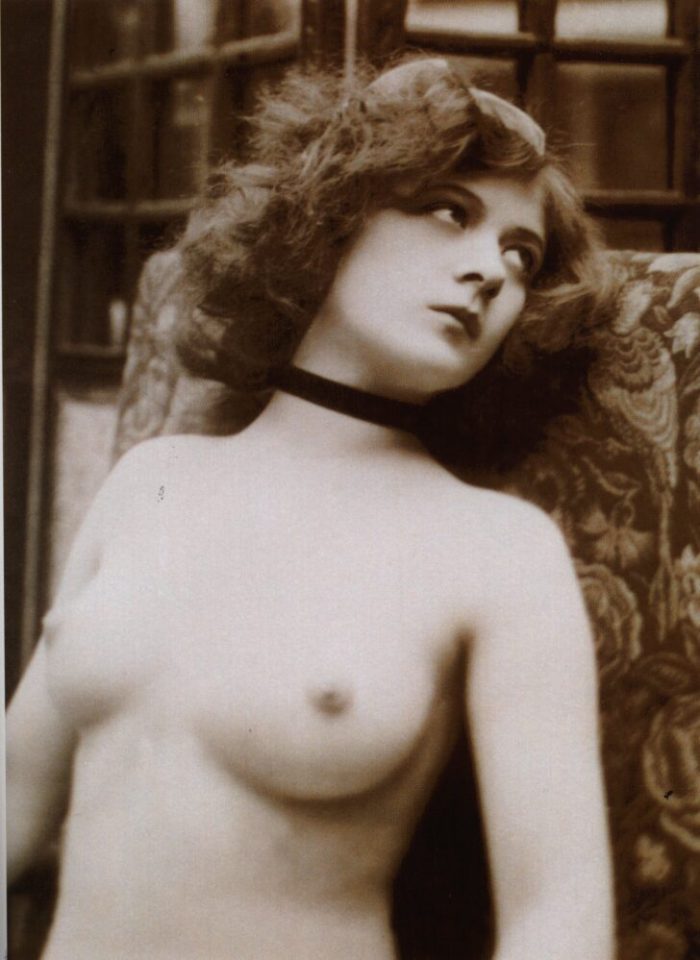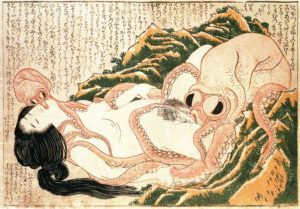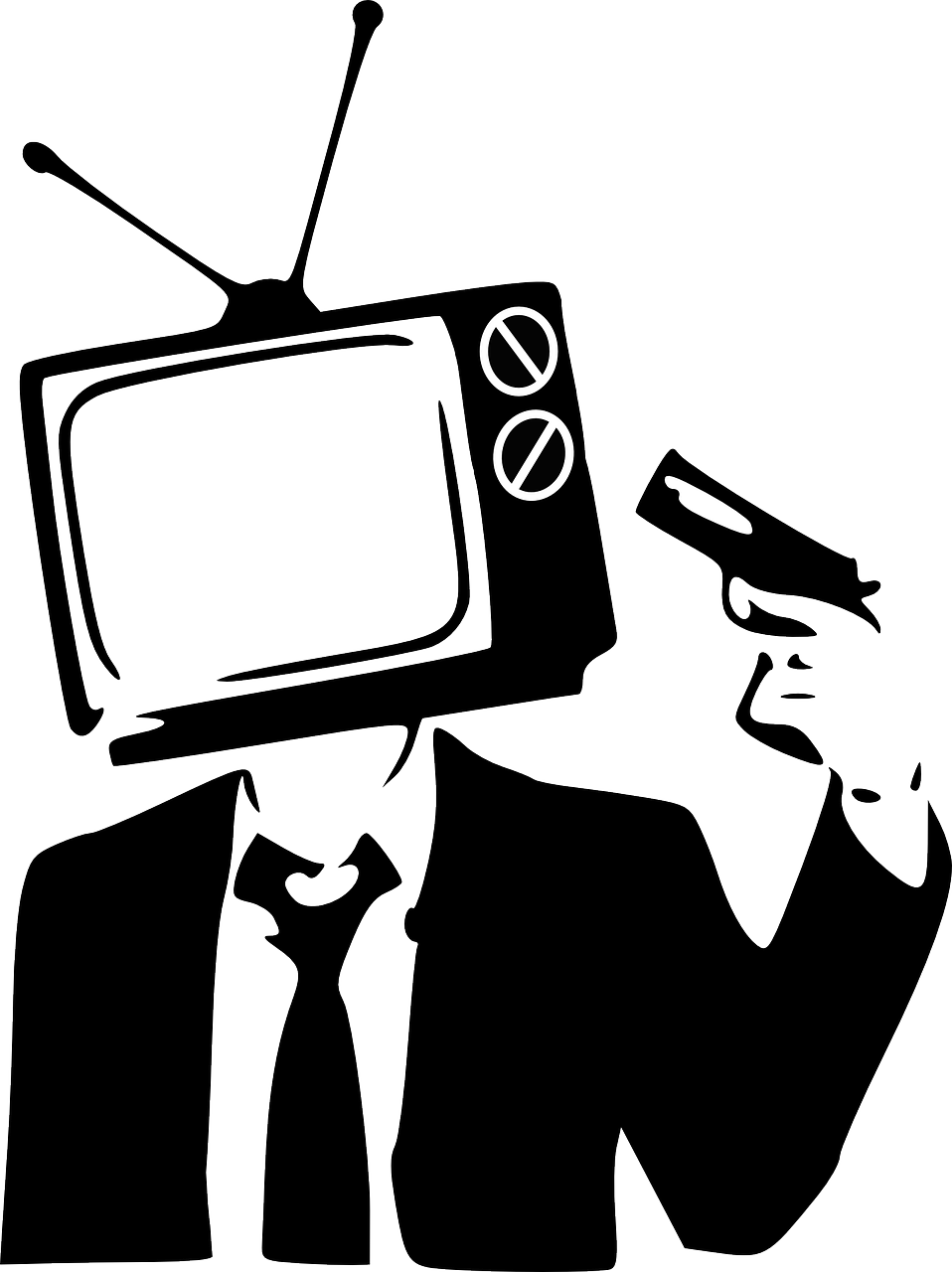La parola magica per capire il finale di Archive 81 – recensione qui – è cliffhanger, ovvero un finale sospeso; senza pensare al film cult omonimo con Stallone del 1993, più semplicemente si tratta di un finale aperto, in cui non è dato sapere un bel po’ di cose. Per chi legge, dovrebbe essere ovvio aver già visto la serie, in caso non fosse così preavviso nuovamente: spoiler in arrivo. Ci sono fin troppe domande rimaste aperte su Archive 81, e non riusciremo davvero a rispondere ad ogni dubbio: fin troppo è ambivalente, multi-interpretabile, soggettivo. Per cui, se va trovato un difetto alla serie, probabilmente potrebbe risiedere proprio qui, in quel finale aperto che quasi banalizza, se vogliamo, la bellezza dei singoli episodi.
 Le domande non mancano: su tutte, che fine ha fatto Dan, in che mondo sia finito e come sia arrivato in ospedale, per quanto la TV faccia capire che è finito negli anni 90, precisamente attorno al 5 aprile 1994, dato che viene mostrata la morte di Kurt Kobain come elemento caratterizzante il periodo. Il suo viaggio nell’Oltremondo è andato, tutto sommato, a buon fine: ha rivisto la propria casa, ha trovato e mandato a casa Melody, ha rivissuto con la propria famiglia morta nell’incendio.
Le domande non mancano: su tutte, che fine ha fatto Dan, in che mondo sia finito e come sia arrivato in ospedale, per quanto la TV faccia capire che è finito negli anni 90, precisamente attorno al 5 aprile 1994, dato che viene mostrata la morte di Kurt Kobain come elemento caratterizzante il periodo. Il suo viaggio nell’Oltremondo è andato, tutto sommato, a buon fine: ha rivisto la propria casa, ha trovato e mandato a casa Melody, ha rivissuto con la propria famiglia morta nell’incendio.
Ma… adesso cosa succederà? Furbescamente, la produzione ha deciso di lasciare la domanda aperta a mille interpretazioni e fan theory. Alcune sono davvero deliziose, secondo noi, e ne riportiamo due tratte da Reddit (PS ricordiamo che le fan theory sono, per definizione, pure invenzioni più o meno plausibili sulla trama, effettuate da persone che hanno visto la serie):
- Per quale motivo Virgil Davenport, che tanto aveva fatto e fornito per salvare i nastri, rifiuta di tornare nell’Oltremondo per salvare il fratello? L’utente doctorsolitaire su Reddit ipotizza che il fratello in realtà non esiste, insinuando che Virgil e Samuel (coi suoi numerosi pseudonimi) siano addirittura la stessa persona. In altre parole, l’uomo si sarebbe rifiutato di andare a prendere il fratello perché, semplicemente, era già sul posto, per quanto ciò cozzi col fatto che in un video si vedono entrambi.
- Perchè viene scelto Dan per indagare sui nastri? Al netto delle sue capacità tecniche, probabilmente (secondo un altro utente Reddit) Dan potrebbe avere poteri, che non ricorda di avere, da medium o comunque sovrannaturali, il che spiegherebbero la sua empatia psichica con Melody. Il che si collegherebbe, a questo punto, col sospetto che suo padre oltre ad essere uno psichiatra fosse anche un para-psicologo, vicino al mondo del sovrannaturale.
Nell’Oltremondo il tempo è semi-congelato o non scorre come dovrebbe (ce ne accorgiamo dall’esperiente visivo delle particelle sospese nel vuoto, senza fluttuare), e tutto sembra suggerire che alla fine Dan sia rimasto intrappolato in un’altra dimensione. Questo è quanto si riesce ad evincere da un finale, alla fine dei conti, puramente lovecraftiano, debitore dei finali aperti modello Lucio Fulci che, per semplice parallelismo, ci siamo permessi di rievocare qui. Ci guardiamo bene, ovviamente, dal sostenere che Archive 81 sia un film collegato direttamente a Fulci: al massimo, infatti, Archive 81 potrebbe essere sottilmente lovecraftiano, con i suoi richiami ad un dio feroce e crudele da un’altra dimensione, ma anche su questo frangente potrebbe essere un accostamento indebito. Quello che ci interessa è evidenziare come certi percorsi narrativi, oggi resi celebri da una serie horror sovrannaturali di grande successo, siano stati, come minimo, intuìti da Fulci prima di chiunque altro.
E tu vivrai nel terrore… L’aldilà! (1981) presenta una situazione in parte simile a quella vissuta da Melody e Dan, mediante i personaggi di Liza e McCabe. Nel cult fulciano i due attraversano una cantina, dopo essere fuggiti dall’ospedale, e si ritrovano all’interno del paesaggio dipinto dal pittore Zweick, morto crocefisso e murato nelle stanze dell’hotel maledetto nella scena iniziale del film. Liza e McCabe si trovano così in una dimensione nebbiosa, sinistra, mortifera e cosparsa di cadaveri, per dirla con le parole del regista: un deserto senza luce, senza ombre, senza vento (La notte americana del dott. Lucio Fulci, documentario del 1994). In parallelo Melody e Dan stanno cercando una via d’uscita da un Oltremondo infernale, tenendosi la mano in vari passaggi del loro viaggio, in cui la sensazione che non ci sia una vera via d’uscita è costante in entrambi i film. Ricerca l’uno dell’altra che culmina in un viaggio, di cui avevano ricevuto solo suggestioni oniriche nelle puntate precedenti. Liza e McCabe, ne L’aldilà, si ritrovano sul posto senza sapere come, se non a livello inconscio – o tra mille suggestioni incerte, in grado di creare una poetica macabra quanto straordinaria.
A differenza del nichilismo di Fulci che sancisce la scomparsa materiale dei due protagonisti dalla scena, la serie di Rebecca Sonnenshine decide di separare la coppia, consegnando Melody alla madre che l’aveva sempre cercata e, quasi come contrappasso dantesco, intrappolando Dan nell’altra linea temporale. Per sempre. O forse …

Il tema della separazione o del confinamento inatteso di un personaggio protagonista all’interno di un altro mondo, del resto, non è nuovo: bastebbe pensare anche solo all’archetipo creato da L’armata delle tenebre, ad esempio, o a molti episodi de Ai confini della realtà, per comprendere la devozione incrollabile della serie ai classici dell’horror e ai loro twist più sconvolgenti.
Dopo aver finito diligentemente di vedere la prima serie, comunque, e fermo restando le considerazioni fatte in precedenza, resta un po’ di amaro in bocca per le parentesi aperte rimaste tali, o se preferite per il gran numero di personaggi che non siamo nemmeno sicuri se siano vivi o morti. È quasi certo, da quello che si legge sul web, che Archive 81 avrà una seconda serie, probabilmente anche una terza, una quarta e così via, andando ad approfondire qualsiasi personaggio in un potenziale infinito dilagare di spin off. Avremmo idealmente preferito che restasse tutto com’è adesso, in questa deliziosa (tutto sommato) sospensione narrativa, in cui Dan ha assolto il proprio destino ed è pronto a ricominciare una nuova vita (ammesso ottimisticamente che non si voglia ritenerlo perso). Avremmo preferito questa sospensione, questa “inconcludenza”: avremmo preferito far finire Archive 81 alla prima stagione, e quasi speriamo che sia così. Perchè non siamo troppo convinti che meriti, artisticamente parlando, di diventare l’ennesima telenovela-polpettone a infinite puntate, personaggi e improbabili resurrezioni. Addirittura gli amatissimi viaggi nel tempo sono diventato il deus ex machina onnipresente che rimette in sesto anche il più sciatto dei cinecomics…
Quello stesso senso di sospensione e di irrealizzabilità di un finale, in questi casi, Lucio Fulci lo aveva intuito – e coraggiosamente realizzato prima di chiunque altro, per quanto certi suoi finali furono tacciati di essere fuori bersaglio. Fu il destino, ad esempio, di un altro lavoro fulciano analogo, anche lì caratterizzato da suggestioni lovecraftiane e passaggi non lineari o illogici: Paura nella città dei morti viventi. Anche qui troviamo una coppia che fugge via da un’inferno sotterraneo, e quando stanno per riabbracciare il mondo dei vivi succede qualcosa. La protagonista urla (non vediamo cosa succede), il fermo immagine si blocca sulla figura del ragazzino (fino a poco prima, apparentemente felice di vederli), due poliziotti camminano dietro di lui con un’andatura quantomeno ambigua (forse sono zombi, forse i morti viventi sono riusciti a seguire sulla terra i due protagonisti, forse addirittura il ragazzino è diventato un morto vivente). Succede qualcosa, insomma, ma non sapremo mai che cosa: l’immagine si spacca, si dissolve nel nero e finisce il film, lasciandoci scossi e annichiliti, incerti su cosa abbiamo davvero visto. Per quanto si sia romanzato sulla realtà delle motivazioni di quel finale, pare che il regista cambiò idea in corsa (di sicuro, aveva in mente H. P. Lovecraft), oppure (secondo altre versioni) pare che qualcuno rovesciò del caffè sui negativi del finale, ormai perso per sempre (che suggestione puramente fulciana, quest’ultima!), e poi riparato alla meno peggio in fase di montaggio.
D’accordo tutto, intendiamoci: godiamoci altri 999 spinoff a tema, riguardiamo Archive 81 altre cento volte, rendiamo Dan uno degli eroi umani con cui empatizzare, addirittura il simbolo del risveglio post-trauma incendiario, pandistruttivo o pandemico che sia. Godiamoci il parallelismo con l’Inferno dantesco, i rimandi al cinema di genere, le sedute spiritiche agghiaccianti e le suggestioni a metà strada tra L’inquilino del terzo piano e [REC]. Ammesso che sia possibile suggerire un alternate ending per Archive 81, pero’, siamo dell’idea che fare una cosa sulla falsariga degli incompiuti fulciani sarebbe stato davvero meraviglioso. Una serie TV che culmina, praticamente, come cinema d’autore, consacrandone i meriti – senza nulla togliere al fatto che comunque la produzione fa quello che gli pare per i seguiti, per cui…
A questo punto pensiamo valga la pena rivedere ancora una volta quel finale: quel lugubre, incompiuto e sinistro finale (di seguito trovate la versione tratta dalla VHS danese: dopo la spaccatura del fotogramma, si intravede una vista sul cimitero e la citazione “L’anima che brama per l’eternità supererà la morte; tu, abitante del vuoto crepuscolare, vieni a Dunwich” di H. P. Lovecraft).