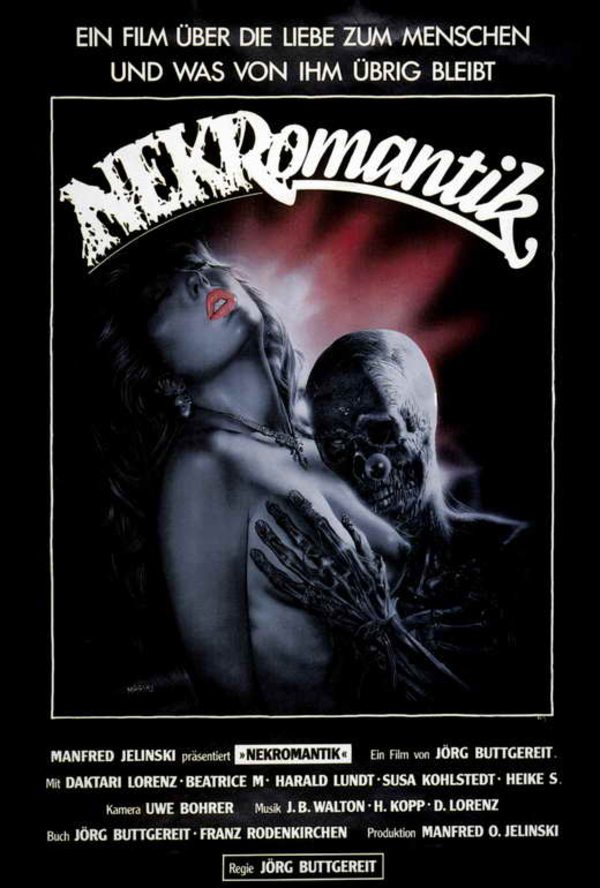Uno dei due cult cinematografici degli Squallor: commedia ad episodi con assurdità demenziali all’ennesima potenza per un genere che, nel 1984, aveva ancora tanto da raccontare. La regia è di Ciro Ippolito, lo stesso che realizzò lo spin-off di fantascienza noto come Alien 2.
Il trash è consapevole di se stesso: troviamo le scenette tipiche dell’italiano medio riportate in chiave umoristica e non-sense (ma anche, c’è da dire, con grande intelligenza e parsimonia). In questo film i quattro geniacci della musica italiana (Bigazzi, Pace, Savio e Cerruti), spesso in compagnia a bellissime attrici (Sabrina Siani, o la fulciana Cinzia de Ponti) prestano i propri volti a scene irriverenti, fuori dalle righe, inconcepibili da raccontare, quasi sempre legate al demenziale più cristallino oltre che infarcito di siparietti pazzeschi e, proprio per questo motivo, assolutamente spassosi.
Tutto è demenziale in “Uccelli d’Italia“, e tutto è dotato di uno humor pazzesco e piuttosto inedito per l’epoca, a cominciare dal titolo che fa riferimento all’inno nazionale “Fratelli d’Italia” (ma che secondo alcuni sarebbe anche la parodia di “Uccelli di rovo“, una miniserie iconica di metà anni Ottanta diretta da Daryl Duke). Ma attenzione, questo non deve far pensare a quella comicità gratuita a cui potremmo essere abituati oggi (la stessa che Maccio Capatonda ha fatto varie volte oggetto di meta-umorismo), fatta di vuoti tormentoni dei quali ridere in modo fine a se stesso.
Ippolito e gli Squallor aggrediscono i luoghi comuni dell’epoca, il perbenismo (ben prima che diventasse patrimonio culturale dei troll della politica e dei social) e – direi soprattutto – sfidano la censura con la propria irriverenza. Come fa ad esempio Daniele Pace quando pronuncia la parola “eiaculare” la bellezza di dieci volte di fila, perchè sì. Uno schiaffone alla cultura mediocre (e rigorosamente democristiana) dell’epoca che, di sicuro, nel suo piccolo non passò inosservata, e che fu in fondo la forma di ribellione insofferente per cui gli Squallor stessi nacquero, vissero e spirarono qualche anno dopo.
Uccelli d’Italia, con la sua iconica capacità di dire tutto senza dire nulla, di esagerare senza andare mai al punto, di diventire senza raccontare quasi nulla, è altresì abile a costruire atmosfere seriose (molto spesso da telenovela anni 80, in cui il modello era naturalmente Uccelli di rovo), per poi smantellarle con la spontaneità delle barzellette di Pierino o, se preferite, con l’immediatezza di battute al fulmicotone che oggi passano relativamente indifferenti ma che, per l’epoca, furono avanti e anche di molto.
Non bisogna dimenticare che dietro questo film vi è il lavoro artistico di Bigazzi, Savio, Cerruti e Pace, attivi per circa 40 anni in una band seminale che nel frattempo è diventata di culto, artefice di ciò che tanti altri gruppi successivi avrebbero banalizzato come “rock demenziale”, e che avrebbe ispirato orde di artisti estasiati da quegli ascolti – era meglio quando c’erano gli Squallor, in effetti. E sono giusto i non-sense esasperati degli artisti che crearono “38 luglio”, “Cornutone” e “Tutto il morto minuto per minuto”, diretti dal regista di Alien 2 – Sulla terra, a prendere quasi completamente la scena e ad occuparla con insensatezze che lasciano lo spettatore sbigottito, costretto a ridere. Immersi in una colonna sonora in parte degli stessi Squallor (ad esempio “A chi lo do’ stasera“, che venne reinterpretata con testo leggermente diverso da Nadia Cassini), in parte dei Village People – che conferiscono, questi ultimi, al film quell’atmosfera così ottantiana – non mancano tanti riferimenti a tormentoni e serie TV che ancora oggi fanno il loro effetto: su tutti l’intermezzo fisso tra un episodio e l’altro, che da “Italia Unoooo” diventa inesorabilmente “Italia culoooo“. Senza dimenticare che “Anche i ricchioni piangono” (anche qui, se parlassimo di politicamente corretto non ne usciremmo più) e soprattutto <<“Osvaldo non sarà più tuo”, un dramma tra due donne ed un mezzo culo in 185 puntate>>.
Particolarmente riusciti rimangono l’episodio iniziale, con il prete che illustra chiaramente le proprie intenzioni nei confronti dell’amante clandestina, la storia di Bigazzi – scrittore in crisi creativa – tormentato da moglie e figli che decide di risolvere la questione con una bomba a mano (!) e, forse soprattutto, una coppia che rientra a casa, lui è appena tornato da un viaggio, lei chiede insistentemente “Cosa mi hai portato da Parigi?“, e dopo uno strip-tease totalmente inutile ai fini della storia l’uomo tira fuori dalla giacca … una provola (!). Mini-film a sè stanti, quindi, perennemente in bilico da demenziale e comicità assurda, con alcune volutissime sbavature come il momento in cui Pace (che interpreta un morto di recente) scoppia dal ridere per via dei riferimenti di Cerruti, vestito da vedova, al capitone ed al celebre “e mo chi mi chiava ammè“.
Un film sincero e spassoso, da tempo uscito in DVD assieme al degno compagno “Arrapaho“, che si lascia guardare con piacere anche oggi, nonostante alcuni momenti alquanto spiazzanti, ma solo perchè i riferimenti non sempre si riescono ad intuire (come avviene molto facilmente, invece, con la parodia dei Visitors, altro cult d’epoca). Probabilmente sulla scia di “Uccelli d’Italia” con qualche mezzo in più sarebbe potuta nascere una sorta di Troma all’italiana (il feeling c’è tutto); del resto sappiamo tutti come venga visto un certo cinema dalle nostre parti, per cui probabilmente va benissimo già quello che abbiamo.