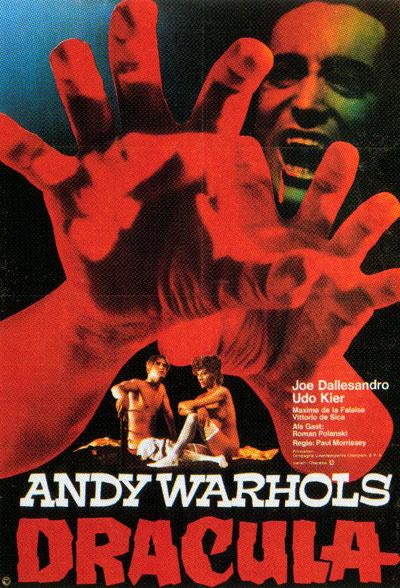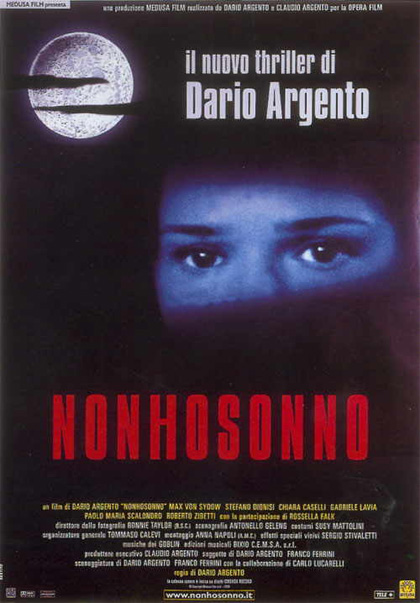Gotham City: il clown e aspirante stand-up comedian Arthur Fleck viene maltrattato ed emarginato dalla società, oltre a perdere il lavoro per via di un’arma (che si è portato dietro per difendersi). Esasperato da svariate circostanze socio-psicologiche, sarà presto noto in città come il Joker.
In breve. Notevole rilettura di Phillips, in chiave anti-eroica, di uno dei cattivi per eccellenza. Il regista ribalta l’assunto narrativo tradizionale, e mostra la storia dal punto di vista del protagonista, con una pregevole analisi sociologica annessa.
Secondo la teoria del comico di Henri Bergson i motivi del riso sono misteriosi: per quanto l’autore abbia provato a formalizzarli in un discreto mattoncino di 138 pagine, resta il dubbio su cosa possa – o meno – suscitare il riso, e di quanto sia etico ridere, sorridere o schernire qualcosa. Il sorriso di Joker, del resto, è cristalizzato nell’immaginario collettivo da più di 70 anni (Joker nasce su carta nel 1940 grazie alla DC Comics), ma quello di Phillips è, sorprendentemente, un riso patologico: Arthur, infatti, è affetto da una forma compulsiva di risata, che non sa controllare e tende ad emarginarlo dalla società. È un malato cronico, insomma, e questo è probabilmente il primo punto da tenere a mente nella sua controversa rappresentazione.
Il Joker di Todd Phillips focalizza la propria attenzione su un personaggio ben noto al pubblico (operazione che ricorda per certi versi il saggio su Leatherface, ad esempio) e ne esplora ogni risvolto; lo fa soprattitto evitando qualsiasi meccanismo di identificazione del pubblico, come sarebbe stato lecito aspettarsi. Se è cosa molto comune simpatizzare per tanti anti-eroi o villain del cinema (ad esempio per quelli di Quentin Tarantino), nel caso di Phillips è impossibile farlo. Un secondo aspetto sostanziale della sostanza del film, insomma, che evita sia l’associazione con il consueto monolitico cine-comics (che parte del pubblico potrebbe, in teoria, pensare di vedere, e da cui questo Joker prende invece le distanze) sia il solito meccanismo di identificazione nel protagonista, che sarebbe tipico del cinema più “epico” e accattivante – favorendo così lo straniamento totale del pubblico. Ed è davvero notevole (oltre che un merito gigantesco di Phillips, a mio avviso) che un film che brutalizza così il rapporto tra opera e pubblico venga strombazzato (peraltro quasi sempre in positivo) dalla stampa.
Se l’intero Joker è focalizzato sul trasmettere al pubblico perché (e per quali ragioni) Joker sia diventato un crudele e beffardo villain, prima ancora che un antagonista e nemesi di Batman (citato solo di striscio, almeno all’apparenza, giusto per non stravolgere completamente la narrazione), alla fine si tratta di un personaggio come molti ne potrebbero davvero esistere: solo, emarginato, incompreso, e secondo alcune analisi associabile ad un incel (neologismo del web per indicare gli involuntary celibate, ovvero i single involontari). Per quanto gli stereotipi e le classificazioni delle persone siano spesso spregevoli, soprattutto se la cosa nasce su internet, questa chiave di lettura è a mio avviso interessante, fermo restando che questo Joker è un film politico (senza essere anti-politico, il che non è poco) ed incentrato su uno dei migliori anti-eroi mai visti negli ultimi anni su uno schermo, in una sarcastica (quanto cupa) satira contro i mass-media, ed il cronico voyeurismo che li caratterizzerebbe.
Lo spettacolo non è un insieme di immagini, ma un rapporto sociale fra individui, mediato dalle immagini. […] Lo spettacolo, compreso nella sua totalità, è nello stesso tempo il risultato e il progetto del modo di produzione esistente. […] Esso è l’affermazione onnipresente della scelta già fatta nella produzione, e il suo conseguente. (G. Debord)
Il focus sulla frustrazione sessuale degli incel, incapaci loro malgrado di trovare un partner, e rifiutati ripetutamente per i motivi più diversi, sembra essere ben figurata dal Joker di Phillips – per quanto i riferimenti al sesso ed alla solitudine del personaggio sembrino riguardare più che altro la società dello spettacolo. Non che il personaggio sia arrabbiato, banalmente, solo perchè non faccia sesso – chi la pensa così, per inciso, non fa parte del pubblico a cui è rivolto il film – ma la sua corrispondenza parziale con la figura dell’incel, il “mostro“ sbattuto in prima pagina su social network come Reddit, è abbastanza palese. Lo dimostra il suo compiacersi di uno stato che non ama, il suo auto-commiserarsi che non è fine a se stesso, ma possiede un’evoluzione prevedibile quanto shockante per lo spettatore (la scena finale nello studio televisivo). L’accusa di romanticizzare la cultura incel e compiacersi di ciò che mostra, del resto, sembra in effetti infondata, frutto di analisi superficiali ed accostamenti mentula canis che minano alla base stessa del cinema di genere: esplicitare la violenza, per alcuni, sarebbe riprovevole – per via di una potenziale emulazione in negativo del pubblico, del quale evidentemente non si ha troppa stima. Ma se funzionasse davvero così, a ben vedere, tutti i film sull’emarginazione e la solitudine sarebbero nel libro nero dell’Inquisizione Truzza da decenni: e nessuno avrebbe mai visto Nekromantik (che estremizza la mancanza d’amore nella necrofilia) o magari Izo (che la contestualizza in una società da sempre marcia e, anche lì, pregna di un mix perverso tra amore, sesso e violenza). In una sequenza di uno dei capolavori di Miike, del resto, si afferma nichilisticamente: “Cos’è l’amore? È una parola. Una parola non è necessariamente associabile alla fondamentale natura del suo significato.”). Gli stessi incel del resto, secondo certa vulgata fascistoide, dovrebbero non solo redimersi e omologarsi, ma addirittura sentirsi responsabili del proprio status, e farsi appellare come sfigati cronici (ed è quantomeno bizzarro che questa osservazione sia intesa da alcuni come una rassicurante “soluzione” al problema).
Del resto se questo Joker è socialmente incazzato con il mondo, la sua rabbia dipende da molti altri fattori (infatti va da una psicologa) ed è progressiva: la vediamo sorgere e crescere a suon di soprusi subiti. È, insomma, generata dalla società, dalla famiglia e dalle circostanze: la madre solo apparentemente mite, la vicina di casa da cui è attratto senza volerlo riconoscere, il governo che taglia i fondi per la sua assistenza sociale, il lavoro che stenta, il sogno di fare il comico che si scontra con il gelo del pubblico (e con l’unica eccezione di Sophie). Del resto, il paradosso più feroce del film risiede proprio nell’ambizione del personaggio, sincera quanto sprovveduta, di voler far ridere, rendere felici le persone, mentre prova profonda frustrazione nel non riuscire a farlo.
Il tutto prosegue in un delirio di violenza indotta, con ulteriori soprusi del proprio capo – passando per i bulletti che lo malmenano e naturalmente i giovani rampanti di Wall Street che lo aggrediscono in metro (e che, guarda caso, poco prima di farlo, parlavano di donne, compiacendosi del proprio essere predatori). Certo quello di Joker non è un meccanismo narrativo nuovo o innovativo, e ai più smaliziati potrà quasi sembrare scontato: ma non c’è bisogno di scomodare Taxi Driver per capirlo, per intenderci, per quanto il regista sia stato il primo (forse un po’ furbescamente) a suggerirlo. Il capolavoro di Scorsese, in effetti, c’entra con Joker soltanto per sommi capi, mentre questo film mostra più che altro derivazioni ed influenze – a livello di regia e ambientazione – che citano, senza scomodare ulteriori paragoni fuori bersaglio (per non dire peggio), soprattutto Requiem for a dream: vedi la dipendenza cronica di madre e figlio dalla TV, e la rispettiva ambizione di parteciparvi come protagonisti, destinata anche lì a collassare in una spirale di morte e distruzione.
Con una differenza fondamentale: a differenza del finale devastante di Aronofsky, Joker mostra che è possibile (forse) ribellarsi alla propria condizione, reagire e sentirsi liberi, ma che l’unico modo per farlo sia quello di ricorrere alla violenza. Joker, in altri termini, non suggerisce banalmente alla “ggente” di incazzarsi a caso, reagire di pancia o vendicarsi su chi capita (come la versione cinematografica di V per vendetta aveva un po’ populisticamente fatto, ad esempio, e cosa che l’omonimo fumetto, per inciso, si guarda bene dal fare. Sarebbe anche il caso di citare, sempre di Alan Moore, Batman: The Killing Joke, che potrebbe avere punti di contatto con questo film a vari livelli). Joker, insomma, ricorre ad una violenza che è catartica, liberatrice, simbolo di un cambiamento radicale che è necessario imporsi, probabilmente sviluppando una giusta dose di libertà e cinismo. La prova della fondatezza di questa considerazione arriva da una sequenza importante: subito dopo aver ucciso i tre ragazzi in metropolitana, vediamo Joker entrare in casa della vicina e baciarla all’improvviso. La sua liberazione è a quel punto ufficiale, in un certo senso, e da lì partirà il processo che finirà per renderlo addirittura protagonista di uno show televisivo, in bilico tra un ego mite e mansueto ed uno crudele e spietato. Non sappiamo se quel bacio sia realmente accaduto o sia soltanto un sogno o un’allucinazione (tantissimo del film vive su questa ambigua doppiezza), ma il messaggio sottinteso è la presa di consapevolezza di un personaggio che ricorre, nei fatti, alla famigerata ultra-violenza (avrebbe abbastanza senso citare Arancia Meccanica, a questo punto) per uscire dal proprio disagio: questo in senso sia letterale che, direi soprattutto, figurato.
Il tutto nonostante le ambiguità del finale, che farebbero pensare ad una gigantesca allucinazione di un protagonista che era, in realtà fin dall’inizio, semplicemente un folle in un manicomio: un twist che, se fosse confermato, renderebbe lecito accostare le conclusioni a quelle de Il gabinetto del dottor Caligari. Una storia, in definitiva, molto semplice da raccontare, quanto necessaria a rendere un messaggio così complesso del tutto totalizzante e, almeno in parte, comprensibile al pubblico mainstream.
E questo, da cinefili incalliti o meno, non potrà che farci piacere.