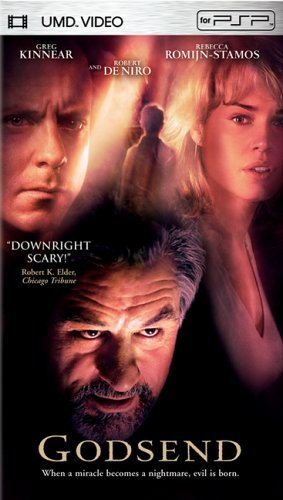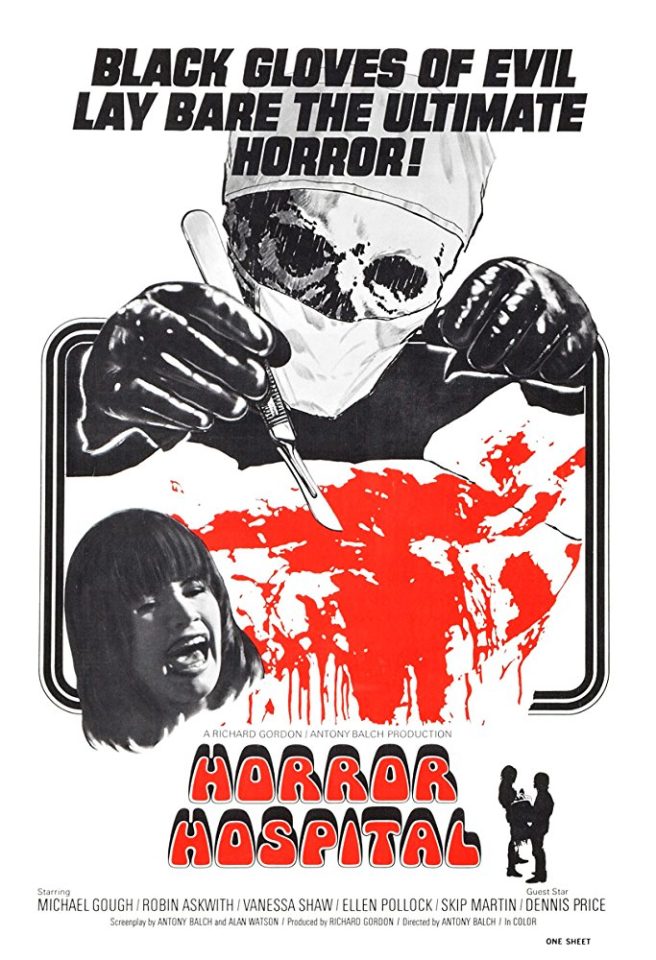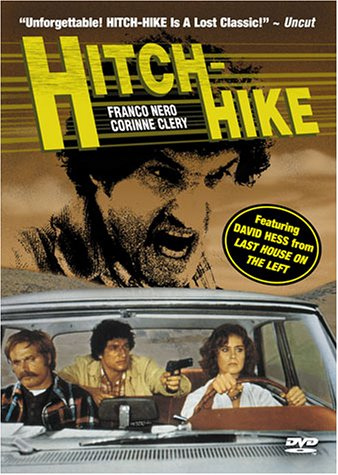Film insolitamente popolare, e questo nonostante la profondità auto-indulgente dei temi che lo caratterizzano: il tutto grazie al successo della sua versione teatrale, ma soprattutto per la componente piccante che lo accompagnò. Metti, una sera a cena evidenzia così un mood che sembra il manifesto della decadenza, in particolare di quella che all’epoca si chiamava – secondo una terminologia oggi desueta – borghesia.
Noto per essere stato l’esordio sia di Florinda Bolkan (che poi sublimerà la propria presenza in Indagine su di un cittadino al di sopra di ogni sospetto e, forse soprattutto, nel fulciano e mai abbastanza lodato Non si sevizia un paperino) che di Lino Capolicchio (La casa dalle finestre che ridono), il film divenne celebre per i dialoghi concettuali e speculativi che molti, probabilmente, hanno più finto di capire che apprezzare e saper discutere. Diretto nel 1969 da Giuseppe Patroni Griffi, venne da lui sceneggiato sulla base di un suo omonomico copione teatrale, in collaborazione con l’allora esordiente Dario Argento.
La scrittura del testo è drammaturgia elaborata e di concetto, che si basa su un’elaborata psicologia di fondo (o, alla peggio, una parvenza della stessa): un dramma concettuale improntato su cinque personaggi intorno ai quali si mostrano azioni (e soprattutto pensieri) rivolti all’ambito sentimentale e sessuale: da un classico menage a trois – fino ad un esacerbato ed ipotetico menage a cinq.
“Il tuo amore è sporca prapaganda”
Emerge in primis un complicato simbolismo figurativo, legato allo spettacolo teatrale di cui ricorsivamente Max fa parte per lavoro, il che si presta ad infinite elucubrazioni meta-filmiche, ma soprattutto per il dettaglio della bandiera nazista, con cui Ric si avvolge mentre dialoga con Nina. Si tratta forse di uno dei simboli più potenti e sottovalutati associati all’opera. È come se, in altri termini, l’unico coadiuvante erotico possibile (per quella borghesia pigra, viziosa ed avulsa all’amore sincero) fosse legata agli abusi, alla violenza, all’assolutismo. Simbolo reso ancora più esplicito dal fatto che si tratta della medesima bandiera con cui Ric, ad un certo punto, tenterà di suicidarsi. Si può certamente dire qualcosa in più del classico legame tra sesso & violenza: si può dire, ad esempio, che il sesso ha una valenza puntuale, risolve una noia di fondo dei personaggi e probabilmente smette, a momenti, di procurare piacere, essendo più un dovere da borghese che un sincerto impeto proletario (come dimenticare, a riguardo, Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto della recentemente scomparsa Lina Wertmuller?)
Anche l’idea classica che si tratti di “teatro borghese”, destinato ad un pubblico colto o per meglio dire presuntuoso, di fatto è smentita dalla pratica: proprio perchè il quadro che ne esce è, in fondo, tanto auto-indulgente quanto vanesio, inafferabile, difficile da formalizzare. Va specificato a chiare lettere che il film non possiede una forma narrativa troppo agevole: questo soprattutto per via del montaggio frammentato che lo rende, di fatto, sperimentale ad ogni latitudine. Molti, di fatto, lo troveranno pesante e difficile da cogliere in ogni sfumatura, soprattutto nel finale che è particolarmente criptico ed assume venature fataliste, probabilmente espressione di un senso di colpa radicato (Freud, Lacan, dove siete?). La lunghezza dell’opera in questo non aiuta, anzi da’ l’impressione di diluire e di non essere semanticamente indispensabile ma – come dire – il difetto più sostanziale dell’opera risiede proprio in questo.
Cinema “da intellettuali”. o presunti tali
Se è vero che la trama esibisce fin troppe forme di vezzi intellettualoidi e fumisterie assortite – ostentando una ricchezza di contenuto che non sempre trova riscontro nella sostanza – è altrettanto vero che il film funziona, specie se lo contestualizziamo in relazione all’era post-rivoluzionaria in cui uscì (1969). Funziona ancora oggi, a nostro avviso, in ottica provocatoria, un’ottica che un tempo avrebbero etichettato come piccolo-borghese, di un gruppo di persone edoniste, rigorosamente avulse dalla gelosia, che vivono le proprie relazioni come puro e semplice status sociale, senza neanche godersele. Anche se, in tutta onestà, quel finale speculativo e logorroico rischia di sembrare quasi inconcludente, perso tra allusioni più o meno esplicite a Platone, Omero e alla Cina dell’epoca.
Il montaggio del film venne realizzato da Franco Arcalli, noto per lo stile non lineare che aveva utilizzato anche in altri film (Il portiere di notte, Zabrieske Point, Ultimo tango a Parigi e Se sei vivo spara). Qui in effetti trova una sua collocazione ideale: non vediamo, infatti, la sequenza di eventi in modo coerente con la relazione causa-effetto: vediamo una sequenza di flashforward e flashback dai quali riusciamo a costruire la trama solo un pezzo per volta, per quanto il clou della storia appaia evidente a metà dell’opera.
Ric, che ha probabilmente avuto una relazione anche con Max in passato, si è innamorato di Nina, e questo sentimento terrorizza e fa istintivamente ritrarre la donna. Che non è sessuofoba come la protagonista di Repulsion (tutt’altro), ma sembra intimorita dalla sincerità dell’uomo, dalla purezza di quel sentimento, che non viene pero’ mai idealizzato ma anzi, addotto a causa di mera infelicità collettiva. Tanto che poi il passivo marito di lei, Michele, quasi per riparare quell’infiltrazione lacerante, finirà per ricorrere al blob conformista che conosce meglio: invitare a cena Ric, facendolo così diventare uno di “loro”.
Le musiche, indimenticabili ed altamente evocative, vennero firmate da Ennio Morricone.
Tra decadenza e astrattismo
Il rischio di un film del genere è quello di goderselo “per sentito dire”, perdendo di vista la logica comportamentale dei personaggi e la narrativa in ballo. Ma il punto probabilmente è proprio questo: alla base dell’opera vi sono vari concetti non ovvi (alcuni dei quali, francamente, sono più fumosi e salottieri che altro), derivati in parte dalla sociologia, dalla fanta-politica e dalla psicologia moderna – uno su tutti: accettare che i personaggi possano avere comportamenti illogici, perchè pensare il contrario è un retaggio tipico del pensiero retrò. Se accettiamo quest’ultimo assunto, il flusso narrativo diventa (forse) più agevole da decifrare.
Ric, Max, Nina, Michele e Giovanna sono del resto, in senso figurato, puri adepti del culto della decadenza, il che viene testimoniato da frasi significative come, ad esempio, l’unica salvezza sta nel vizio. Il loro agire non è tanto basato sulla logica o sull’istinto, ma serve a scuotere il pubblico in maniera indiretta, giocando su vari sottintesi e suggerendo, in qualche modo, che più di qualcuno possa specchiarsi in quegli intrighi di amanti e gelosie malcelate. Tutt’altro che reali visto che si tratta di un film sperimentale, eppure tutt’altro che irrealistici, date le storie di “corna” – come la vulgata spesso racconta ad ognuno di noi in modo un po’ becero – che conosciamo tutti più o meno per sentito dire.
La borghesia in cui si muovono i personaggi è mediocre quanto inebriata del proprio status, annebbiata da una visione nichilista sul matrimonio o, ad esempio, dal fatto che una madre non possa che essere madre single (da cui l’ossessione per l’idea, rivolta a Giovanna, di trovare un uomo che debba farle fare un figlio e poi scomparire). I personaggi sembrano comunque trascorrere più tempo a discutere che ad agire, e anche quando agiscono vediamo sempre il fatto compiuto: anche questa (oltre ad essere essenza del teatro moderno) è una cristalizzazione del pensiero in cui finzione e realtà, a momenti, finiscono per miscelarsi in una dimensione possibilista, perennemente erotizzata ed in tensione (per non dire meramente di facciata o ipocrita).
Addirittura l’erotismo di Metti, una sera a cena è pura e insopportabile formalità: deve esserci, ma la regia sembra aver fatto di tutto per renderlo simbolico e scarsamente stimolante, per quanto poi i nudi di alcuni personaggi siano affascinanti, oltre che causa non indifferente di successo della pellicola.
L’inutilità del mondo esterno
Se l’intreccio del film, di per sè, deve moltissimo alla rispettiva forma teatrale (ai suoi spazi ridotti ed alla sua ambientazione quasi sempre collocata in un appartamento angusto, quasi inospitale), risalta molto una sostanziale inutilità del mondo esterno. Questo tema emerge in maniera indiretta fin da subito, a cominciare dalla sequenza del trio che guarda un incontro di pugilato in modo distaccato, e se a qualche spettatore potrà sembrare puro snobismo, serve a focalizzare l’attenzione su una trama che funziona accettando la succitata cristallizzazione dei pensieri dei protagonisti.
Ai cinque personaggi della storia (Ric, Max, Nina, Michele e Giovanna) non serve altro: si nutrono di sè stessi, della propria capacità di maneggiare una sintassi elaborata quanto vuota, dei propri vezzi, delle rispettive attrazioni mal celate o mal espresse – conducendo nel contempo una vita pigra e orientata al pettegolezzo, alla passività e alla decadenza.
Cinque solitari che giocano ad accompagnarsi nella noia
I personaggi vivono un singolare status di solitudine sempre marcata e costante, poco cambia se si trovino in più di una tresca oppure, come Giovanna, siano tormentati ed irrigiditi dalla solitudine. Viene parzialmente in mente la figura de Il solitario di Ionesco, un romanzo breve del 1973 (dalla lettura, per inciso, abbastanza ostica) in cui il protagonista eredita una grossa somma da uno zio d’America, e decide così di ritirarsi a vita privata, abbandonando il lavoro dipendente. Il protagonista sembra proprio come il quintetto del film: scettico, disilluso, facile a stancarsi e stanco, uno che vive senza scopi, che lavora il meno possibile, e che trova rifugio nell’alcol e nel cibo, come i protagonisti che spesso vediamo a tavola, assimilati ad una ritualità puramente formale che, di fatto, espone i rispettivi vizi ed ipocrisie quotidiane.
Vediamo così la figura di Nina (Florinda Bolkan), che si reca a casa di Ric, una sorta di artista bohémien, il quale si esercita (e si sfoga) sparando con una pistola contro una figura ritratta sul muro. Ric è stato scritturato dall’amante di Nina, Max, per ravvivare un rapporto clandestino che la donna considera scarsamente stimolante. Formalmente, poi, continua ad essere la moglie di Michele, un autore teatrale che sta immaginando, guarda caso che non è un caso, di scrivere un’opera incentrata su una relazione a tre.
Al netto dei succitati (e ben noti) difetti, è da considerarsi un esperimento riuscito: lo è anche perchè i film derivati dal teatro sono raramente ben riusciti, e Metti, una sera a cena ha un peso specifico sostanziale e la propria importanza, per quanto recondita. Al tempo stesso è una forma seminale di cinema filosofico o speculativo a cui probabilmente molti autori, dal Von Trier di Melancholia e Dogville a Elio Petri, hanno finito per ispirarsi in un modo o nell’altro.