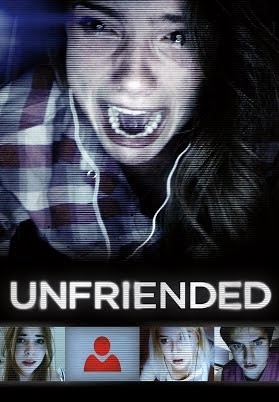Un ragazzino e una giovane donna si recano nel bosco, al fine di scavare una fossa che possa condurli direttamente all’inferno: l’idea è far vedere per l’ultima volta al giovane Nathan il suo cane, Maxine, morto qualche tempo prima. Antrum rappresenta il mockumentary in questione, risalente a fine anni 70, il quale esamina amabilmente, ancora una volta, la potenza orrorifica della narrazione realistica.
In breve. Mockumentary sulfureo e sinistro come pochi, costruisce un’atmosfera impagabilmente tesa, pur mostrando un impianto semplice e relativamente lineare. Cosa ancora più interessante, si muove su un duplice livello interpretativo (sovrannaturale vs. realistico).
Lanciato da una tagline fulminante e a suo modo geniale (“c’è un motivo per cui non hai mai visto Antrum: se l’avessi fatto, saresti morto“), Antrum (un mockumentary del 2018 della Else Films) prefigura l’idea stessa del film maledetto, la classica fissazione da cinefili incalliti, alla perenne ricerca di pseudo-snuff introvabili, inediti o tanto cruenti da essere messi al bando.
Scritto sapientemente dalla coppia di registi David Amito e Michael Laicini, Antrum ci introduce nella storia sfruttando un doppio livello narrativo: da un lato un horror low budget che racconta la storia di un ragazzino e della sorella a contatto con dei demoni, dall’altro dei ricercatori ed organizzatori di festival horror che ne riferiscono la minaccia per l’incolumità del pubblico. Se i presupposti sono sulla falsariga della strega di Blair, la sostanza cambia parecchio: Antrum è corposo, sostanziale e minaccioso, permeato come è da un’aura di tensione costante. Gli sguardi dei protagonisti, spesso persi nel vuoto e nell’indefinito, hanno un che di esoterico e “preoccupano” lo spettatore, che spesso non capisce realmente cosa stia succedendo. Un gioco di equilibri importante che rende l’opera a mio avviso superiore di qualità a quella dei numerosi film analoghi su questa falsariga.
Prima di passare alla parte sostanziale dell’intreccio, vediamo una breve premessa: essa è atta a raccontarci le cose orribili accadute a quasi tutti coloro che hanno visto – o si sono interessati al film, per poi passare ad un avviso con la più classica delle declinazioni di responsabilità. Lo aveva già fatto Wes Craven con L’ultima casa a sinistra, peraltro già allora accarezzando il mood degli snuff (gli horror reali o realistici che mostrerebbero vere morti, pubbliche esecuzioni e via dicendo) pur senza scomodare i formalismi legali che introduccono Antrum. A testimonianza di un linguaggio che, per evidente fame di iperrealismo, ha finito per adeguarsi ai tempi che corrono, anche a scopo di sembrare francamente esagerato. Un film tanto maledetto da essere un “assassino di pubblico” è un’idea perfetta per un horror memorabile, anche se non certo una novità assoluta, dato che è stata già sviscerata da piccoli capolavori quali The last horror movie, ad esempio, ma anche – qualche anno prima – da Cigarette Burns di John Carpenter (in cui si narrava della pellicola dannata “La Fin Absolute du Monde“, proiettato una sola volta e seguìto da un raptus omicida che aveva colto gran parte del pubblico).
Certo, non è un invito a continuare allegramente la visione ma, al tempo stesso, diventa un’operazione di accattivante narrativa degna del miglior scrittore horror.

A conferma di un certo gusto esotico da parte dei registi David Amito e Michael Laicini, i titoli di testa sono parzialmente in carattere cirillico, quasi a voler disorientare il pubblico, o magari impedirgli di effettuare ricerche “di sgamo” su Google durante la visione del film stesso. Tutto sembra iniziare a fine anni 80, quando il film è stato proiettato per la prima volta a Budapest, provocando l’incendio del cinema e 56 morti. In seguito, molti produttori e promoter di festival del cinema che lo avevano visionato avrebbero subito la stessa sorte, senza contare una sorta di delirio collettivo (la spiegazione in questo caso è razionale: il proprietario del cinema avrebbe inspiegabilmente sciolto pasticche di LSD nel burro per friggere i popcorn, circostanza che non può che richiamare Climax di Gaspar Noè).
Quando poi inizia il film vero e proprio – di cui abbiamo visto la cornice narrativa che ne fa da premessa – sembra di tuffarsi realmente nel cinema horror anni ’70: la grana della pellicola è consumata, sembra realmente un film di 30 o 40 anni fa ed è un espediente che richiama film underground come The last house on dead end street oppure, meglio ancora, il filone satanico dell’epoca che viene omaggiato, ad esempio, da The house of the devil. C’è anche da notare che, dopo aver visto il film per intero, possiamo considerare i demoni sia in senso letterale (e ciò rende Antrum un horror sovrannaturale di grandissimo livello) sia, volendo, in senso figurato (ed in questo caso abbiamo comunque visto un film che omaggia una tradizione exploitation simboleggiata dai due grotteschi cannibali e dai sacrifici umani che sono soliti perpetrare).
La narrazione è complessa ed è in realtà strutturata in vari strati, che dovrebbero corrispondere con i gironi infernali di dantesca memoria, che i due protagonisti scoprono scavando una fossa sempre più profonda. A quel punto, come in un spettacolo di teatro sperimentale (o come in Dogville di Lars Von Trier) la foresta diventa un non-luogo privo di dimensioni e riferimenti temporali, in cui non esistono muri separatori o non sembra succedere mai nulla – quando invece, nella realtà, si tratta di un universo parallelo popolato di non morti, demoni ed altre creature non identificabili.
Altri elementi della storia vivono di non sequitur, sono tutt’altro che ovvi oppure, ancora, probabilmente pregni di simbologia che i soliti fan, come spesso accade, potranno divertirsi a sviscerare o interpretare: ad esempio, quando nella foresta compare – un po’ dal nulla, apparentemente – un uomo dai tratti orientali, che sta per eseguire un suicidio rituale tipico dei samurai (un seppuku). Si gioca anche molto con le suggestioni, dato che molti personaggi sono ombre che si muovono nell’oscurità, e non sempre esiste un approfondimento in merito.
Che cos’è Antrum?
Seguendo la trama del film, “Antrum” è il nome di un presunto lungometraggio maledetto girato negli anni ’70, circostanza ovviamente inventata dai registi nonchè sulla falsariga della campagna viral che aveva lanciato il primo film sulla strega di Blair. Ma a differenza del cult dei primi anni duemila che, rivisto oggi, lascia poco più di una sensazione di camera traballante, in Antrum è tutto tremendamente ordinato, una sorta di caos calmo che non aspetta altro se non svelarsi in tutto il proprio orrore: nulla è casuale, dal cadavere inquadrato quasi accidentalmente alla comparsa di un demone in forma di scoiattolo.
Le urban legend che circondano questo lavoro – che non sono troppo difformi da quelle che, ad esempio, sono legate alle disgrazie avvenute a chi aveva lavorato al film The Omen – insistono ossessivamente sull’idea che si tratti di un film maledetto, e che chiunque abbia osato guardarlo sia destinato a morire (idea identica, peraltro, a quella della videocassetta della saga di The Ring).
Cosa sono i fotogrammi in bianco e nero che si intravedono in alcuni momenti del film?
Sempre nell’ambito delle leggende urbane resta da considerare l’inserimento di alcuni frame in bianco e nero che intervallano la visione del film: in uno, ad esempio, si intuisce la presenza di due persone che urlano mentre vengono torturate (a prima vista sembra che si trovino in una sorta di mattatoio), in un altro si vede il viso di un demone inespressivo, in primo piano, che muove gli occhi e sembra fissare il pubblico. Verso la fine del film, le due persone sembrano prima abbracciarsi, poi urlare esasperate forse in vista di una potenziale liberazione. In seguito, le vediamo sdraiate, e non vediamo mai il loro aguzzino (cosa che suggerisce possa trattarsi di uno snuff, cosa che pero’ sembrerebbe piuttosto scollegata con il resto della trama).
Frammenti di un altro film? Allucinazioni? Fino a qualche anno fa si discuteva della presenza di fotogrammi occulti o satanici all’interno di vari film Disney, da Bianca e Bernie a Chi ha incastrato Roger Rabbit, e che plausibilmente furono quasi tutti Easter egg (sorprese fuori contesto, collocate non ufficialmente dai creativi al lavoro sul film). Riportare questa dimensione in un horror è un’idea molto funzionale, così come inframezzarlo con quello che potrebbero essere (tiriamo ad indovinare, visto che non ci sono risposte definitive) frammenti di un film snuff, anime dannate presenti all’interno dei vari gironi o semplici allucinazioni che vivono i protagonisti durante il proprio viaggio.
Cosa c’è scritto nelle scritte che passano rapidamente in sovraimpressione?
Oltre ai frammenti in bianco e nero, vediamo anche delle scritte scorrere rapidamente. Alcune di esse sono al contrario (come in uno specchio), altre nel verso corretto, ma passano troppo rapidamente perchè si possa vedere qualcosa. In alcuni casi, vediamo un simbolo del pentacolo, verso la fine un triangolo rovesciato: il primo è il simbolo del demone Astaroth, mentre il triangolo è molto più ambivalente e sembra chiara la sua natura occulta di “evocatore”.
Si tratta di elementi che alimentano la suggestione del film, e dal carattere fortemente caratterizzante.
La storia di Nathan e Oralee
Nell’introduzione e nella conclusione del film vediamo riprese moderne, da documentario, che ci raccontano quello che dovremmo sapere sul film; si tratta di una sorta di meta-introduzione all’argomento. Nella storia vera e propria il registro visuale cambia del tutto e, da digitale, diventa quello di una pellicola da 35mm anni ’70. Un bambino rimane traumatizzato dalla morte del proprio cane, e la sorella (in seguito ai suoi frequenti incubi) decide di organizzargli una grottesca “gita all’inferno” per farglielo rivedere. Proprio questa disinvoltura di fondo, nonchè abile giustapposizione tra l’innocenza del piccolo Nathan e l’ambiguità della sorella Oralee, crea i presupposti per innalzare la tensione, soprattutto per l’ordinarietà con cui effettuano i rituali, con tanto di grimorio e di una conoscenza di quel mondo evidentemente regressa.
Cosa ancora più inquietante, non si riesce subito a capire – anche se poi col tempo forse lo intuiremo – se Oralee stia agendo con effettiva convinzione, per aiutare il fratello ad esorcizzare il trauma o, al limite, per entrambi i motivi. Dalla colonna sonora in stile Goblin, poi, emerge un riferimento ben preciso all’epoca d’oro del cinema di Bava, Fulci ed Argento, mentre una certa dissonanza psichedelica sembra implicitamente fare riferimento al mondo del satanismo e della demonologia.
Inquadrare il contesto di un film di genere, motivo per cui ho dovuto fare una infinita sfilza di premesse, è fondamentale per non banalizzarne l’atmosfera e godersene ogni singolo frame: perchè questo è uno di quegli horror che va dritto al cuore degli orrorofili più incalliti o disillusi, quelli convinti che gli horror di oggi non facciano più paura – cosa falsa, peraltro, perchè per fortuna – anche grazie agli emergenti servizi di streaming – le distribuzioni horror sono sempre più online e sempre più capillari.
Tutto questo, ovviamente, con tutte le rielaborazioni derivate dai precedenti dello stesso genere, che vanno da The Blair Witch Project a Cannibal Holocaust, passando per The war game, ovviamente in chiave satanica e con evidenti richiami ad un orrore che, in media, è più “di parola” che visuale. Una tradizione di falso-documentario che, anche in questo caso, ci tiene a rendersi credibile a ogni costo (e Antrum non fa eccezione), arrivando a “minacciare” virtualmente lo spettatore, pena che l’intero impianto risulti risibile.
Per questo, e per un finale apertissimo e sopra le righe, Antrum è promosso a pieni voti.
Spiegazione del finale
Merita qualche parola il finale, che in realtà è un doppio (se non un triplo) finale, aperto ad innumerevoli interpretazioni, per quanto basti vederlo per trovare la risposta ad almeno una parte degli interrogativi. Seguendo la falsariga dell’analisi di un film come Il gabinetto del dottor Caligari e, direi soprattutto, Omen Il presagio, ho deciso di trarre un po’ di considerazioni secondo me importanti. Bisogna secondo me partire da qualche minuto prima, per entrare correttamente nel mood di queste considerazioni.
Come nel capolavoro espressionista di Weine, secondo me ci sono almeno due livelli interpretativi: nel cult in questione c’erano una storia realmente accaduta, e poi i deliri immaginati da alcuni pazienti di un ospedale psichiatrico. Una cosa non esclude l’altra, questa è la cosa affascinante – ed è esattamente quello che succede in Antrum: Oralee sembra aver individuato un trauma che preoccupa il giovane fratello Nathan, e decide di applicare una sorta di “terapia d’urto” per fargli superare il dolore per la perdita del cane. Il viaggio, peraltro, è suggestivo e vorrebbe essere fonte di distrazione e svago per Nathan, ma le cose sembrano sfuggire di mano, istante dopo istante. Viene più volte il dubbio, in effetti, che il viaggio nell’aldilà infernale sia effettivo, e non semplicemente un gioco immaginato dai due protagonisti (il riferimento alla parola “gioco”, peraltro, è anche presente nello spiegone conclusivo). I due personaggi, peraltro, non sembrano poter più uscire dal bosco una volta entrati, dato che hanno preso una barca, poi hanno camminato a lungo verso casa – salvo ritrovarsi con orrore nel punto di partenza (situazione tipica di molti horror surrealisti e concettuali).
Per tutto il film vediamo un’escursione in un territorio che, a giudicare dal comportamento di Oralee, dovrebbe conoscere bene: questa confidenza col bosco, unita ad una sostanziale destrezza nel campeggio e l’essere l’adulta della situazione, potrebbe anche suggerire una certa familiarità ambigua con i rituali satanici e con l’evocazione di demoni, tant’è che siamo in un non-luogo e lei stessa ammetterà che il grimorio lo aveva scritto ed illustrato da sola. Sembra quasi che i protagonisti giochino con il mondo occulto – fin quando è possibile farlo in modo relativamente sicuro, nelle loro intenzioni – anche se poi la protagonista diventa molto lucida quando avverte un pericolo reale (i due cannibali che li catturano).
Nathan, dal canto suo, è un topos cinematografico ben noto: è infatti molto simile al pacato e sinistro Damien di The Omen, i suoi silenzi ed il suo guardarsi attorno sono quasi sovrapponibili e – soprattutto – poco prima della scritta The End lo vediamo sorridere alla camera, non sappiamo se rivolto alla sorella, agli spettatori, al proprio cane finalmente ritrovato o a qualche altra presenza oscura. Il finale del cult di Richard Donner era ambiguo, conteneva anch’esso un sorriso alla camera da parte del bambino e, probabilmente in modo incidentale, anche in quel caso era stato appena ucciso qualcuno con un colpo di pistola (l’ambasciatore nell’uno, il cannibale nell’altro). In entrambi i film, non abbiamo un’idea netta su chi sia davvero il bambino, se abbia natura umana o sovrannaturale e quali conseguenze ciò potrà avere.
Il sorriso alla camera sarebbero stato il finale aperto perfetto – ed io stesso ero convinto, sulle prime, che fosse finita lì. Ma c’è di più, perchè Antrum contiene un duplice finale: vediamo ora la fine della storia questa volta dal punto di vista di Oralee, mentre corre nel bosco per raggiungere il fratello. Si rende conto, quindi, di essere circondata da vari demoni mimetizzati tra gli alberi, probabilmente infastiditi dal mancato sacrificio avvenuto poco prima.
Non sembra esserci modo di scacciarli, tant’è che ha perso il cerchio magico che utilizzava per proteggersi (glielo hanno smantellato i due cannibali), e non le resta a questo punto che bruciare il grimorio. Questo non la preserva da una sorta di follia finale: si rintana nella tenda, in attesa dell’arrivo di Nathan. Non vediamo se lo sparerà o meno, ma sentiamo il colpo e poi finisce il film, questa volta sul serio. La necessità di un doppio finale, in effetti, sembra più dettata da un omaggio che ad altro (i doppi finali sono tipici del cinema horror classico a qualsiasi latitudine), anche se rimane suggestiva l’ipotesi che Nathan sia ormai controllato da uno dei demoni (a cui, a questo punto, avrebbe sorriso). Interessante anche pensare che si tratti di una sorta di extra che i registi stessi siano stati “spinti” a girare, in nome di un Male che tenderebbe nichilisticamente a sopraffarci (che è un po’ lo spirito con cui è stata girato, ad esempio, Morituris). È anche l’unica spiegazione al fatto che decida di compiere questo gesto, che stando alla stretta logica è inspiegabile mentre, nel vortice delle suggestioni di cui è avvolto il film, potrebbe avere più di una valenza.
Le considerazioni conclusive sono meta-filmiche ancora una volta, e svelano alcuni simbolismi usati nella pellicola. Non viene detto nulla, curiosamente, dei frammenti pseudo-snuff (forse per accattivare il pubblico), ma si conclude il cerchio con una serie di riflessioni incentrate sui simboli, su alcuni dettagli del film e sul potere della ritualità e della credenza, autentico motore in grado di suscitare le più disparate emozioni umane, incluse quelle mortali.