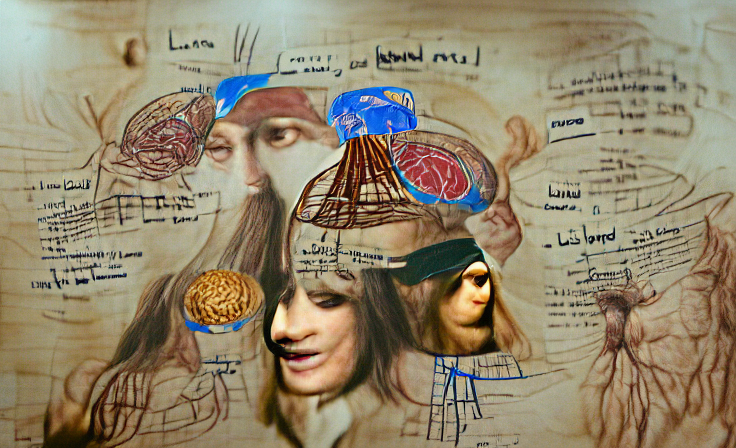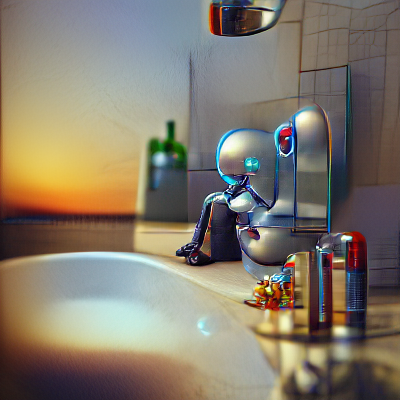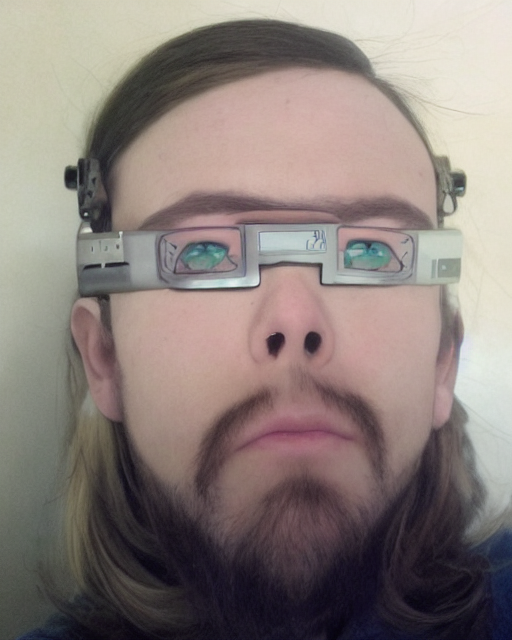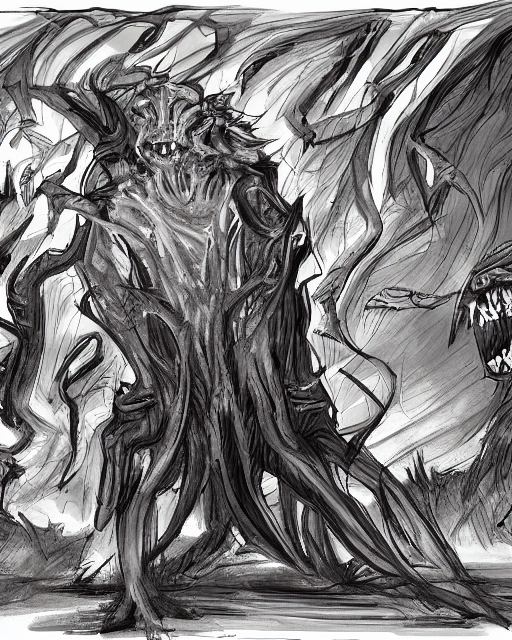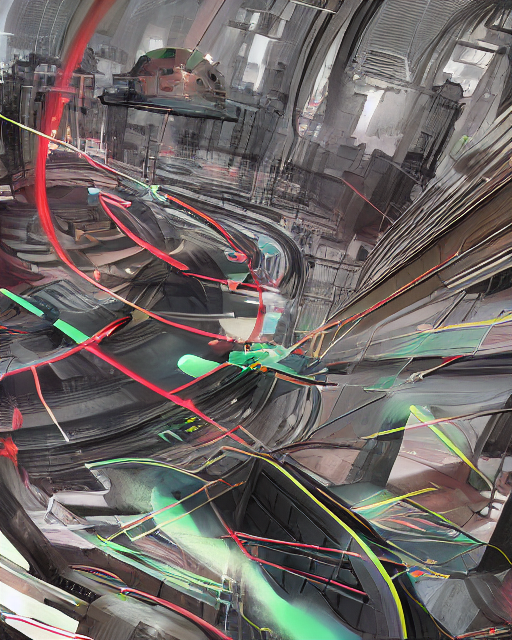Un serial killer si aggira per la città prendendosi gioco della polizia, disseminando indizi relativi alla Divina Commedia di Dante Alighieri. Il tutto sembra ricollegarsi ad un caso irrisolto di quindici anni prima: la giovane figlia di un noto drammaturgo che scompare nel nulla.
In breve. Un giallo anni 70 fuori tempo massimo (il film è del 2015), senza che ciò risulti stucchevole nè narcisistico. Archetipizzato su un modello di successo del passato (tra i film più noti c’è Profondo rosso), è tutt’altro che un mero esercizio di stile; al contrario, risulta accattivante per certe scelte fuori canone, sempre spiazzanti in positivo. Il retrò non disturba neanche il più accanito modernista: una vera e propria gemma del genere, per quanto destinata quasi esclusivamente a baviani o argentiani DOC. Da riscoprire.
Scritto e diretto da Luciano Onetti e in collaborazione con Nicolas Onetti (nei titoli di testi gli Onetti abbondano, ed è facile perdere il conto), Francesca è un thriller appartenente alla corrente del revival anni 70, in particolare il giallo-thriller archetipizzato da Tenebre, senza dimenticare la tradizione del genere che risale, per dovere di cronaca, a quasi venti anni prima, e vede come primo antesignano Sei donne per l’assassino di Mario Bava.
Di recente esperimenti analoghi sono stati realizzati, per intenderci, da film come Amer opppure (almeno in parte) The house of the devil: girati come si girava negli anni settanta, riproponendo visionarietà, personaggi, situazioni e stilemi tipici del genere – il più banale dei quali, presente in Francesca, è la onnipresente bottiglia di J&B, autentico sponsor non ufficiale dei film d’epoca.
Sorprende – in certa misura – come un film del genere sia stato poco considerato dalla critica e dal pubblico: Davinotti gli assegna 2 stelle su 5, IMDB non arriva nemmeno alla sufficenza (poco meno di 6, al momento in cui scrivo), in tanti hanno un po’ snobbato la sua uscita (il film è disponibile su Prime Video, per la cronaca). Certo è che Francesca assume un ruolo tanto preciso da assurgere a genere a sè stante, tanto è significativo, coinvolgente ed impregnato di cinema di vecchia scuola, senza risultare troppo derivativo ed introducendo elementi di originalità non da poco. Onetti ha stile ma possiede anche quella personalità registica che gli consente, a ben vedere, di produrre un film del tutto autonomo, che sembra quasi un inedito del periodo riesumato per l’occasione. Il che non potrà che provocare il tripudio degli amanti di Dario Argento e Mario Bava, per quanto la perplessità lecita di questi revival afferisca al perchè sia stato fatto così e non, ad esempio, ambientato in tempi moderni (risposte brevi che mi viene in mente: perchè gli eccessi tecnologici di oggi risulterebbero banalizzanti nel risolvere certe situazioni, e perchè l’immaginario anni 70 resta inarrivabile).
Sono trascorsi quindici anni dalla scomparsa di Francesca, figlia di un noto drammaturgo italiano: Vittorio Visconti, ridotto su una sedia a rotelle a causa dell’aggressione che ha portato al dramma familiare in questione. Nel frattempo, la moglie è caduta in depressione per la perdita dell’amata ragazza, e non sembra volersi più muovere dal letto. Un serial killer agisce per la città bersagliando varie vittime e mostrando un singolare filo conduttore negli omicidi: uccide quasi sempre con un punteruolo e poi, come firma del delitto (come tradizione pagana è solita raccontare) pone due monete sugli occhi della vittima. Ben presto la polizia scoprirà un legame con la storia misteriosa di cui sopra, svelando una verità sorprendente. Una verità conclusiva che possiede come autentica ispirazione – e si badi allo spoiler ineluttabile, per una volta – più di qualcosa della filosofia di fondo di film poco citati in questo ambito, e che a mio avviso restano primari: parlo di Vestito per uccidere e di Sleepaway Camp, anche per via della sessualità repressa di cui la killer è evidentemente imbevuto.
Non che il film sia un esercizio di stile da scuola del cinema, peraltro: Francesca propone qualche variazione sul tema considerevole, ad esempio l’identità del killer – che sembra banale, ma in realtà non lo è; il doppio finale alla Dario Argento (anche questa volta c’è di mezzo l’amore verso i figli spinto all’estremo), l’omicidio a sorpresa dopo i titoli di coda, il che vìola la regola generale che il climax di questi film debba essere continuo, o che almeno il finale sia tranquillizzante o stabilizzante. Di fatto, anche quell’inserto post titoli di coda da alcuni criticato, è meno gratuito di quello che potrebbe sembrare, dato che predilige la continuità del Male su quella narrativa, un po’ sulla falsariga del primo Halloween di John Carpenter.
Ed è proprio a certi vecchi, epici ed immarcescibili archetipi di thriller all’italiana e non solo (citiamo a campione, non potendo fare altrimenti: Profondo rosso, Tenebre, Shock, A Venezia un dicembre rosso shocking, Chi l’ha vista morire); modelli assimilati, visti, annotati e rielaborati dalla regia, a livello sia narrativo che di stile visuale. Ed il risultato, per il suo sotto-genere, rasenta il capolavoro. Non mancano nemmeno le musiche alla Goblin, composte dal regista stesso in totale mood carpenteriano (regia e musiche affidati alla stessa persona). Non mancano poi i traumi infantili irrisolti, i personaggi dal passato non raccontabile, la presenza del personaggio poliziesco che viene un po’ per volta ridimensionato, sopraffatto dalla banalità del male e, anche qui, contravvenendo alla regola non scritta per cui, in questi film, anche se il bene non vince sempre, quantomeno alla fine spiega come sono andate le cose. In Francesca non esiste alcun finale falsamente consolatorio, e al contrario si rincorre un effetto di shock sullo spettatore che esibisce un feroce irrazionalismo.
La regia di Onetti è infaticabilmente settantiana, quasi da sembrare ossessivo-compulsiva nel senso buono del termine, tanto è ricca di allusioni allucinatorie, primi piani su guanti, occhi, mani, pori della pelle, attizzatoi, magnetofoni e pianoforti: il regista cura la direzione della fotografia ed è pesantemente influenzato dall’estetica argentiana esaltata da Profondo rosso, primariamente. Il vero difetto di Francesca, a ben vedere, potrebbe forse essere ricondotto ad una eccessiva referenzialità, per quanto la presenza di elementi narrativi originali, fuori canone anche per l’epoca, eviti almeno in parte accuse di questo tipo. Per convincersene basterebbe pensare al serial killer dall’identità sessualmente ambigua, che si vede quasi da subito chiaramente (e che poi non è chi sembra), che si ispira all’Inferno dantesco (il canto terzo, per la precisione: quello che narra delle porte dell’inferno), possiede un passato oscuro ed esprime una marcata sessualità repressa. Senza contare la maestria registica, al limite del talentuoso, con cui i suoi delitti sono mostrati, con qualche eccesso violento e insistito ma sempre con un sostanziale equilibrio. Oggetti di casa quali l’attizzatoio ed il ferro da stiro diventano feroci armi del delitto, in una spaventosa rilettura d’epoca dai colori psichedelici, tanto accesi da sembrare incandescenti.
Mamma, ho voglia di giocare con te. Mamma, ho voglia di giocare con te. Mamma, ho voglia di giocare con te…
In Francesca il flusso di coscienza guida una sceneggiatura dai tratti chiari e sempre distinguibili, che non si fa fatica a seguire e che raccontano di una killer, almeno in apparenza, dall’aria avvenente, di cui intravediamo anche le fantasie sessuali e che sembra essere l’incarnazione sadica di una ragazzina scomparsa: ragazzina che non esita, nella prima sequenza, a martoriare la carcassa di un uccellino, per poi trapassare – in una traumatizzante sequenza iniziale – l’occhio del fratellino ancora in fasce. L’occhio sarà anche, in successive sequenze del film, la parafilia primaria o ossessione prediletta del killer, e rappresenta molto più di quanto una visione superficiale possa suggerire.
La killer in cappotto rosso, gonna nera e guanti in pelle sembra essere guidata da intenti moralistici, ed in questo potrebbe ricordare l’archetipo argentiano ben noto che poi, a ben vedere, quasi mai era ciò che l’apparenza poteva suggerire. In questo caso, per inciso, non si fa eccezione: il finale di Francesca sorprende quanto i migliori lavori argentiani, sia per come viene costruito e fuorvìa anche lo spettatore con più esperienza, sia per la violazione di una ulteriore convenzionale regola non scritta: l’ultimo omicidio e rivelazione avviene quando l’ispettore chiede spiegazioni, ed è la narrazione a rendere esplicito cosa sia realmente successo. Glii echi familiari perversi dovuti ad un’educazione repressiva sono più che evidenti, in un vero e proprio rehash della narrazione che ha reso Profondo rosso famoso in tutto il mondo, film da cui si ereditano le parafilie, le ossessioni e le immagini in primo piano: quella di un bambolotto prima impiccato a un albero e poi cullato dentro a una carrozzina, a testimoniare la natura sadica di una piccola killer fin dall’età adolescenziale.
Come nota finale, il film è una produzione italo-argentina recitata in italiano, per cui non è stato proposto un doppiaggio: gli attori sono caratterizzati da una curiosa inflessione italo-argentina.