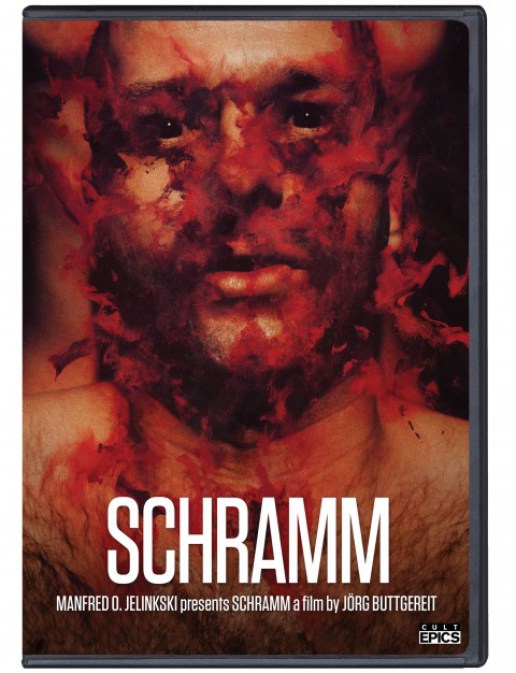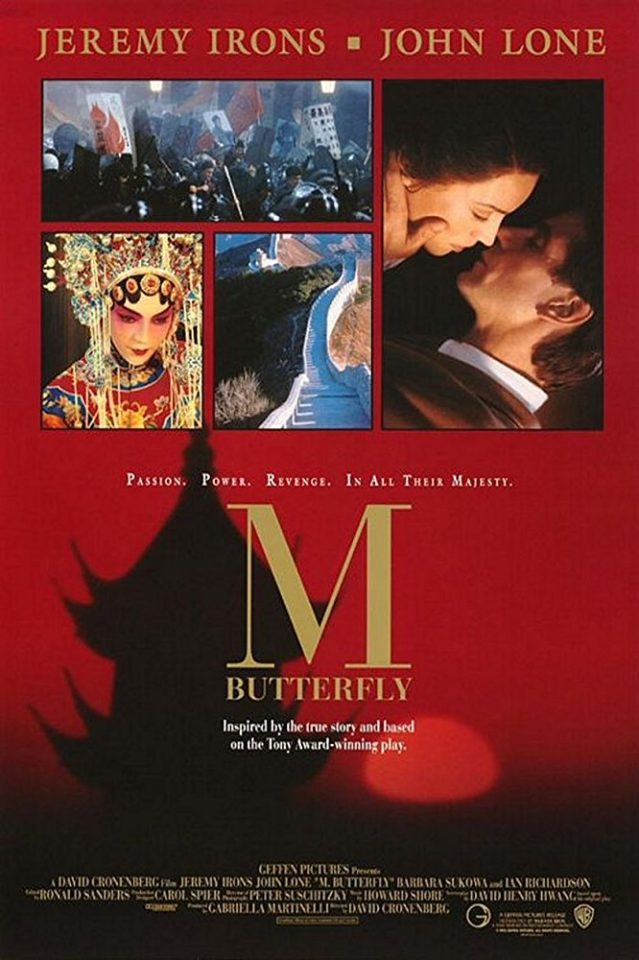Sinossi “Il filo nascosto”
Il filo nascosto” (titolo originale: “Phantom Thread”) è un film del 2017 diretto dal regista Paul Thomas Anderson, noto anche per aver diretto film come “Magnolia” e “There Will Be Blood”. “Il filo nascosto” è ambientato nella Londra degli anni ’50 ed è incentrato sulla vita di Reynolds Woodcock, un famoso stilista di moda interpretato da Daniel Day-Lewis, il quale veste l’alta società britannica. La sua vita cambia quando incontra Alma, interpretata da Vicky Krieps, una giovane donna che diventa la sua musa e amante. Il film affronta temi come l’amore, l’ossessione, la creatività e i compromessi nella relazione tra Reynolds e Alma. La trama è intricata e il film è noto per la sua raffinata fotografia, la recitazione di Daniel Day-Lewis e la colonna sonora evocativa composta da Jonny Greenwood.
Il film è diventato di culto e ha ricevuto elogi dalla critica per la sua maestria tecnica e le prestazioni degli attori. Daniel Day-Lewis è stato particolarmente lodato per la sua interpretazione e ha vinto l’Oscar come Miglior Attore Protagonista per il suo ruolo nel film.
Ho una strana inquietudine. Ma non riesco a darne un motivo specifico. Come un battito d’ali. (Reynolds)
Cast Il filo nascosto
Ecco il cast principale del film “Il filo nascosto” (Phantom Thread):
- Daniel Day-Lewis nel ruolo di Reynolds Woodcock
- Vicky Krieps nel ruolo di Alma Elson
- Lesley Manville nel ruolo di Cyril Woodcock
- Camilla Rutherford nel ruolo di Johanna
- Gina McKee nel ruolo di Contessa Henrietta Harding
- Brian Gleeson nel ruolo di Dr. Robert Hardy
- Harriet Sansom Harris nel ruolo di Barbara Rose
- Lujza Richter nel ruolo di Princesse Mona Braganza
- Julia Davis nel ruolo di Lady Baltimore
- Nicholas Mander nel ruolo di Lord Baltimore
Interpretazione del film
“Il filo nascosto” è un film che offre molteplici interpretazioni e spunti di riflessione anche a livello filosofico, ne abbiamo trovate parecchie e adesso proveremo ad elencarle con voi. La natura umana e i desideri nascosti: Il film esplora la complessità della natura umana e dei desideri che spesso rimangono nascosti e repressi. I personaggi di Reynolds e Alma mostrano il conflitto interiore tra l’immagine esteriore che proiettano nella società e i loro veri desideri interiori. Il ruolo dell’arte e della creatività: Reynolds Woodcock è un artista, uno stilista di fama mondiale, che esprime la sua creatività attraverso i suoi abiti. La sua dedizione all’arte e alla perfezione rappresenta un tema centrale del film, sollevando domande sulla relazione tra l’artista e la sua arte, e sulla natura dell’ispirazione e della passione creative. Il potere nelle relazioni umane: La dinamica tra Reynolds e Alma illustra le dinamiche di potere all’interno di una relazione. Ciascuno dei personaggi cerca di controllare l’altro, ma in modi diversi. Questo solleva interrogativi sulla libertà individuale, la manipolazione e la vera essenza dell’amore.
Ci sono infinite superstizioni quando si tratta un abito da sposa. Le giovani che non lo toccano per paura di non sposarsi. Le modelle che hanno paura di sposarsi solo uomini calvi se ne indossano uno… (Reynolds)
Identità e trasformazione: Il film esplora anche temi di identità e trasformazione personale. I personaggi principali subiscono cambiamenti significativi nel corso della storia, e ciò solleva questioni sulla fluidità dell’identità e sull’accettazione del cambiamento nella vita umana. La fragilità dell’amore: Il film offre una rappresentazione complessa dell’amore e delle relazioni umane. Mostra come l’amore possa essere imprevedibile, fragile e talvolta difficile da comprendere. Ciò apre spazi per considerare la natura dell’amore e la sua stabilità o insicurezza. Estetica e bellezza: La bellezza e l’estetica rivestono un ruolo centrale nel film. I personaggi sono costantemente coinvolti nella creazione di oggetti di bellezza, come gli abiti di Reynolds. Questo solleva domande sulla natura della bellezza, i suoi significati soggettivi e culturali, e il suo ruolo nella vita umana.
10 cose che non sapevi su Il filo nascosto
- Ritiro di Daniel Day-Lewis: Dopo aver interpretato Reynolds Woodcock, Daniel Day-Lewis ha annunciato che “Il filo nascosto” sarebbe stato il suo ultimo film prima del ritiro dalla recitazione. Quindi, questo film segna la sua ultima apparizione sul grande schermo.
- Ruolo scritto appositamente: Il regista Paul Thomas Anderson ha scritto la sceneggiatura pensando esclusivamente a Daniel Day-Lewis per il ruolo di Reynolds Woodcock.
- Nomination agli Oscar: “Il filo nascosto” ha ricevuto sei nomination agli Oscar, tra cui Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Attrice Protagonista per Vicky Krieps.
- Colonna sonora di Jonny Greenwood: La colonna sonora del film è stata composta da Jonny Greenwood, chitarrista del gruppo musicale Radiohead, che ha lavorato anche con Paul Thomas Anderson in precedenza.
- Fotografia con pellicola: Il film è stato girato interamente utilizzando pellicola 35mm, anziché le moderne tecnologie digitali, per ottenere un aspetto visivo specifico e un’atmosfera vintage.
- Ispirazione dalla vita reale: Paul Thomas Anderson si è ispirato al celebre stilista spagnolo Cristóbal Balenciaga e alla sua dedizione per il suo lavoro, nonché ai designer britannici del periodo degli anni ’50.
- Accuratezza storica: Per creare gli abiti del film, la costumista Mark Bridges ha effettivamente usato vecchi modelli e tessuti autentici dell’epoca, cercando di mantenere la massima precisione storica nei dettagli degli abiti indossati dai personaggi.
- Set in casa: Gran parte del film è stata girata in una casa georgiana a Fitzroy Square a Londra, che è stata appositamente restaurata e arredata per ricreare l’atmosfera degli anni ’50.
- Finali multipli: Originariamente, il film avrebbe dovuto avere un finale diverso, ma il regista e gli attori hanno deciso di girare un’ulteriore scena finale per aggiungere un elemento di sorpresa alla storia.
- Curiosità sull’anello: Nel film, Reynolds Woodcock regala ad Alma un anello con un grande diamante. Quell’anello era in realtà una creazione del regista Paul Thomas Anderson e non un oggetto di scena standard. Daniel Day-Lewis ha ammesso che il valore dell’anello era così alto che l’ha tenuto in cassaforte ogni notte durante le riprese.
Per prepararsi al film, Daniel Day-Lewis ha guardato filmati d’archivio di sfilate di moda degli anni ’40 e ’50, ha studiato stilisti famosi, si è consultato con il curatore della moda e dei tessuti del Victoria and Albert Museum di Londra e ha fatto un apprendistato con Marc Happel, capo del reparto costumi del New York City Ballet. Ha anche imparato a cucire e si è esercitato su sua moglie Rebecca Miller, cercando di ricreare un tubino di Balenciaga ispirato a un’uniforme scolastica.
Spiegazione del finale Il filo nascosto
Il finale di “Il filo nascosto” è intenzionalmente aperto e ambiguo, lasciando agli spettatori il compito di trarre le proprie conclusioni sulla natura della relazione tra i personaggi e il significato delle loro azioni. Il regista Paul Thomas Anderson ha voluto creare uno spazio per la riflessione e l’interpretazione individuale, lasciando che il pubblico decida come interpretare la complessa dinamica tra Alma e Reynolds.
Attenzione: Spoiler a seguire per chi non ha visto il film.
Nel finale, Alma, la giovane amante di Reynolds Woodcock, decide di assumere un approccio radicale per risolvere i problemi nella loro relazione. Essendo stufa della dominanza di Reynolds e dei suoi atteggiamenti controllanti, Alma decide di avvelenarlo sottilmente con dei funghi che ella stessa ha raccolto, portandolo in uno stato di debolezza e dipendenza da lei. La scena finale mostra Alma e Reynolds seduti insieme a fare colazione. Mentre Reynolds mangia, sembra debole e vulnerabile, accettando passivamente la situazione. La luce si spegne su di loro mentre Reynolds continua a mangiare.
La spiegazione di questo finale può essere interpretata in diversi modi:
- Controllo ribaltato: Alma ha preso il controllo della situazione e della relazione con Reynolds. Potrebbe essere una forma di vendetta per come lui l’ha controllata in passato. Questo finale suggerisce che il potere nella relazione si è ribaltato, con Alma che ora detiene il controllo.
- Simbiosi e dipendenza: Alma e Reynolds sembrano intrappolati in una sorta di simbiosi tossica. Entrambi sembrano dipendere l’uno dall’altro, nonostante la loro relazione sia disfunzionale. Il finale può rappresentare la perpetuazione di questo ciclo di dipendenza.
- Amore e complicità nella follia: Il finale potrebbe suggerire che Alma e Reynolds, pur essendo coinvolti in un comportamento strano e talvolta dannoso, trovano una forma di amore e complicità nella loro stranezza e follia condivise.
- La natura dell’arte e dell’ispirazione: Il finale può essere interpretato anche come una metafora sulla natura dell’arte e dell’ispirazione. Reynolds potrebbe essere rappresentato come un artista che trae ispirazione dalle situazioni estreme e dalle emozioni forti, e la sua relazione con Alma è la sua fonte di ispirazione creativa.