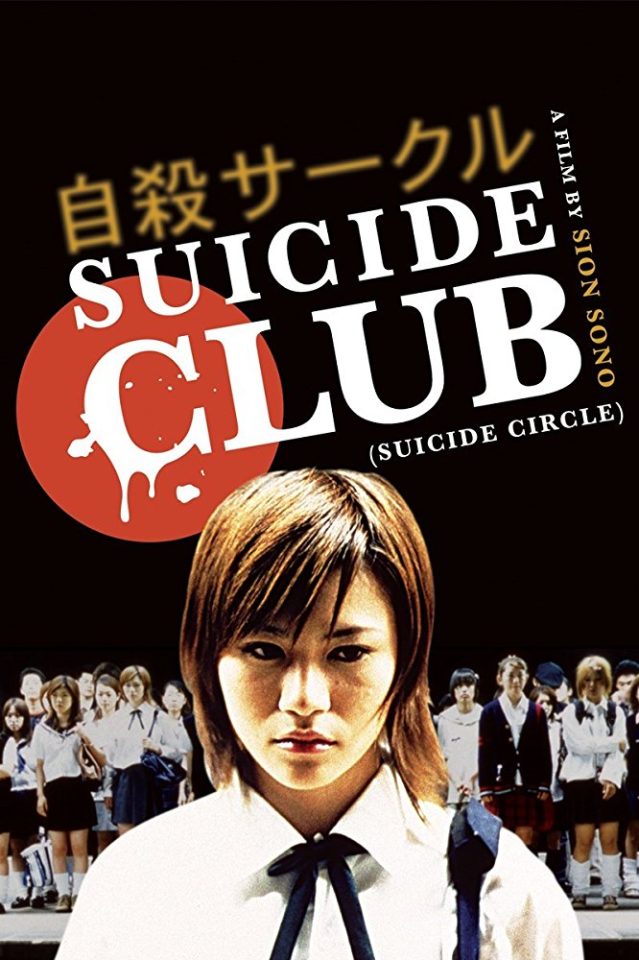Tre uomini e l’amante di uno di loro si ritrovano in una villa sperduta per una battuta di caccia: la donna, bellissima quanto frivola, attira le loro attenzioni facendo degenerare la situazione.
In breve. Eccessivo e violento, si incentra sulla martirizzazione di un corpo femminile che sembra nato per l’eros: in questo, la Fargeat compie una nobile operazione anti-maschilista, filmando un’opera autenticamente sovversiva, che farà parlare di sè per buone ragioni. Per altri versi, pero’, il film non regge, e non è credibile come dovrebbe sembrare.
Nell’intero suo concepimento, e per come finisce per presentarsi al grande pubblico, questo Revenge sembrerebbe avere le carte in regola per essere considerato un film di livello: del resto, già solo l’inquadratura insistita e dettagliata che lo caratterizza (l’enorme deserto nella zona del Grand Canyon) è un biglietto da visita fin troppo eloquente.
Sono anche chiari i modelli di riferimento che sono stati sviluppati: Wes Craven (che sembra quasi ovvio, ma non era banale riprendere certi temi oggi), ma anche Lucio Fulci per alcune sequenze splatter (gli occhi trafitti da una lama, il cadavere che riemerge dall’acqua).
L’insieme di dettagli che caratterizza Revenge finisce, però, per risultare vagamente sconnesso, soprattutto per il suo insistere sulla quantità di sangue finto – che, a quanto pare, fu largamente sottostimato in termini di litri necessari. C’è tanto plasma sgorgante in Revenge, insomma, che nemmeno in uno splatter puro: questo per molti è diventato un pretesto per far notare quanto rischiasse di essere poco verosimile. Da un lato personaggi che non muoiono (pur “avendo il dovere” di farlo), e soprattutto (a mio parere) la circostanza di sopravvivenza della protagonista si prefigura, forse, come la meno realistica in assoluto. Ed è proprio da qui che si diparte il clou della trama, ed è questo che mi ha convinto meno di qualsiasi altra cosa.
Coralie Fargeat è la regista (esordiente) alle prese con il modello del rape’n revenge, ad oggi considerato antisociale a priori da gran parte della critica e del pubblico; ma qui siamo di fronte alla classica eccezione che smentisce il trend. Una regista donna che gira, con la piena consapevolezza dei propri mezzi tecnici ed espressivi, un film contro la mercificazione dell’immagine femminile, dando un ampio saggio della bellezza, innegabile, del corpo di Matilda Lutz per poi capovolgere l’assunto e renderlo selvaggio, irrazionale e violento. Se nulla, poi, in Revenge sembra casuale o “buttato lì”, troppo spesso la trama finisce per scontrarsi con la logica, distrando così dagli intenti più nobili, e anche solo dal semplice godersi il film. D’accordo che poi, in ambito exploitation, è consuetudine effettuare degli “azzardi” poco coerenti come sviluppo narrativo; non bisognerebbe nemmeno dimenticare che Revenge è sostanzialmente un b-movie – per quanto girato “alla Tarantino” (ovvero facendo elegantemente finta di avere pochi mezzi). Per cui la critica più razionale, per quanto lecita, finisce per doversi attenuare, un po’ per forza di cose un po’ perchè il film è impostato così.
Non c’è dubbio, comunque, che il film funzioni da molti altri punti di vista: la scelta dei personaggi è azzeccata, a cominciare dall’inaspettata protagonista (prima frivola e incosciente, poi determinata e feroce) a finire alle tre figure maschili, tre declinazioni di “orchi” molto diversi tra loro, sia per spessore che per potenzialità.
La regista sembra aver voluto creare un sano exploitation incentrato sugli stereotipi del genere, giocando sui consueti contraccolpi a sorpresa, e regalando al pubblico momenti violentissimi quanto frustranti (o liberatori) all’interno della trama. Del resto, chiunque abbia visto La casa sperduta nel parco, ad esempio, non dovrebbe avere difficoltà a riconoscere il modello che è stato seguito: i presupposti sono quasi identici – per quanto ci fosse forse maggiore credibilità nel lavoro di Deodato.
L’unico modo per visionare Revenge senza farsi trascinare da una critica inutilmente feroce, che il film a conti fatti non sembra meritare del tutto, è quello di farsi avvolgere dal clima puramente ottantiano che lo caratterizza, divertendosi anche a cogliere le citazioni cosparse nella pellicola (The descent, Rambo). Revenge sarebbe forse potuto essere qualcosa di meglio, essenzializzando e rinunciando a simbolismi suggestivi quanto improbabili: l’insistere sulle tracce di sangue nel rapporto predatore-preda, soprattutto, che farà venire ai più sarcastici spettatori la voglia di fare un esposto all’Avis per tutto il plasma sprecato. E soprattutto: mai chiedersi – nel modo più assoluto, direi – come sia possibile che i personaggi sopravvivano e riescano a maneggiare armi quasi completamente dissanguati. Questo è un b-movie puro, nel bene e nel male – e finchè morte non ci separi.
Menzione particolare per la scelta delle musiche, infine, ispirate ai lavori – tra gli altri – di John Carpenter.